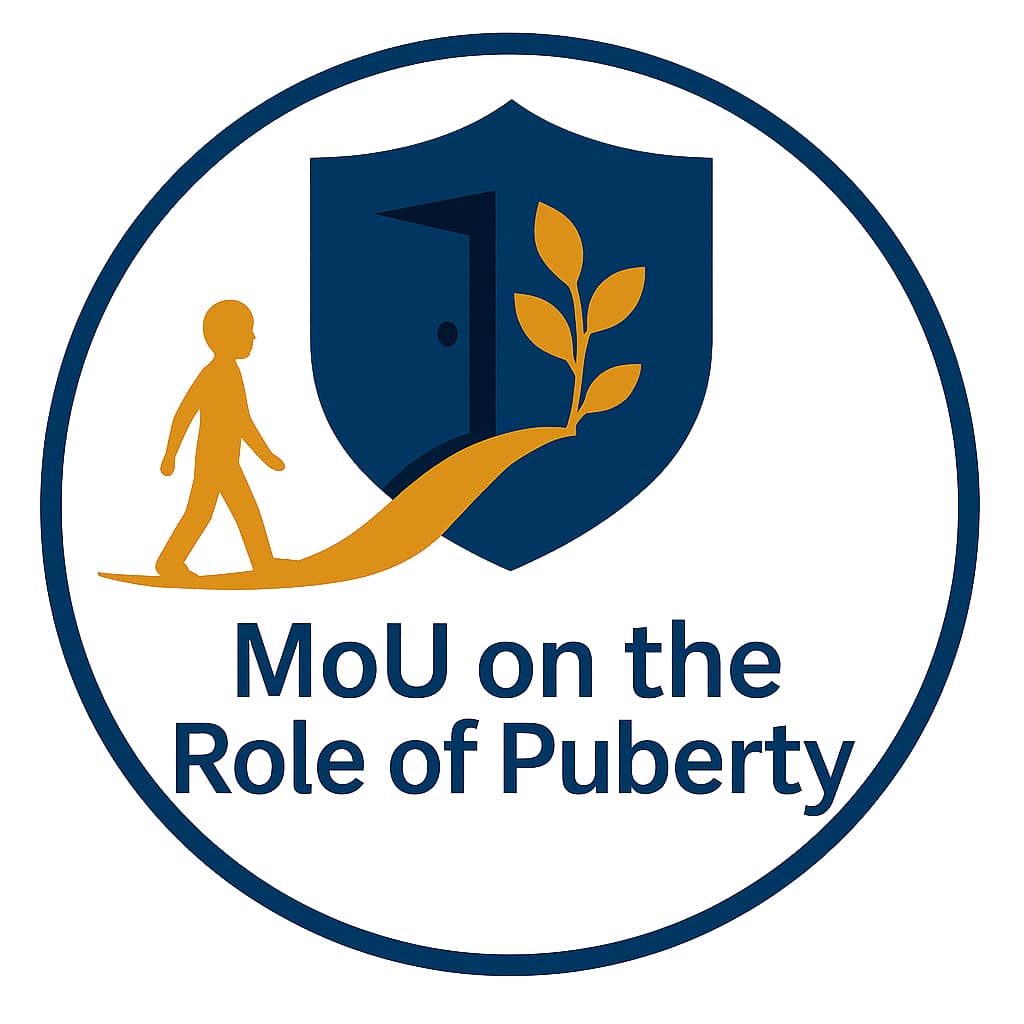Circa due mesi fa, nel giorno della Festa del Papà, a Bologna sono stati affissi dei manifesti per iniziativa dell’Associazione Genitori Sottratti “Roberto Castelli” e della Lega Uomini Vittime di Violenza). Manifesti che denunciavano la violenza della quale possono essere vittime gli uomini in generale e i padri in particolare. Immediatamente diversi esponenti delle istituzioni cittadine e diverse associazioni femministe hanno protestato, affermando che è stato un errore non impedirla e, dopo qualche giorno, sono stati brutalmente vandalizzati, con scritte pacifiche e inclusive come “uomo morto non uccide”. Una esponente di un’associazione femminista si era particolarmente contraddistinta nei social per i toni violentissimi contro gli stessi manifesti, fino a pubblicare sul web delle foto in cui orgogliosamente si mostrava in posa accanto ai manifesti deturpati. Tanta solerzia ci ha spinto a cercare qualche informazione su questa paladina del libero pensiero e dei diritti umani: quello che abbiamo trovato ha pienamente appagato i nostri sforzi.
Trattasi di una sorta di versione economica (o di “concorrenza”, come si diceva una volta) di Rula Jebreal, perché come diceva Elémire Zolla «gli italiani hanno un particolare talento a nutrirsi dei rifiuti altrui». Si tratta di tale Marina Misaghi Nejad, attivista femminista e soggetto “antitutto” (così lei stessa si definisce), vicina a diverse associazioni femministe nazionali tipo “Non una di Meno” e alle istituzioni della stessa città di Bologna. L’armamentario ideologico e la fraseologia sono quelle tipiche del femminismo: “maschi assassini”, “lotta contro il patriarcato”, “spacco tutto”, eccetera. Spettacolare la sua auto-descrizione su Linkedin, dove dice di occuparsi, tra l’altro, di “il transfemminismo decoloniale” (!!!). Tipica è anche la coerenza tra teoria e prassi, che nel femminismo si traduce sempre in manifesti surreali, qualche smutandata o in atti vandalici coperti dalla certezza dell’impunità. Tutto nella norma, insomma e infatti non è tanto questo che ci interessa del personaggio in questione.

Fiera di non sapere.
«Tra cinque anni», ha dichiarato, «voglio vedermi più radicale di oggi. Mi immagino (o meglio mi sogno!) in una società senza lavoro, finalmente libera di dedicarmi alle uniche due cose che davvero mi appassionano: i libri e le piante. Niente più scocciature capitaliste! Ma, realisticamente, sarò ancora qui, più arrabbiata di prima, a fare il lavoro che comunque amo, circondata dalla comunità che mi sono faticosamente costruita, ancora nella città che considero il mio luogo sicuro (o forse dovrei chiamarla “la mia bolla”). E chissà, forse avrò anche imparato a non uccidere tutte le mie piante!». È facile immaginare in cosa si tradurrà il proclama di una maggiore radicalizzazione: vandalizzazione degli uffici dell’INAIL affinché non indichino più i dati dei morti sul lavoro divisi per genere (quasi tutti uomini, quindi oppressori patriarcali che non meritano nessuna attenzione), oppure la pubblicazione di qualche storia su Instagram insieme alle compagne femministe o mentre passeggia per i parchi bolognesi, in segno di vicinanza al gruppo oppresso di moda in quel momento. La parte interessante del suo proclama in realtà è quella secondo cui il lavoro sia una prerogativa delle società governate da una economia di tipo capitalista.
Vediamo alcuni dati: le stime sull’Unione Sovietica indicano i morti per le condizioni di lavoro in un numero di almeno venti milioni, quella sulla Cina si attestano su una stima di 100.000 morti ogni anno, cifra che è una stima molto probabilmente al ribasso e soprattutto per i decenni passati. Eppure Rul… ehm, Marina è laureata in antropologia, come può disconoscere il fatto che anche nei regimi socialisti per mandare avanti la baracca è necessario spaccarsi la schiena nelle acciaierie, nei pozzi petroliferi, nelle miniere? La spiegazione potrebbe schiudersi osservando la società odierna (quella italiana in particolare). Essa sembra ormai posseduta da un demone che cinge d’assedio ogni individuo e tenta sin dall’infanzia di corromperne lo spirito: l’ignoranza. Che non è (più) la semplice mancanza di conoscenza data dal mancato accesso al mondo dell’istruzione e quindi da condizione di marginalità sociale e economica, ma il rifiuto della conoscenza, sovente espresso da chi ha conseguito titoli e risultati accademici. Si tratta di uno spirito radicalmente contrario a ogni sapere e a ogni slancio di onestà e rigore intellettuale. Mentre l’ignorante d’un tempo era più propenso all’imbarazzo e alla vergogna, quello attuale, laureato e in qualche caso riconosciuto dalla comunità come “dotto”, ostenta con orgoglio questo tratto del suo animo. Così, mentre lo spirito consapevole dei propri limiti dell’ignorante d’un tempo conduceva al socratico “so di non sapere”, quindi a ricercare il sapere, a dotarsi di una cultura o, in extremis, a non far conoscere pubblicamente la propria ignoranza, oggi prevale una volontà di rimanere nell’oblio della più cieca e assurda stupidità che conduce alla vanteria, all’orgoglio di sé, e che fa terra bruciata d’ogni sapere, sostanziandosi in uno slancio inverso a quello del sapere. Il motto delle filosofe femministe instagrammabili di oggi diventa così: “so di non sapere, non voglio saperlo e ne vado fiera”.