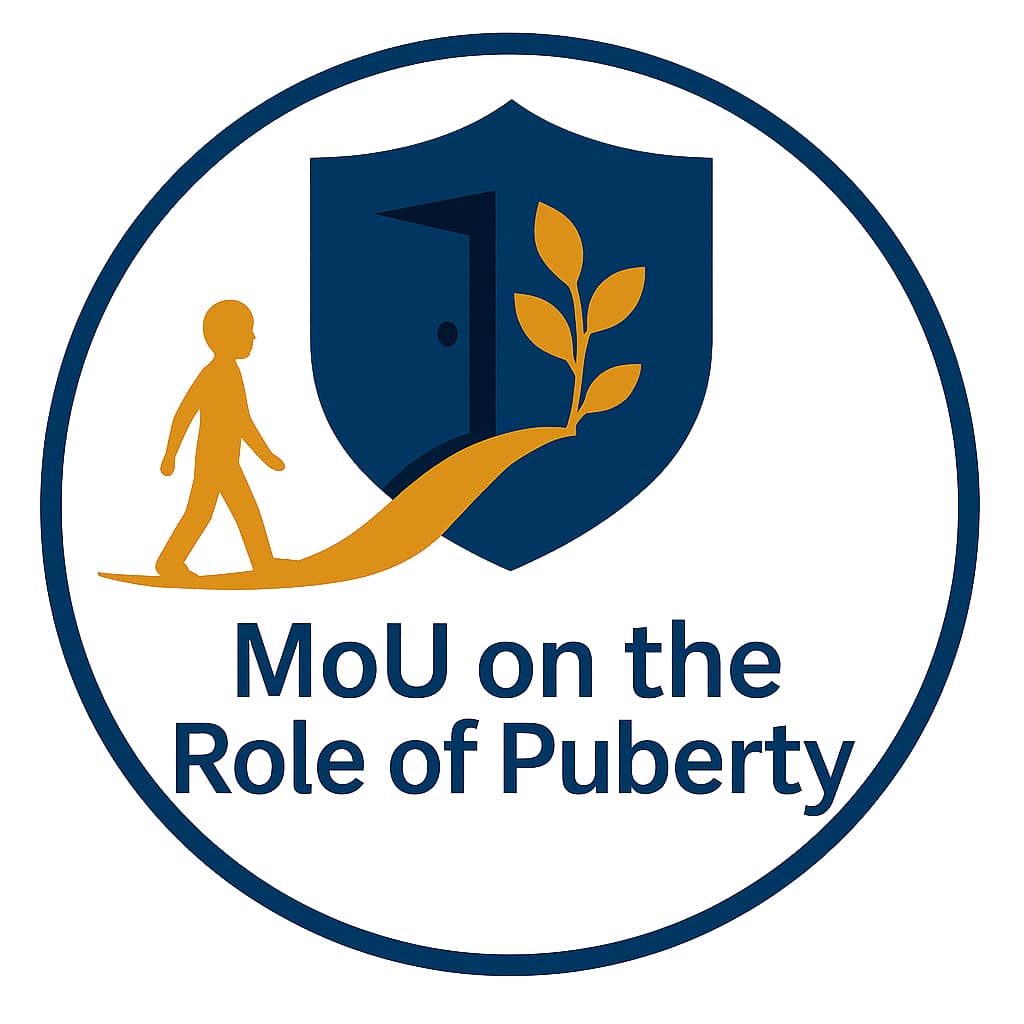«Bisogna tener fermo il proprio cuore; perché se lo si lascia andare, con che rapidità lo segue la testa! Ahimè, dove al mondo sono state commesse più stoltezze che presso i compassionevoli? E che cosa al mondo ha causato più dolore delle stoltezze dei compassionevoli? Guai a tutti coloro che amano, se non hanno anche un’altezza che sia al di sopra della loro compassione! Così una volta mi parlò il diavolo: “Anche Dio ha il suo inferno: e il suo amore degli uomini”. E ultimamente gli ho sentito dire queste parole: “Dio è morto; lo ha ucciso la sua compassione per gli uomini”. Dunque siete avvertiti contro la compassione», così parlò il filosofo Nietzsche attraverso Zarathustra. Per Nietzsche la compassione non è una virtù, ma un vizio da estirpare. Il filosofo oppone una serie di argomenti alla compassione nel suo scritto L’Anticristo (1888). Per prima, la compassione induce sovente a reazioni eccessive e senza proporzione con l’effettiva causa, ciò provoca un danno (come di fatto ammonisce il proverbio “il medico pietoso fa la piaga verminosa”, cioè la compassione del medico uccide il paziente). Inoltre, nulla toglie alla sofferenza reale di chi la prova, anzi invece che individualmente, fa soffrire in due (o in molti, in quanto si tratta di un sentimento contagioso), aggiunge al dolore provato dal sofferente, quello immaginario suscitato in chi osserva. In aggiunta, il filosofo sostiene che l’esercizio della vita morale richiede una grande forza del sentimento (coraggio, perseveranza, disciplina), la compassione invece indebolisce il soggetto: quando si ha compassione si perde forza. Infine, la compassione ostacola la selezione naturale, che è alla base del progresso (non solo biologico e sociale, ma anche morale) dell’uomo. Il compassionevole, che protegge ciò che è debole e malato, finisce per danneggiare quello che vi è di più sano e di migliore nell’individuo: l’ardimento del coraggio, la disponibilità al sacrificio.
Nietzsche non è stato né il primo né l’unico filosofo a criticare questo sentimento. La pietà verso i deboli e i sofferenti, o compassione, è un sentimento naturale, esaltato dalla religione cristiana come massimamente virtuoso, ma nel mondo classico questa morale compassionevole del cristianesimo era del tutto estranea. Il dominio assoluto della ragione sulle passioni, concepite di solito come vizi o malattie dell’anima, era l’ideale morale proposto dall’etica classica. Nella Retorica (II, 8), Aristotele definisce in questo modo il sentimento della pietà o compassione: «Definiamo la pietà un dolore causato da un male distruttivo o doloroso che appare capitare a una persona che non se lo merita e che si può attendere di soffrire noi stessi o uno dei nostri, e ciò quando questo male sembra prossimo; è evidente infatti che si proverà necessariamente pietà se ci si ritiene suscettibili, noi o uno dei nostri, di ricevere un tale male». La sofferenza altrui fa quindi paura, il timore nella previsione di un male futuro simile a quello che constatiamo nei nostri simili, e ci dispone in un atteggiamento di passività e di paralisi, contrario alla virtù. La compassione è quindi un sintomo di debolezza, prerogativa delle persone di rango sociale inferiore – le donne, gli schiavi o i bambini – che non hanno ancora sviluppato le forze della propria anima razionale. L’uomo saggio deve sopportare con fortezza virile il dolore della vita e persino l’ingiustizia di cui è talvolta vittima, consapevole che nulla di esterno può scalfire la coscienza del suo valore intimo.
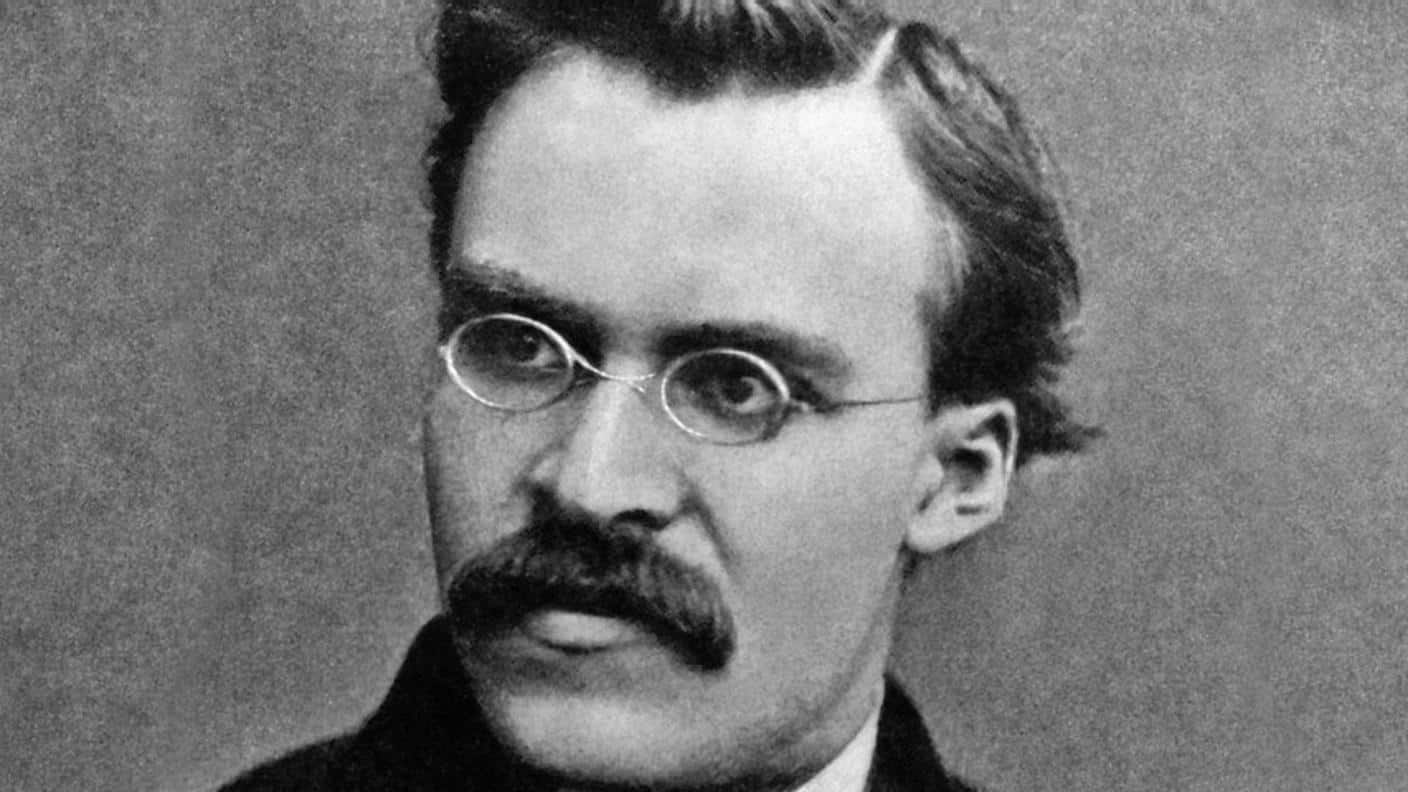
Nietzsche, la compassione e la clemenza.
Allo stesso modo l’uomo saggio deve giudicare gli altri, pretendendo da essi la stessa forza d’animo, invece di applicare la compassione e la commiserazione nei loro riguardi, che glieli renderebbe ai suoi occhi spregevoli. Commiserare qualcuno infatti significa ribadirne l’inferiorità: abbiamo compassione degli animali, o dei bambini, perché la loro fragilità fa appello più al nostro istinto di “protezione”, che ad un senso di giustizia o di uguaglianza. O delle donne! – aggiungo io –, non a caso la figura sofferente della madre di Gesù sotto la croce (la Pietà, quale massima icona dell’arte cristiana e occidentale) è stata assurta ad archetipo della virtù cristiana, non il Figlio torturato e ucciso. Chi soffre va soccorso e aiutato nel bisogno, perché lo impone un sentimento razionale di solidarietà, ma applicando sempre il sentimento della giustizia e della imparzialità. L’uomo saggio deve affrontare con freddezza razionale le situazioni luttuose dell’esistenza dei sofferenti. Dallo stesso parere sembrano gli stoici. Ecco come Seneca esorta il saggio a evitare la compassione, in un passo tratto da Della clemenza 2: «…così come la religione onora gli dei e la superstizione li offende, allo stesso modo tutti gli uomini di valore daranno prova di clemenza e mitezza, ma eviteranno la pietà, perché è condizione morbosa di un animo debole che si lascia turbare alla vista dei mali altrui. Pertanto è assai diffusa tra le persone di minor pregio: le vecchie e le donnicciole si lasciano commuovere dalle lacrime dei peggiori malfattori, e sfonderebbero, se potessero, le porte del carcere. La pietà guarda alla sventura, non alla causa; la clemenza, invece, si accorda alla ragione».
Il filosofo distingue nettamente tra clemenza (virtù razionale, propria dell’uomo saggio e giusto) e compassione (debolezza emotiva di chi si lascia sopraffare dalle emozioni). La compassione non deve offuscare il nostro giudizio nell’applicare la norma suprema della giustizia, che raccomanda di “dare a ciascuno il suo”. Anche il giudice più severo può applicare talvolta la legge con clemenza, attenuandone le sanzioni, ma non deve essere indotto a ciò dalla pietà, bensì da una pura considerazione razionale. Il colpevole, il debole o il sofferente non possono pretendere dagli altri un diritto alla compassione, ma soltanto il diritto ad essere trattati con giustizia. La compassione induce a giustificare qualsiasi misfatto, in nome di una auto-indulgenza, moralmente pericolosa, molto simile a quella messa in atto oggigiorno dal “buonismo”, atteggiamento caratterizzato dall’ingiustificata benevolenza e tolleranza nei confronti di qualsiasi gesto altrui. È da notare come questa sia stata, lungo la Storia, una delle grande accuse che spesso gli uomini hanno sollevato nei confronti delle donne per ostacolare loro l’esercizio della magistratura: le donne non riuscirebbero ad essere giudici imparziali, anteponendo i sentimenti alla freddezza razionale che il giudizio richiederebbe. Argomento denunciato dal femminismo come patriarcale, misogino e falso. Uomini e donne riescono ad diventare parimenti giudici imparziali? Argomento complesso e politicamente scorretto che, di nuovo, come è successo nell’intervento precedente, per ovvi motivi di spazi, per ora, non verrà trattato. Mi chiedo solo, en passant, se nelle notizie di cronaca nera che di tanto in tanto saltano all’attualità, di giovani adolescenti che dopo aver commesso atti molto gravi, come possono essere omicidi colposi oppure incidenti con l’auto, ed essere riusciti in un primo istante a svignarsela, siano stati convinti ad assumersi la responsabilità, denunciati o accompagnati in Questura dai padri o dalle madri. In questi casi così estremi, padri e madri agiscono allo stesso modo? Comanda in loro la ragione o il cuore?
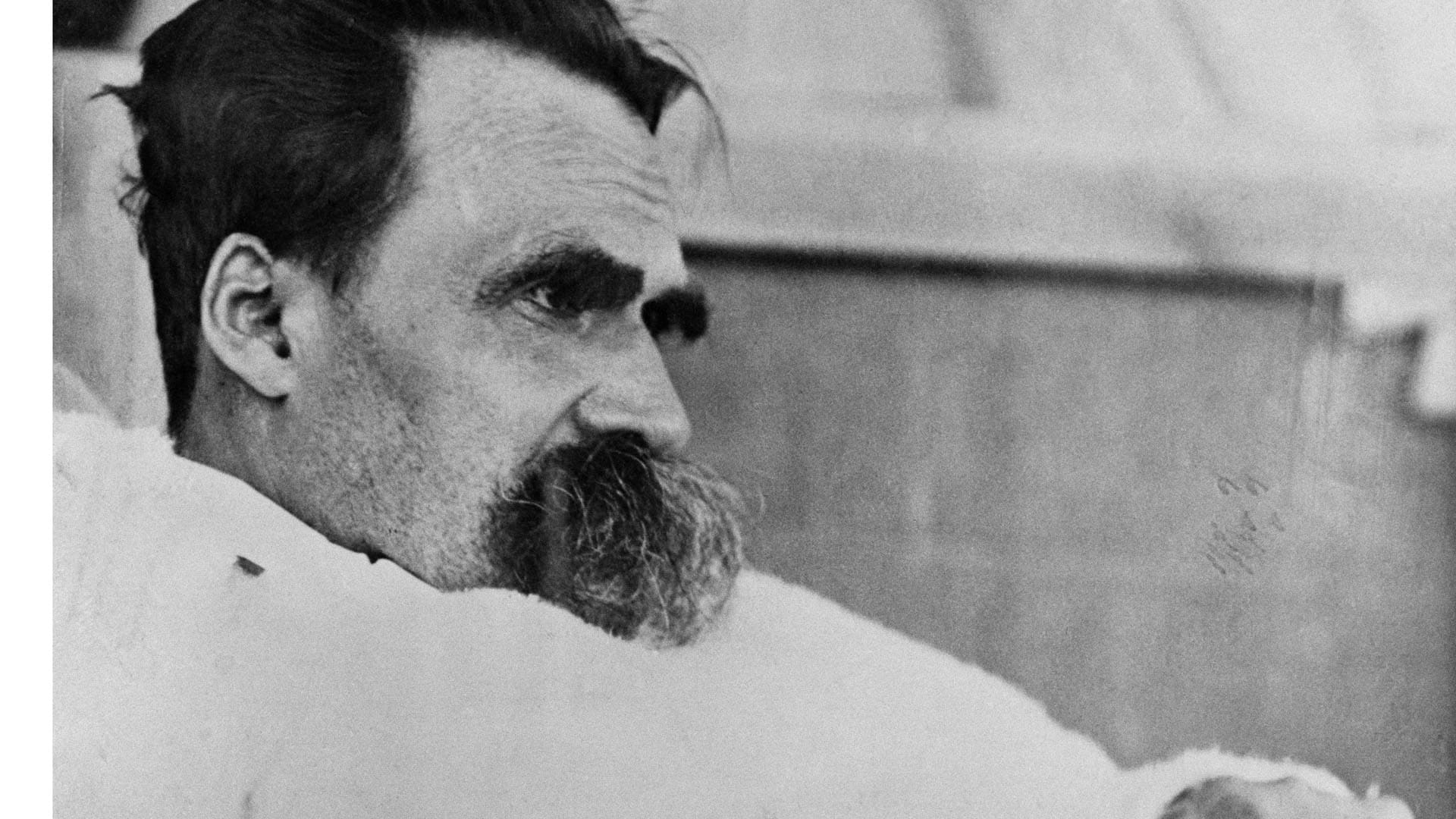
Nietzsche: «l’uguaglianza è potenza impotente».
Qualsiasi opinione possiate avere in merito, resta il fatto che tutti i filosofi accennati – Aristotele, gli stoici, Nietzsche – menzionano esplicitamente le donne come individui più a rischio di lasciarsi trascinare dalla compassione a scapito della razionalità. All’etica antica aristocratica dei liberi e forti, alla morale dei signori (o dei dominanti), caratterizzata da valori vitali, che provengono da individui forti, creativi, orgogliosi, nobili, indipendenti, autonomi, che vivono l’esistenza come affermazione, come aspirazione verso l’alto e capacità di affrontare difficoltà e rischio senza curarsi dell’approvazione altrui, è stata contrapposta, secondo Nietzsche, quella cristiana degli umili e sofferenti, la morale degli schiavi (o del gregge), che ha determinato una decadenza profonda della morale. La morale degli schiavi è una reazione dei deboli, degli oppressi, che non riescono a vivere con i valori dei signori e impongono i propri valori: l’umiltà, la modestia, la pietà, la compassione, la gentilezza, la pazienza, l’obbedienza e sottomissione alle regole e all’autorità, l’egalitarismo e l’uguaglianza, la sicurezza, il conforto, la stabilità piuttosto che il rischio o il pericolo… Sono forse questi valori marcatamente femminili, come ipotizzano molti dei filosofi “misogini”? Secondo il femminismo e, in special modo, Simone de Beauvoir, nella sua opera Il secondo sesso, alla radice dei problemi che le donne devono affrontare, c’è il mito dell’eterno femminino che descrive le donne come intuitive, affascinanti, sensibili, compassionevoli, abnegate, generose, ecc., e le allontana dalla razionalità. Mito o realtà, quanto c’è di vero?
Anche qui, al di là di qualsiasi opinione possiate avere in merito, resta un dato inoppugnabile: le femministe e le loro continue richieste di normative a tutela delle donne (soprattutto, ma non solo, nell’ambito della violenza), hanno moltiplicato all’infinito ovunque nel mondo le leggi e le norme, la burocrazia, l’assistenza alle donne, gli enti e i finanziamenti alla ricerca di sicurezza, conforto, egalitarismo, stabilità piuttosto che rischio o pericolo, obbedienza e sottomissione all’autorità e alle norme… tutti “vizi”, secondo Nietzsche, della morale degli schiavi. Col senno di poi, possiamo affermare che il filosofo tedesco è riuscito a descrivere in anticipo la vera natura del movimento femminista. Infine, una breve digressione sul concetto di uguaglianza, avverso al filosofo e venerato dall’ideologia femminista. In Così parlò Zarathustra: «predicatori dell’uguaglianza! La follia tirannica dell’impotenza invoca attraverso di voi l’uguaglianza; cosi le vostre più segrete voglie tiranniche si mascherano da parole di virtù! Presunzione umiliata, invidia repressa…». E ancora: «Con questi predicatori di uguaglianza non voglio essere confuso e scambiato. Giacché così parla a me la giustizia: “gli uomini non sono uguali”. E neanche devono diventarlo!». «Il volere libera», esclama Zarathustra, «questa è la vera dottrina della volontà e della libertà». Per Nietzsche la volontà di uguaglianza non è altro che la volontà di potenza impotente dei disgraziati. Aristotele distingue la giustizia commutativa (restituire l’uguale) da quella distributiva (dare a ciascuno in base al merito). Secondo voi, a quale delle due invocano «i predicatori di uguaglianza», gli «impotenti» di Nietzsche? E il femminismo? Nel prossimo intervento parlerò delle conseguenze dell’«impotenza», dell’«invidia ripresa».