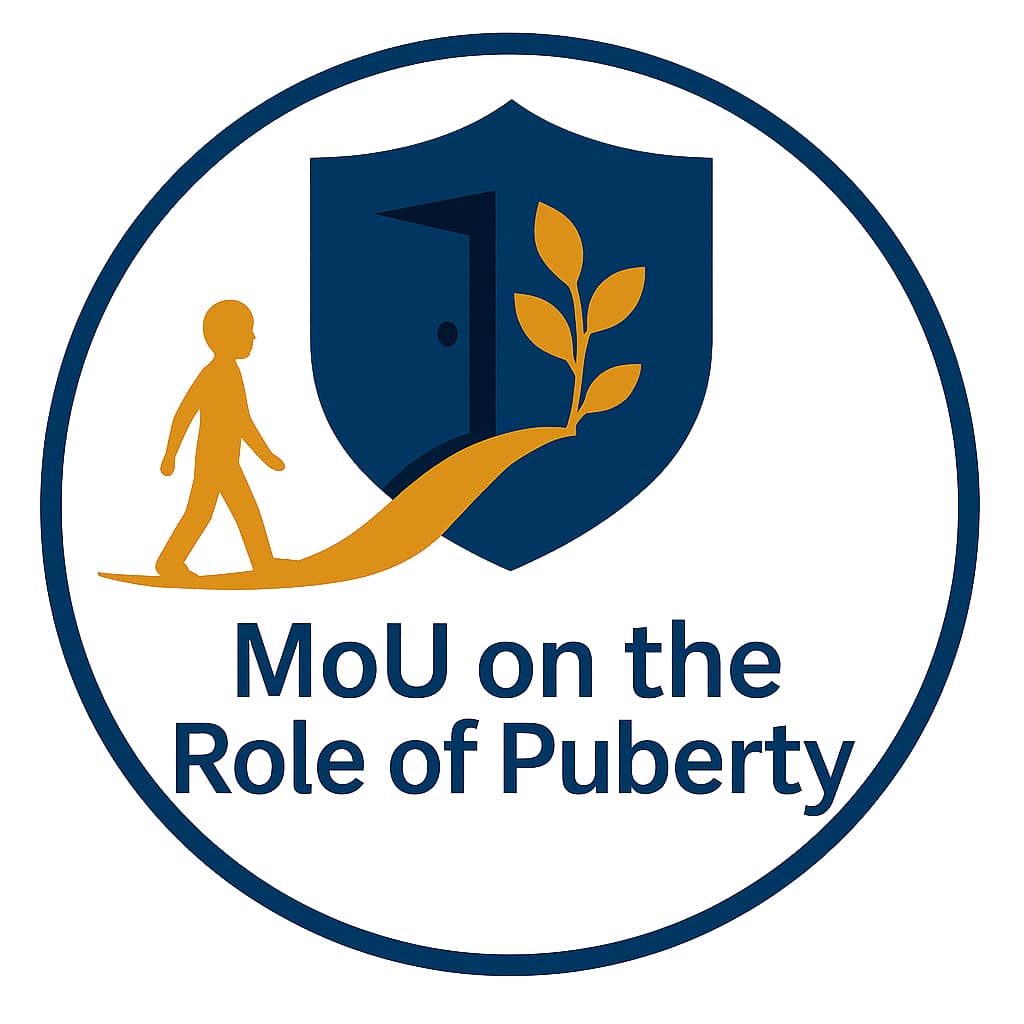Esiste nella natura umana una ricerca incessante della felicità piena, l’essere umano brama un Paradiso, che non possiede. È connaturale quindi nell’essenza umana una infelicità ontologica che non riesce a risolvere. Tutte le scuole filosofiche e tutte le religioni hanno ammesso che l’anima umana è sottoposta a questi turbamenti e difficoltà della vita. Per i greci, gli uomini conducono per lo più un’esistenza infelice e senza salute (dell’anima): più gravi delle malattie che aggrediscono il corpo sono le paure, i turbamenti, le false opinioni che gravano sull’anima. L’uomo teme esageratamente ciò che non può raggiungere (l’immortalità, il tempo sfuggente che scorre nella vita, la leggerezza dell’essere), si consuma nel desiderio di ciò che non può ottenere. Per la concezione cristiana del tempo, fortemente orientata in senso escatologico, la vita era solo un breve passaggio, una prova dolorosa, una valle di lacrime in vista dell’eternità. Da questa visione nasce, ad esempio, il ricorrente tema letterario e spirituale del Contemptus mundi (disprezzo del mondo), che si concentra sulla fugacità della vita terrena, sulla vanità dei piaceri mondani e sulla precarietà della condizione umana. Valga come esempio l’opera del poeta medievale italiano Iacopone da Todi, ispirata ad un crudo pessimismo basata sull’infelicità della condizione umana, di immagini cupe e forti delle sofferenze fisiche, i vizi, i peccati, la morte. Infatti, la Commedia di Dante nasce da questa visione cupa e apocalittica della realtà presente e dalla ansiosa speranza di un riscatto futuro. Dante vede dinanzi a sé un mondo caotico, violento e corrotto, «diserto d’ogne virtude» e «di malizia gravido e coverto», in cui l’ordine voluto da Dio per assicurare agli uomini la pace, la giustizia e l’esercizio delle virtù è stato sconvolto.
Durante il Rinascimento l’uomo perde la sua “centralità”, alla perdita di questo “centro” del cosmo (spaziale) corrisponde la disperante oscillazione tra aspirazione all’infinito e considerazione della propria nullità, visione accentuata nell’immaginario barocco, dominato dall’idea di infinito e di sproporzione tra umano e divino. Secondo Blaise Pascal, posto tra due infiniti (quello che precede la nascita e quello che succede alla morte), l’uomo avverte il senso della propria nullità. La sua aspirazione alla felicità è frustrata dal peccato. Il “vuoto del cuore” è il risultato tra la sproporzione tra la nostra “aspirazione” alla felicità e qualsiasi possibilità di un suo positivo “riempimento”. Scrive Pascal in Pensieri: «Descrizione dell’uomo: dipendenza, desiderio d’indipendenza, bisogno. Condizione dell’uomo: incostanza, noia, inquietudine». Per il filosofo Schopenhauer la vita è un processo di continua creazione e distruzione. Essa ha, come condizione del proprio perpetuarsi, il suo contrario: la morte e la distruzione di altri esseri viventi: «ogni vivere è per essenza un soffrire». L’uomo tende al piacere, ma questo stimolo ha per condizione uno stato di bisogno e quindi di dolore. La vita si rivela come un affare in perdita, essa si conclude per tutti con la catastrofe finale del morire. Schopenhauer ripete con il poeta Calderòn de la Barca: «il delitto più grande dell’uomo è nell’esser nato». In tutte le sue manifestazioni, la volontà di vivere è caratterizzata da un’insuperabile conflittualità. La natura, a tutti i livelli, mostra uno spettacolo desolante di «guerra e sopraffazione, miseria e dolore». Sommando fra loro i piaceri e i dolori del mondo, sono questi ultimi a prevalere.
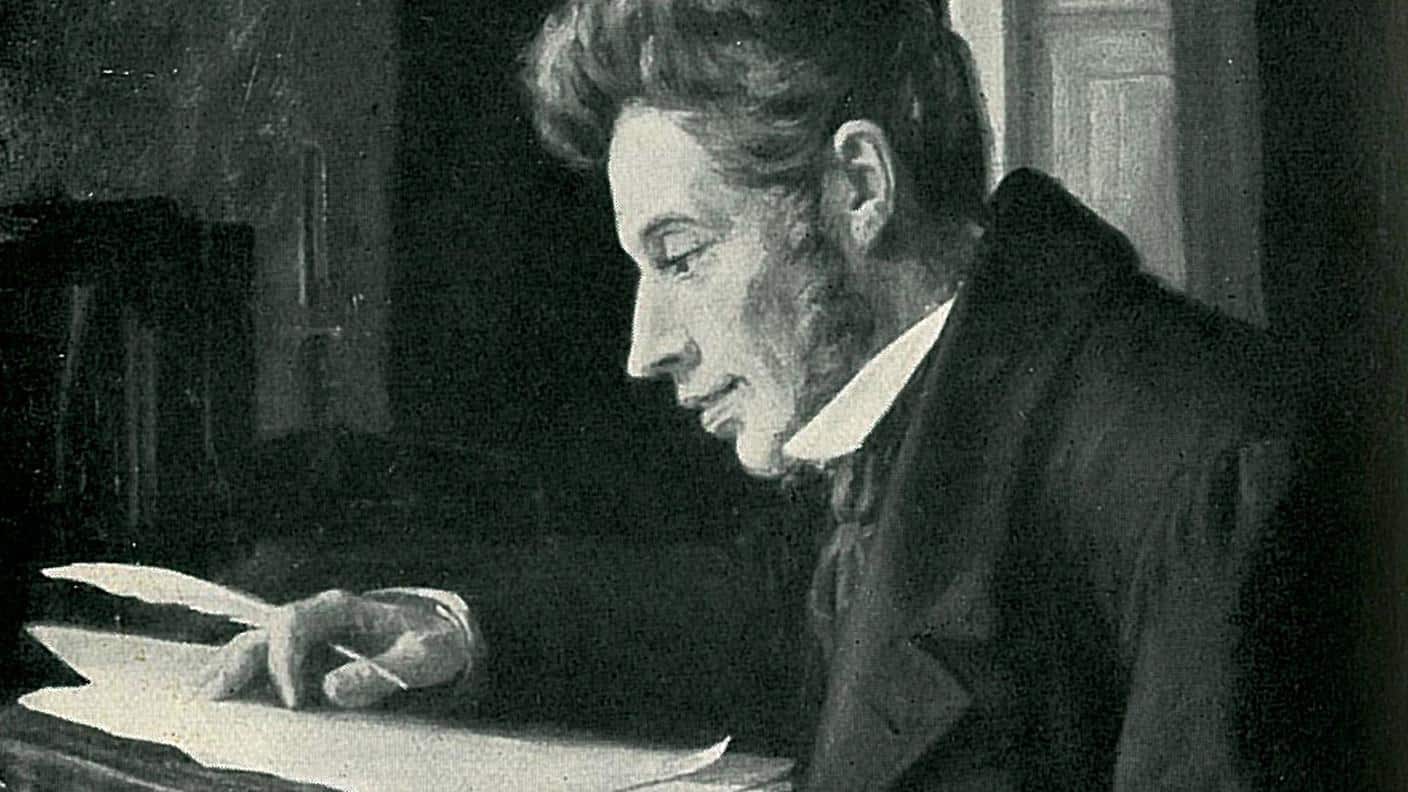
La parola ai filosofi.
Per Porfirio, nel Dialogo di Plotino e di Porfirio di Leopardi, la vita non ha alcun senso e l’aspirazione naturale dell’uomo alla felicità è destinata a venire frustrata dalla somma dei dolori e dei mali, che è sempre maggiore di quella dei possibili piaceri che si possono ottenere. Solo un errore di calcolo nella valutazione di questa “bilancia di piacere e dolore” è ciò che trattiene l’uomo dalla conclusione più logica: il suicidio. Per il filosofo Kierkegaard la disperazione è vista come condizione esistenziale propria dell’uomo in quanto tale. L’Io è sintesi sempre instabile, sempre precaria di finito e infinito, di necessità e libertà. Apparentemente l’uomo si dispera per una cosa determinata, ma in verità non è così: la disperazione è sempre di se stessi. Se un ambizioso non raggiunge il potere, non è disperato per il potere che non ha, ma per il suo Io, che gli è divenuto insopportabile: «vorrebbe sbarazzarsi di se stesso» ma non può, perché l’eterno che è in lui non può essere spento. La disperazione nasce dal fatto che «quell’Io, che egli disperatamente vuole essere, è un Io che egli non è». Dunque, alla base della disperazione c’è un fraintendimento: il fatto che l’uomo non accetta la propria natura di essere derivato, di essere posto da altro: «il disperato vuole separare il suo Io dalla potenza che l’ha posto». La disperazione “per non voler essere se stessi” e “il voler essere disperatamente se stessi”, assolutamente padroni di se stessi, sono le forme di una medesima malattia.
Per il filosofo Heidegger l’uomo si ritrova nel mondo a esistere senza sapere da dove viene e dove va, in uno stato di smarrimento: il suo essere si rivela come un “essere-gettato” nel mondo. Di fronte a una totale indeterminatezza assume particolare rilevanza lo stato d’animo dell’angoscia: davanti all’angoscia c’è il nulla: il mondo perde ogni significato. Il protagonista del romanzo La nausea del filosofo Sartre, lo scrittore Roquentin, è assalito dal taedium vitae e dalla noia profonda, e non sa dare un nome e un perché al proprio disagio, che interpreta come disagio fisico, malattia o debolezza nervosa. Il filosofo Max Horkheimer (Scuola di Francoforte), s’appella alla «speranza che, nonostante questa ingiustizia che caratterizza il mondo, non possa avvenire che l’ingiustizia possa essere l’ultima parola». Credo che questi pochi esempi possano bastare a constatare la diffusa esistenza di un sentimento condiviso di infelicità ontologica universale e atemporale nell’anima umano. Le diverse religioni e correnti filosofiche hanno attribuito il primato di questa fonte di oppressione esistenziale, che ostacola il raggiungimento della piena felicità, a svariate questioni generiche – la trascendenza, il peccato, l’ignoranza, le difficoltà della vita, la dimensione economica… – e hanno offerto altrettante soluzioni e una via per la felicità. Per i greci (socratici, platonici, aristotelici, stoici, epicurei, scettici, cinici…) soltanto la filosofia può liberare l’individuo dai turbamenti e dalla schiavitù che lo opprime.
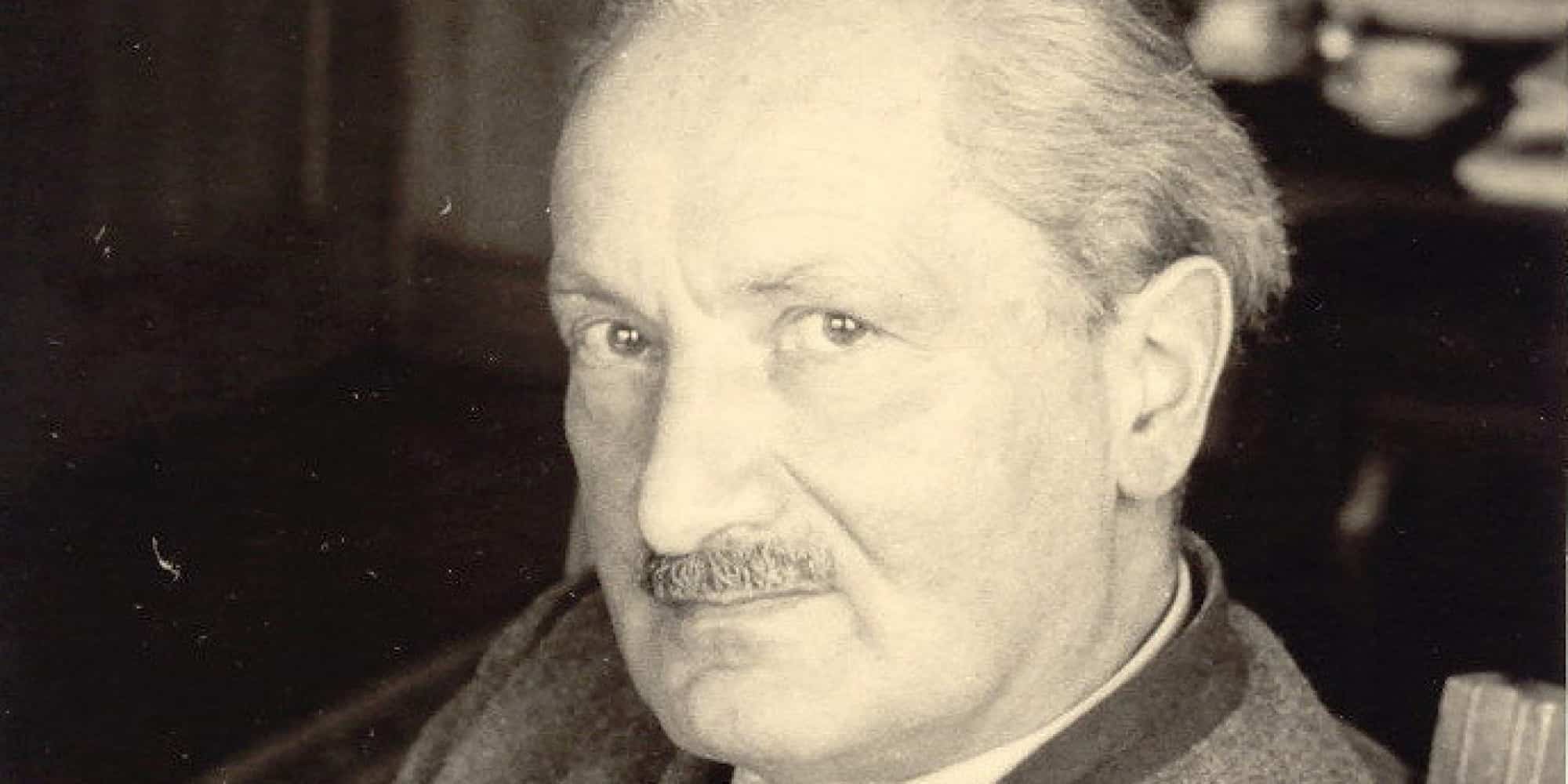
Felicità e Infelicità.
Per Kierkegaard la soluzione risiede nel cristianesimo, nella fede, unica via di salvezza dall’angoscia: solo la morale è in grado di offrire una prospettiva di redenzione dall’infelicità universale. La religione è la sfera in cui l’individuo scopre l’insufficienza della razionalità a governare l’esistenza e a conferirle un senso. La linea della sinistra hegeliana (Feuerbach-Marx) propone una soluzione radicalmente opposta: la religione è la causa dell’infelicità ontologica, è alienazione, perdita dell’essenza umana attraverso la proiezione delle sue qualità specifiche in un ente, Dio, “altro dall’uomo”, che non esiste. Per Marx, inoltre, la religione è frutto dell’oppressione sociale. Scrive Karl Marx in La questione ebraica (1844): «La religione è […] il suo universale fondamento di consolazione e giustificazione […] La miseria religiosa è insieme l’espressione della miseria reale e la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo. […] La critica della religione è dunque, in germe, la critica della valle di lacrime di cui la religione è l’aureola». Kierkegaard oppure Marx, soluzioni in antitesi scaturite dalla stessa problematica: l’angoscia della vita, la miseria e le difficoltà del mondo che è una valle di lacrime.
Questa sofferta coscienza – che Hegel definì «coscienza infelice» – della lacerazione esistente tra aspirazioni ideali e realtà effettiva, dell’insanabile frattura tra ideale e reale, tra piacere e sofferenza, che porta a uno stato di sgomento, e alla ricerca di una risposta capace di dar senso alla perenne insoddisfazione e infelicità della vita, ha trovato per le donne, grazie all’ideologia femminista, una sconvolgente analisi e soluzione nell’individuazione dell’uomo (il Patriarcato) il colpevole dell’infelicità ontologica femminile. «Nel XIV secolo, la scrittrice Christine de Pizan nega per la prima volta l’universalità dell’origine dell’infelicità dell’anima umana, e individua nell’uomo il principale indiziato dell’infelicità delle donne. […] La valle di lacrime universale, creazione divina e ineludibile, diventa con l’avvento del femminismo la valle di lacrime patriarcale, una costruzione maschile modificabile, un’infelicità guaribile mediante l’inevitabile conflitto dei sessi. La “condizione umana” si tramuta nella “condizione della donna”» (tratto dall’opera La grande menzogna del femminismo, p. 115). La realizzazione esistenziale della donna è compromessa dall’oppressione maschile, in altre parole, il problema dell’esistenza della donna è l’uomo. Ogni turbamento, ogni infelicità, ogni insuccesso della vita femminile, la fonte primaria dell’oppressione esistenziale femminile risiede nel Patriarcato, cioè nell’uomo. L’uomo è la causa della infelicità ontologica della donna, così come per i nazionalisti la fonte della loro oppressione sono le altre nazioni. La soluzione prospettata sarebbe la liberazione dall’uomo.

La spiegazione illogica del femminismo.
In conclusione, esiste un’infelicità ontologica che affligge l’anima umana, universale e atemporale (un dolore spirituale al di là delle reali e obiettive condizioni dell’esistenza: povertà, fame, prigione, torture…). In questo riflettere sulla condizione umana, l’ideologia femminista ha individuato per metà dell’umanità (le donne) nell’uomo la causa e consigliato la liberazione. Dall’altra parte, questa stessa ideologia non si è preoccupata di spiegare da dove provenisse allora l’infelicità e i turbamenti dell’altra metà dell’umanità (degli uomini), né si è curata di trovarne delle soluzioni. Questo è in sintesi il femminismo. Per fare più sopportabile il dolore dell’esistenza alle donne, il femminismo ha risolto questo “problema esistenziale” trovando un capro espiatorio della propria infelicità ontologica, un fantomatico nemico, una distrazione sulla quale convogliare e concentrare ogni sforzo e ogni lotta (la lotta contro il Patriarcato) in modo da sfuggire alle proprie responsabilità e scomode introspezioni: ogni fallimento, ogni insoddisfazione, ogni ansia, ogni infelicità, ogni disagio dell’anima femminile trova in questo modo la sua origine nel Patriarcato, negli uomini. A questo punto bisogna constatare con rammarico che, nella storia dell’umanità, a livello collettivo le donne hanno dato vita a un sistema ideologico, il femminismo, che incolpa gli uomini della loro infelicità ontologica mentre gli uomini, nella stessa storia dell’umanità, a livello collettivo, non hanno mai dato vita a un sistema ideologico che incolpa le donne della loro infelicità ontologica.