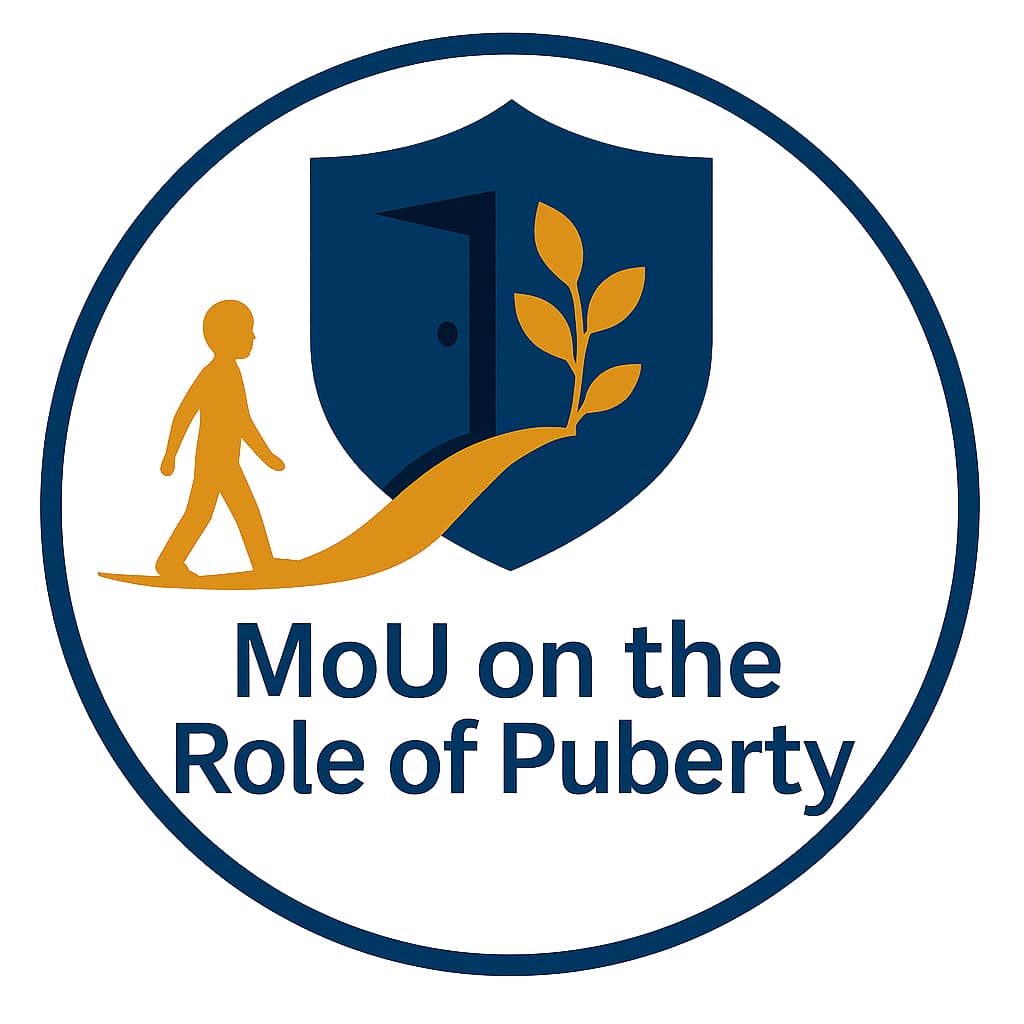Con la guerra tra la Russia e l’Ucraina si è tornato a parlare, soprattutto in Europa, di ripristinare la leva obbligatoria. Di fronte alla minaccia russa e alla carenza di personale (cioè di volontari), molti paesi europei stanno studiando la reintroduzione del servizio militare per rafforzare gli eserciti. Per quanto mi risulta, attualmente è obbligatoria solo in 8 paesi europei. Nel 2013, l’Austria votò per mantenere il servizio militare maschile obbligatorio, con una maggioranza del 60% (in pratica anche le donne austriache, che erano esenti da quest’obbligo, votarono a favore di mantenerlo). In Svizzera, tutti gli uomini sopra i 18 anni sono obbligati a svolgere il servizio militare, mentre per le donne è volontario. In Francia il servizio militare obbligatorio fu istituito dalla Rivoluzione nel 1789 e abolito nel 1997 dal presidente conservatore Jacques Chirac. In Italia non è stato abolito ma solo sospeso, si può ripristinare se è deliberato lo stato di guerra o in caso di grave crisi internazionale che coinvolga il paese. Nel Regno Unito, il servizio militare obbligatorio fu introdotto nel gennaio 1916, un anno e mezzo dopo l’inizio della Prima Guerra Mondiale, e richiedeva la partecipazione di tutti gli uomini single tra i 18 e i 41 anni; qualche mese dopo, vennero chiamati anche gli uomini sposati. Circa 2,5 milioni di uomini prestarono servizio obbligatorio fino al 1920. Successivamente, fu nuovamente attuato durante la Seconda Guerra Mondiale, iniziando con gli uomini dai 18 ai 41 anni, per poi estendersi, a partire da dicembre 1941, agli uomini fino ai 51 anni. Le donne furono chiamate al servizio civile e militare volontario, ma non furono soggette alla leva obbligatoria. In pratica, nel Regno Unito si ripristina il servizio militare maschile obbligatorio ogniqualvolta scoppia una guerra, allo stesso modo come attualmente prevede la legge italiana.
La Russia, in piena guerra, mantiene l’obbligatorietà maschile e non ha alcuna intenzione di eliminarla. Nel luglio 2023, in un momento in cui le sue truppe subivano pesanti perdite sul fronte ucraino, è stata aumentata l’età massima per la leva, che è passata da 27 a 30 anni, ampliando il numero di uomini che possono essere arruolati. Dall’altro lato del campo di battaglia c’è l’Ucraina, dove solo la mobilitazione maschile è obbligatoria. Gli uomini tra i 18 e i 60 anni hanno il divieto di lasciare il territorio ucraino, anche se si stima che 650.000 siano già fuggiti dal paese dall’inizio della guerra. I paesi baltici non hanno mai smesso di temere la minaccia russa e l’annessione della Crimea ha riacceso la necessità del servizio militare obbligatorio. In Estonia, il servizio militare è obbligatorio per tutti i giovani, con una durata che va dagli 8 agli 11 mesi. La Lituania lo ha reintrodotto nel 2015 per gli uomini tra i 18 e i 26 anni, dopo averlo abolito nel 2009. Il Parlamento della Lettonia, invece, ha approvato nel 2023 la Legge sul Servizio di Difesa Nazionale, che prevede la reintroduzione del servizio militare volontario per gli uomini sopra i 18 anni, e obbligatorio a partire dal 2024. Tutti gli uomini tra i 18 e i 27 anni dovranno completare un corso di addestramento militare di 11 mesi e saranno richiamati progressivamente, in modo che dal 2028 ogni anno 7.500 lettoni vengano convocati al servizio.

Un sacrificio mai sottolineato.
In Norvegia, dal 2016 tutti gli uomini e tutte le donne devono presentarsi agli esami fisici militari, ma solo circa 9.000 su 60.000 persone sottoposte a esami sono poi effettivamente chiamate al servizio militare obbligatorio, che dura 19 mesi. Parimenti la Svezia che, a causa della mancanza di reclute, ha reintrodotto il servizio militare obbligatorio nel 2018 (per quanto mi risulta, assieme alla Danimarca e alla Norvegia sono gli unici tre paesi europei che prevedono un servizio militare obbligatorio per entrambi i sessi, ciò non vuol dire però che le regole di ingaggio siano identiche per entrambi i sessi). In Finlandia, gli uomini sono chiamati al servizio militare al compimento dei 18 anni e la sua durata varia da 6 a 12 mesi. Una volta terminato, entrano nella riserva fino ai 60 anni. Per le donne, il servizio militare è volontario. Agli uomini finlandesi che non hanno ancora prestato servizio militare vengono emanati passaporti validi solo fino ai 28 anni, costringendoli, se sono all’estero, a tornare e prestare servizio – l’età della leva in Finlandia dura fino alla fine dei 30. Farsi fare un passaporto per sfuggire la leva o perché si vuole emigrare, non sarà quindi utile, poiché i passaporti finlandesi sono validi al massimo per 5 anni o limitati fino ai 28 anni. Inutile far notare che le donne finlandesi possono farsi fare i passaporti senza limiti di età ed emigrare ovunque e quando desiderano senza alcuna limitazione, limitare i loro movimenti, come tutti sappiamo, sarebbe una grave violazione dei diritti umani.
Se c’è un argomento, al di sopra di qualsiasi altro, che mette in evidenza le contraddizioni della teoria femminista e l’inesistenza del Patriarcato, «una struttura politica universale che privilegia gli uomini a spese delle donne», questo è la guerra e la leva maschile obbligatoria. Il diritto all’incolumità e alla vita è il diritto basilare sul quale possono trovare fondamento tutti gli altri diritti. Senza vita nessun altro diritto ha senso. La guerra mette a repentaglio in maniera evidente il diritto alla vita e, a cascata, comporta la violazione di tutta una serie di ulteriori diritti, all’incolumità, alla libertà, alla proprietà… Non c’è bisogno di disturbare il cinema per stuzzicare l’immaginazione per capire la portata di sofferenza, di ingiustizia e di tragedia che comporta la guerra. Film classici, se mi è permesso di consigliare, come Orizzonti di gloria del 1957 (tre soldati si rifiutano di continuare un attacco suicida, saranno fucilati per codardia durante la Prima Guerra Mondiale; l’attore Kirk Douglas, nei panni del colonnello, cerca di difenderli) oppure L’arpa birmana del 1956 (racconta la storia di un soldato che abbandona l’esercito giapponese in ritirata). Nel film sudcoreano My Way del 2011 si racconta l’assurda storia di Yang Kyoungjong, un soldato coreano che sarebbe stato catturato dall’esercito americano durante il D-Day. Yang Kyoungjong sarebbe stato arruolato con la forza prima nell’esercito imperiale giapponese; catturato dai russi, avrebbe poi servito forzatamente nell’Armata Rossa; infine, catturato dai tedeschi, avrebbe servito, di nuovo forzatamente, nella Wehrmacht (l’esercito tedesco). È difficile immaginare come la società possa concepire questi uomini come i «privilegiati» di un sistema sociale denominato Patriarcato. Ed è questa la cosa sbalorditiva di questi film: nessuno di loro, né nessun altro film bellico mai realizzato, tratta l’argomento come se fosse una questione di genere.

L’assenza dell’ONU.
Nella guerra le società hanno sempre tutelato il diritto delle donne alla vita e trascurato o, più correttamente, ignorato lo stesso diritto degli uomini. E questa tragica asimmetria è stata completamente normalizzata. Ieri e oggi. A nessun film è mai venuto in mente di denunciare la profonda ingiustizia radicata nel destino di sofferenza e di morte assegnato agli uomini, in quanto uomini, mentre le donne stanno al sicuro a casa. Nel film Orizzonti di gloria i tre soldati francesi saranno fucilati perché avevano gettato «una macchia sull’onore di tutti gli uomini, donne e bambini di questa nazione». La vita e il comportamento maschile sottoposto al servizio e al giudizio delle donne, che non sono tenute a fare altrettanto per gli uomini. E così le donne austriache votano il destino degli uomini austriaci. È incredibile come la guerra non sia per nessuno, né per il movimento femminista, né per i media, né per le istituzioni – menzione speciale merita l’ONU, sempre latitante su questo fronte – una questione di genere. È incredibile come l’argomento guerra riesca a normalizzare qualsiasi violazione di diritti a danno degli uomini. A chi può interessare se gli obiettori di coscienza (ad esempio in Corea del Sud) vengono imprigionati? A chi può interessare se agli uomini finlandesi o agli uomini ucraini vengono limitati i loro spostamenti internazionali? Di sicuro all’ONU no.
Tradizionalmente, questo asimmetrico trattamento viene giustificato con l’argomento evolutivo: le nascite delle nuove generazioni sono limitate dal numero di femmine fertili, per questo motivo gli esseri umani possono tollerare la perdita degli uomini più facilmente della perdita delle donne. Ma questo non ha mai spiegato perché le donne non fertili, anche quelle ultra quarantenni, ormai oltre l’età fertile, non vanno spedite a combattere alla pari degli uomini. Oppure a bonificare le zone minate. Ci deve essere una ragione più impenetrabile, una ragione che spiega l’ingiustificata tutela di tutte le donne a scapito degli uomini in qualsiasi ambito, la tutela delle donne infertili in guerra, la tutela delle donne separate che vengono ingiustamente mantenute, la tutela delle donne che andavano in pensione prima degli uomini (e lo fanno ancora in molti paesi) senza nemmeno aver avuto gravidanze o figli, ecc. L’unica spiegazione plausibile è l’asimmetrico valore concesso dalla società agli uomini e alle donne. Alla donna, in quanto essere speciale, la società concede un plusvalore – comportamenti giudicati più indulgentemente, maggiore presunzione di credibilità, maggiore tutela e attenzione (ad esempio le date ricorrenti dell’8 marzo e del 25 novembre, e tutte le altre giornate internazionali dedite alle donne) –, che non è concesso agli uomini. Le donne stesse crescono convinte di possedere per diritto naturale questo plusvalore, di valere di più degli uomini. Per loro è legittimo ottenere di più, anche se ingiusto e se comporta sofferenza maschile (ad esempio, nella guerra loro pretendono la protezione degli uomini anche se questo può recare a quest’ultimi sofferenza e morte).
Quanto siamo disposti a dare?
E tutto questo è stato normalizzato dalle istituzioni, dai media, dalla scuola, dalla società. Per questo motivo sentiamo parlare continuamente di “diritti delle donne”, “tutele delle donne”, perché le donne sono state educate al privilegio e si sentono nel diritto di ottenere di più, perché per la società i bisogni femminili sono di gran lunga più importanti di quelli maschili e del danno che, la soddisfazione di questi bisogni femminili, possa recare agli uomini. Il Patriarcato è solo il modo che ha il movimento femminista per giustificare le continue richieste femminili per ottenere di più. Il rispetto che nel 1965 reclamava l’uomo alla propria compagna, quando arrivava a casa stanco dal lavoro e le dava lo stipendio, nella celebre canzone Respect di Otis Redding, divenne per tutti e tutte, due anni più tardi, un rispetto ribaltato, reclamato dalla cantante Aretha Franklin, e con lei da tutte le donne, ai loro compagni. Il rifacimento di Aretha Franklin della canzone Respect divenne un inno della lotta femminista che, come la sua narrativa, ha capovolta la storia: è il sacrificio femminile che merita il rispetto maschile. Le donne si sono erette così a giudici del comportamento maschile, e fissano gli standard, al di fuori dei quali gli uomini gettano «una macchia sull’onore di tutte le donne». In quanto detentrici di questo plusvalore, loro pretendono di ricevere dagli uomini molto di più di quanto siano disposte a dare. La società asseconda. Soltanto questo plusvalore aggiunto delle donne può spiegare quindi la netta asimmetria che avviene in ogni ambito e, in special modo, in guerra. È dovere dell’uomo sacrificare la vita a favore di lei. È diritto della donna pretenderlo. Come succede oggi in Ucraina e in ogni guerra. Come è successo sempre. Il femminismo non ringrazia: esige ed insulta. Prima o poi l’uomo dovrà decidere quanto è ancora disposto a dare.