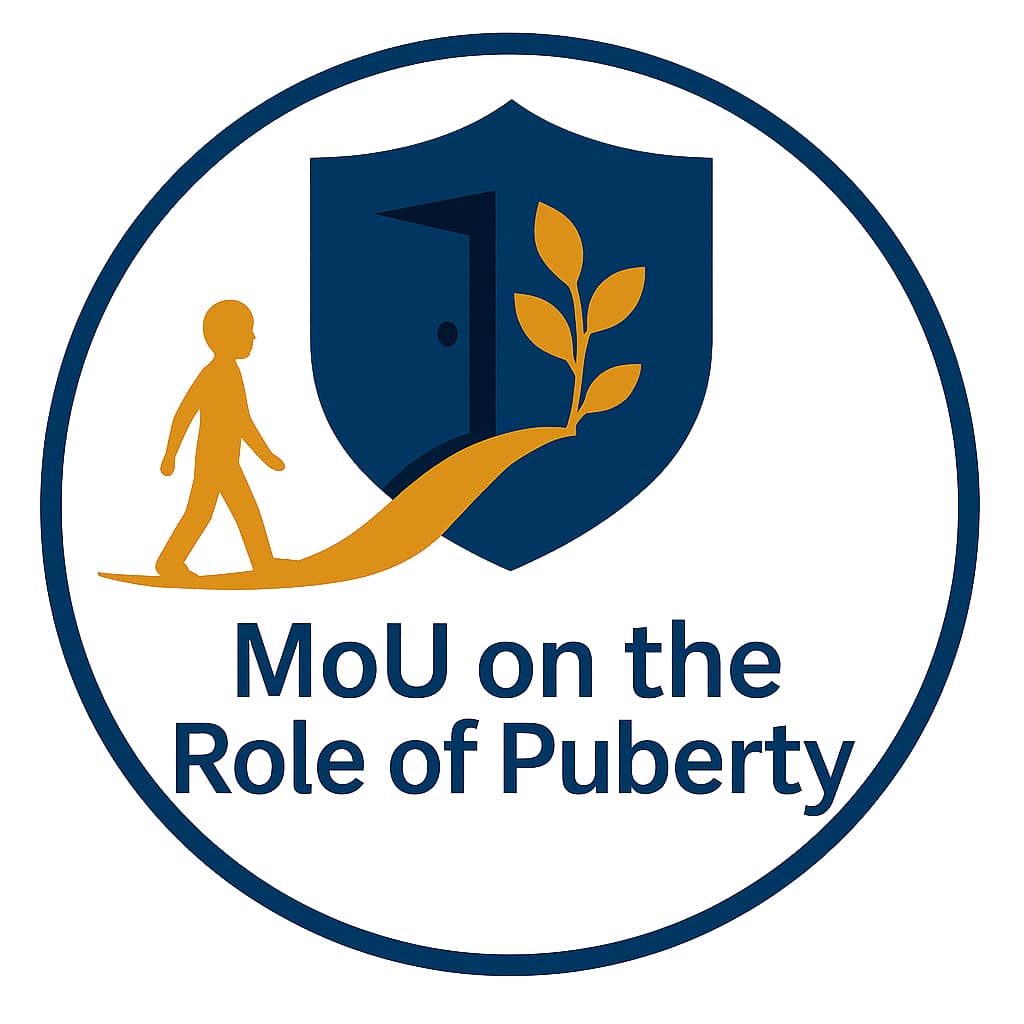«Androcentrismo: consiste nel considerare l’uomo (inteso come maschio) come misura di tutte le cose», definizione tratta dalla Guida per la formazione tecnica e politica per le donne (Comune di Torino, Formación y capacitación política para mujeres electas, URB-AL Red n12 “Mujer y Ciudad”, Finanziato dalla Comunità Europea, 2006, p. 69). Fino a non molto tempo fa i filosofi, credendo di parlare a nome di tutti sotto la falsa riga dell’umanità, parlavano in realtà unicamente nel loro nome, e non parlavano né riflettevano il punto di vista delle donne. Dunque, le presunte verità universali dei filosofi riguardavano unicamente una visione maschile. Questa sconvolgente e rivoluzionaria critica è uno dei grandi contributi del pensiero femminista. Quando studiamo la produzione dell’umanità (testi, dipinti, opere materiali, concetti…), per una migliore comprensione adoperiamo l’analisi. L’analisi permette di intendere più in profondità il messaggio, mediante la scomposizione dell’oggetto di studio nei suoi elementi costitutivi e nei rapporti che tra questi si determinano. In questo modo si colgono i legami del pensiero dell’autore, con la tradizione e con il contesto storico. Individuare il contesto storico e culturale nel quale si è mosso l’autore, eventuali influenze e riferimenti ad altri autori e produzioni della stessa epoca, differenze e analogie, la “contestualizzazione” insomma, è un elemento rilevante dell’analisi. Tutti gli autori sono immersi in un specifico contesto storico e culturale, tutte le opere nascono influenzate da questo contesto e possono essere pienamente comprese soltanto se inserite all’interno di questo contesto. La produzione quindi è “contaminata” dal tempo nel quale viene prodotta.
La nazionalità, la religione, il ceto sociale, l’epoca vissuta, sono tutti elementi che hanno influenzato l’opera e ci fanno decifrare il messaggio in maniera più accurata. In questo modo però, poiché il messaggio risulta contaminato dal contesto, vengono relativizzate le intenzioni dell’autore di proporre verità universalmente condivisibili. In altre parole, in genere la produzione cristiana produce produzione cristiana, la produzione musulmana produce produzione musulmana, la produzione rinascimentale produce produzione rinascimentale, la produzione borghese produce produzione borghese, e così via. Se Aristotele giustifica l’istituzione della schiavitù lo fa perché è immerso in una società schiavista. Ad un certo punto, il femminismo ha introdotto un altro elemento di importanza, a dir loro, fondamentale: il sesso. Agli elementi previamente elencati, che servivano ad analizzare correttamente l’opera dell’umanità ed eliminarla dei pregiudizi culturali e storici, è stato aggiunto in maniera preponderante il sesso dell’autore, allo scopo di eliminare dalla produzione i pregiudizi misogini e/o patriarcali: la produzione maschile produce produzione maschile. Lungo tutta la Storia l’uomo, spesso inconsapevolmente, avrebbe spacciato per universale una produzione che in realtà risultava essere solo maschile, contaminata da gravi pregiudizi maschili. Inevitabilmente, per default, poiché l’umanità ha vissuto sempre in un Patriarcato, tutta la produzione prodotta dall’umanità arrivata fino a noi (testi, idee, dipinti, opere materiali…), in special modo quella prodotta dagli uomini, che comprende la maggior parte della produzione universale, è viziata da questo difetto, contaminata da una visione androcentrica. «L’androcentrismo è ovunque».
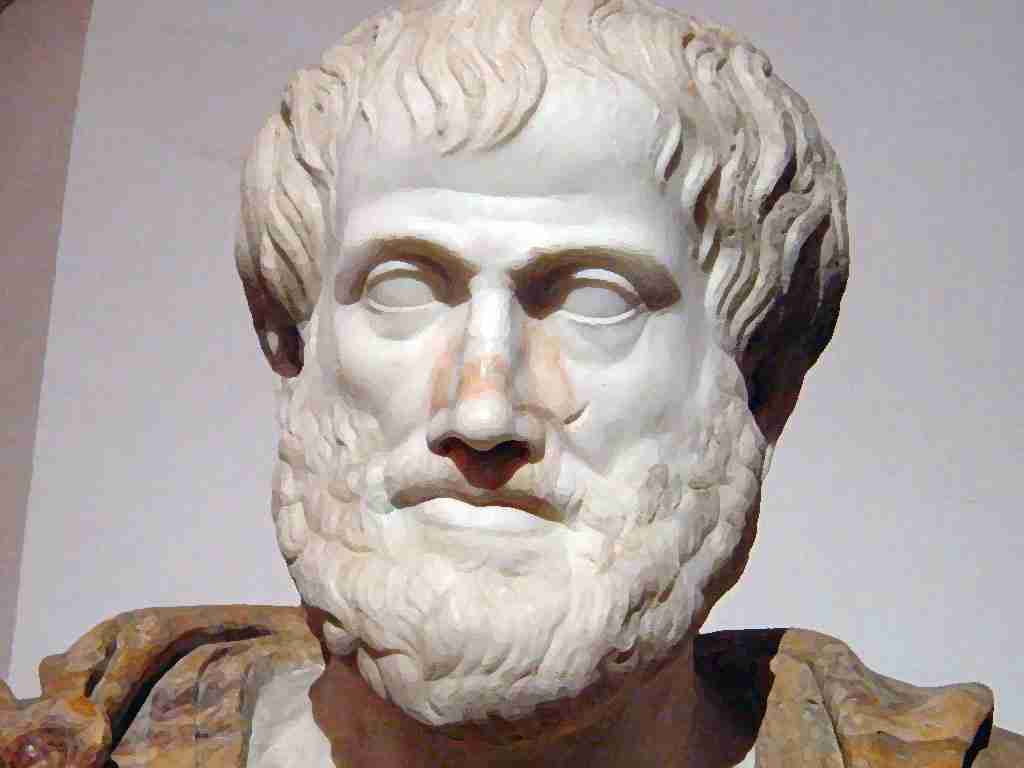
Androcentrismo e pregiudizi.
Tutte le correnti filosofiche (storicismo, umanesimo, strutturalismo, spiritualismo, stoicismo,…), tutta la filosofia, tutti i rami del sapere (linguistica, etnologia, teologia, sociologia, matematica, psicologia, psicoanalisi…), tutti i filosofi e i pensatori prima dell’avvento del femminismo – anche le donne, contaminate all’epoca dallo stesso pensiero patriarcale –, e le loro opere e il loro pensiero, sarebbero sospetti di androcentrismo, cioè viziati da un pregiudizio contro la donna che sarebbe necessario vagliare, rivedere, riformulare e correggere sotto la nuova ottica dell’inclusione della donna, della sua esperienza, del suo pensiero, del suo sentire… Valga come unico e semplice esempio l’analisi dei miti di Claude Lévi-Strauss. Generalmente ricondotti all’ambito della fantasia, secondo il filosofo i miti sono invece trasformazioni delle strutture logico-formali che, nelle più diverse culture, consentono agli uomini di ordinare e di dare senso ai fenomeni, frutto dell’attività inconscia dello spirito umano. Per sostenere la sua tesi, il filosofo durante anni farà degli studi e delle ricerche etnografiche che verranno pubblicati nei suoi volumi. Ora, se teniamo conto della critica sollevata dal femminismo dobbiamo dedurre che le conclusioni alle quali è arrivato Lévi-Strauss sono sbagliate: lo studioso, contaminato dalla sua visione androcentrica, credeva ingenuamente di studiare l’attività inconscia dello spirito umano, quando in realtà studiava solo l’attività inconscia dell’uomo, la donna esclusa. I miti stessi, come tutti sappiamo grazie alle teorie femministe, sono caratterizzati dalla stessa misoginia e androcentrismo, quindi lo stesso oggetto di studio era già “contaminato”, questione che probabilmente Lévi-Strauss non è riuscito nemmeno a intravedere.
Compito quindi degli studiosi è quello di palesare i pregiudizi maschili delle teorie di Lévi-Strauss, o di qualsiasi altra teoria o ramo della scienza, rimasti invisibili fino all’avvento della critica femminista. Nell’ambito della filosofia, mettere in risalto il pensiero femminile, portare alla luce le pensatrici emarginate e additare il pensiero e i filosofi misogini, come fa il giornale la Repubblica. «Cosa ha perso il mondo impedendo al genere femminile di esprimere la propria voce?», si chiede il giornale. «Il pensiero femminile è stato ignorato da millenni di cultura patriarcale». Il giornale non si chiede «cosa ha perso il mondo» per il mancato pensiero di milioni di uomini e di donne ai quali è stato impedito, per povertà o per mancanza di istruzione, di esprimere la loro voce lungo la Storia, ma specificamente, e unicamente, lo si chiede per «il genere femminile». La perdita non è quindi quantitativa – il numero di essere umani ai quali è stato impedito di esprimere la propria voce –, ma qualitativa, manca «il pensiero femminile» (il pensiero maschile, androcentrico, c’è già), ammissione implicita che il pensiero e la produzione sono sessuate: un pensatore non riesce a sostituire una pensatrice e viceversa. Di primo acchito sarei disposto ad accettare la critica femminista, mi sembra ragionevole. Se uomini e donne siamo diversi (come sostiene il femminismo della differenza, cosa che anch’io condivido), allora le idee, riflessioni, comportamenti, desideri e conclusioni tendono a essere diversi, non universali. Il mio problema logico sorge quando la critica femminista si pone in maniera universale a giudicare la produzione storica tanto degli uomini come delle donne. A rigor di logica, se la produzione maschile produce produzione maschile, la produzione femminile deve per forza produrre produzione femminile. Per l’analisi femminista non è così.

E il ginocentrismo no?
Quando la produzione femminile lamenta la discriminazione e la condizione delle donne o denuncia l’androcentrismo e il comportamento maschile, come fa ad esempio il sopraccitato articolo della Repubblica, il femminismo si pone come un pensiero universale, che noi tutti gli uomini dobbiamo accettare. Vale a dire, per il femminismo la produzione femminista/femminile non produce produzione femminista/femminile, ma universale. Al contrario, quando la produzione storica femminile si è allineata con quella maschile, quando migliaia e migliaia di donne (ad esempio le migliaia di religiose), lungo la Storia, hanno alzato la propria voce a favore di valori e di un sistema prestabilito, noto come Patriarcato, allora per il femminismo non si tratta più di produzione femminile né universale, ma di condizionamento patriarcale. Le donne, inconsapevolmente – e contro la loro volontà, anche se non lo sapevano –, sotto il dominio androcentrico del mondo, avrebbero prodotto produzione e pensiero maschile. In questo modo la storiografia femminista spiega uno dei grandi misteri storici della narrazione storica femminista: il motivo per il quale il movimento femminista sia nato grossomodo solo due secoli fa, e le donne, che lungo tutta la Storia avrebbero vissuto per secoli nella più cupa oppressione e schiavitù per mano degli uomini, non si siano né ribellate né, in linea di massima, mai lamentate, ma al contrario, abbiano espresso molto più spesso entusiastiche adesioni a quei valori criticati dal femminismo.
In conclusione, la teoria femminista ha espresso un pesante giudizio critico e ha gettato il sospetto sulla validità universale della conoscenza e del sapere ereditati nei secoli, viziati da pregiudizi maschili e patriarcali, cioè androcentrici. D’altra parte però non ha saputo spiegare per quale motivo noi non dovremmo giudicare il suo pensiero, femminista/femminile, come il sopraccitato articolo della Repubblica, alla stessa stregua: pregiudizievole e ginocentrico. Cosa rende entrambe le produzioni diverse, tanto da far diventare la prima parziale e pregiudizievole, androcentrica, e la seconda valida e universale? Cosa rende il pensiero femminista/femminile immune ai peccati del pensiero maschile? Femminismo: consiste nel considerare la donna come misura di tutte le cose.