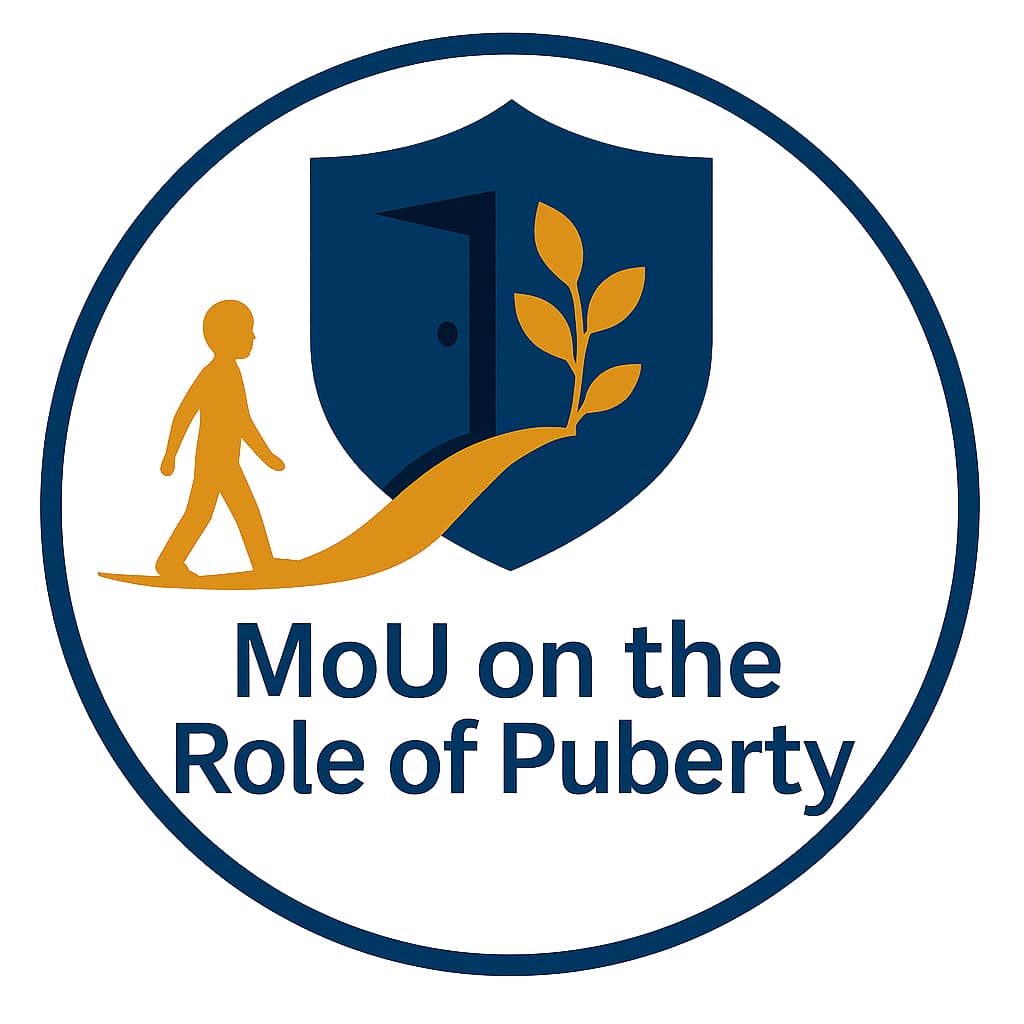«Ho esitato a lungo prima di scrivere un libro sulla donna», recita l’incipit dell’introduzione della celebre opera Il secondo sesso (1949), e con l’interrogativo «che cos’è una donna?» apre la riflessione l’autrice Simone de Beauvoir. Con quest’opera le donne fanno l’ingresso nel campo della ricerca filosofica. Raramente prima di lei, nella tradizione filosofica occidentale, i pensatori avevano trattato il tema della donna, e quando l’avevano trattato, l’avrebbero fatto con uno sguardo androcentrico. Secondo la de Beauvoir, la necessità di chiedersi cos’è una donna sarebbe una conferma della subordinazione femminile, nessuno si pone la stessa domanda per l’uomo, cosa sia un uomo si sa: la definizione dell’uomo corrisponde alla definizione di essere umano, inteso come soggetto razionale; la donna, invece, viene definita in relazione all’uomo. Secondo l’autrice, l’anatomia non è evocata per caratterizzare la figura maschile, ma per differenziare la donna. La figura maschile, la sessualità maschile, è la norma. L’uomo è il parametro di misura, sul quale si misura la donna: la sessualità femminile, ricondotta alla naturalità e all’irrazionalità, diviene quindi strumento per decretare l’inferiorità costitutiva del “secondo sesso”. La donna sarebbe «l’inessenziale di fronte all’essenziale. Egli è il Soggetto, l’Assoluto, lei è l’Altro».
Lungo la Storia, le diverse correnti filosofiche (stoicismo, umanesimo, esistenzialismo, personalismo…) hanno sempre attribuito la centralità alla persona, all’essere umano, senza specificare il sesso. L’essere umano non è soltanto incarnazione, in quanto esistenza in un corpo (sessuato) e in una situazione storica. Oltre al peso che esercitano sull’essere umano i fattori biologici ed economici e sociali, esiste anche una componente spirituale di vita interiore, oltre che esteriore, comune a tutti. È importante situare la persona nel contesto storico, in relazione con gli altri, gli uomini con le donne e viceversa, ma anche in relazione con sé stesso, in un esercizio continuo di bussare alla propria coscienza morale e di meditazione verso il mistero di una realtà che trascende analogamente tutti noi, una ricerca continua del “conosci te stesso”, dove non esistono uomini o donne, ma solo persone, esseri umani. L’uomo, che i filosofi intendono come essere umano, senza sesso, è un essere gettato nel mondo. La nostra esistenza effimera e il nostro ineluttabile destino ci legano in un unica riflessione comune. Mi servo di un semplice esempio, tra i tantissimi che potrebbero essere menzionati: secondo il filosofo italiano Giambattista Vico (1668-1744) l’uomo è l’artefice del «mondo delle nazioni». Con questo Vico non voleva negare il ruolo fondamentale della provvidenza divina, che per tutti all’epoca dettava le leggi costanti e universali, ma secondo lui all’interno l’uomo lavorava come un fabbro, nel rispetto delle quali l’agire umano produceva le differenti civiltà secondo le leggi dettate dalla provvidenza. L’uomo, inteso come essere umano, è dunque sì l’artefice della storia delle civiltà, ma la sua azione era, nelle sue linee generali, determinata dalle leggi imposte dalla provvidenza divina al corso degli eventi umani. Per Vico quindi tutti eravamo gli artefici, e tutti parimenti sottoposti alle leggi imposte dalla provvidenza divina, senza distinzione di sesso.

La confusione identitaria del femminismo.
Il femminismo diffida di questa presunta universalità che ci rende uguali – un pensiero che in realtà, a dir suo, nasconde una visione androcentrica a danno delle donne –, e attribuisce la centralità non più alla persona bensì alla persona sessuata, cioè alla donna (e quindi anche all’uomo, inteso come maschio). Scrive la de Beauvoir, sempre nell’introduzione: «Dorothy Parker ha scritto […]: “Non posso essere giusta verso i libri che trattano della donna, come tale… Io penso che tutti, uomini e donne, dobbiamo venir considerati esseri umani”. Ma il nominalismo è una dottrina un po’ miope […]. Certo che la donna è, come l’uomo, un essere umano: ma questa è un’affermazione astratta; il fatto è che ogni essere umano concreto ha sempre la sua particolare situazione. Respingere le nozioni di eterno femminino, di anima negra, di carattere giudaico non significa negare che vi siano, oggi Ebrei, Negri e donne: questa negazione non ha per gli interessati un significato di libertà, ma rappresenta una fuga dall’autenticità». De Beauvoir respinge quindi il trattamento della donna come essere umano, «un’affermazione astratta», vuota, «una fuga» che mira ad occultare la «particolare situazione» delle donne, cioè «l’eterno femminino», la subordinazione femminile, l’essere il «secondo sesso». Tale subordinazione, tale alterità rispetto all’uomo, però, non costituisce il destino della donna. Secondo l’autrice le radici della condizione femminile di dipendenza non sono naturali ma culturali, sociali; l’eterno femminino è una costruzione artificiale e patriarcale, da qui il suo noto motto «donna non si nasce, lo si diventa». Pertanto – conclude la pensatrice francese – è possibile un’azione collettiva di liberazione dalla subordinazione, subordinazione accettata dalle donne perché sottoposte a condizionamenti sociali ed economici. Ecco, in somma sintesi, il pensiero contenuto ne Il secondo sesso di Simone de Beauvoir.
È interessante evidenziare il periplo che ha fatto l’ideologia femminista sulla domanda posta dalla de Beauvoir: «che cos’è una donna?». È stata la stessa pensatrice a esserne la causa: se l’eterno femminile è artificiale e l’aspetto biologico, naturale, della donna è trascurabile rispetto alla sua realtà culturale, sociale, se «donna non si nasce, lo si diventa» e la donna deve essere decostruita per farla diventare… cosa? Tra gli anni ottanta e novanta, a seguito delle riflessioni della de Beauvoir, c’è stato un ripensamento critico di nozioni quali corporeità, sessualità, soggettività, assunte come direzioni di ricerca per individuare la specificità dell’essere donna. Anzi, in questa prospettiva, è lo stesso concetto di donna a essere stato messo in discussione: esso viene, infatti, ritenuto una costruzione culturale maschilista, non corrispondente ad alcuna identità femminile. Tale linea di riflessione si accompagna al rifiuto di indagini che rimandino alla contrapposizione tra un’essenza femminile e un’essenza maschile. Quest’impostazione comporterebbe il rischio di confermare la logica binaria dell’ordine patriarcale, rinchiudendo così le donne nelle opposizioni che intendono superare. Da qui dunque l’ideologia di genere, la critica alla nozione di soggettività femminile, in un contesto contrassegnato dalla fluidità e dalla crisi del soggetto sessuato: non esistono uomini e donne. «Che cos’è una donna?», dopo oltre mezzo secolo di “pensiero femminile” non si riesce più a definire il soggetto donna, siamo a punto e capo.

La mistificazione del genere neutro.
Curiosamente c’è un punto che accomunano la critica di Simone de Beauvoir e l’attuale dibattito sui trans e l’ideologia di genere: nessuno si chiede cosa sia un uomo. «Che cos’è un uomo?» è una domanda che non viene mai posta. Tanto ieri come oggi tutti si chiedono cosa sia una donna e nessuno sembra interessato a chiedersi cosa sia un uomo. Se la spiegazione fornita, nel 1949, dalla filosofa francese – nessuno lo chiede perché è ovvio, tutti lo sanno, la definizione dell’uomo corrisponde alla definizione di essere umano – potrebbe sembrare all’epoca ragionevole, oggi, dopo oltre quasi un secolo e, soprattutto, dopo mezzo secolo di rivoluzione femminista, questa spiegazione non ha più alcun senso. Forse la spiegazione è molto più banale di quella fornita dalla de Beauvoir: nessuno lo chiede perché nessuno è interessato. Forse sapere che cosa è un uomo è qualcosa di trascurabile, e rientra dentro della stessa logica di conteggiare solo il numero delle vittime femminili di omicidio (femminicidi), trascurando le vittime maschili, o di salvare in un incendio, in un naufragio o in un rapimento (vedasi il sesso degli ultimi ostaggi rapiti rimasti in mano di Hamas) per prima le donne, tralasciando gli uomini, o di parlare sempre delle condizioni delle donne e mai delle condizioni degli uomini, o di elargire lauti finanziamenti per la lotta contro la violenza sulle donne e ridotti per combattere il suicidio o le morti sul lavoro, che colpiscono preminentemente gli uomini, e così via.
Nessuno si chiede che cosa sia un uomo perché, fondamentalmente, a nessuno interessa che cosa sia un uomo (nemmeno agli uomini), è un argomento trascurabile. Come si giustifica questo disinteresse degli uomini a definirsi? Come si giustifica il disinteresse dei filosofi (maschi) verso la propria condizione? Come si spiega la ricorrente esigenza che hanno le donne di approfondire teoricamente lo studio della condizione della donna (e di riflesso della condizione dell’uomo, nel ruolo di oppressore e colpevole), esigenza che è mancata agli uomini? La verità è che l’essere uomo non corrisponde alla definizione di essere umano. L’uomo, in quanto uomo, non ha mai fatto l’ingresso nella ricerca filosofica. Come succede nel linguaggio delle lingue neolatine, l’uomo si è sempre confuso con il genere neutro (non esiste il genere maschile), e il neutro non ha valore in sé, non ha specificità. Lungo la storia della filosofia non è mai emerso un pensiero maschile sull’essere uomo (nei confronti della donna). L’uomo, senza valore in sé, senza specificità, si è confuso con l’umanità, è emerso solo in quanto essere umano (nei confronti dell’umanità). I filosofi hanno parlato e pensato in termini di umanità, di gruppo, senza differenze sessuate, similmente a un pater familias, inteso come capo famiglia, che pensa alla famiglia come un tutto unico e inscindibile da sé stesso.

Una domanda, stavolta per gli uomini.
È dovuto arrivare il femminismo per attribuire la centralità del pensiero a sé stessi in quanto soggetti sessuati, in conflitto con l’altro. L’interrogativo che la de Beauvoir e il femminismo hanno tentato di risolvere non è, in realtà, «che cos’è una donna?» ma che cos’è una donna per la donna (o per la de Beauvoir)?. In questo processo, senza averlo mai ammesso, la de Beauvoir e il femminismo hanno invero risposto a un’altra domanda: che cos’è un uomo per la donna (o per le femministe)? La risposta che è venuta fuori è stata ostile e deplorevole. Ho già accennato in un altro intervento che «l’inizio del più importante testo femminista [Il secondo sesso], invece di parlare delle donne, parla degli uomini, spiega cosa pensano, sentono e provano, entra nelle loro teste e li colpevolizza. Come Simone de Beauvoir, anche la più nota femminista italiana, Carla Lonzi, nell’opera Sputiamo su Hegel: «L’uomo è involuto in sé stesso, nel suo passato, nelle sue finalità, nella sua cultura. La realtà gli sembra esaurita, i viaggi spaziali ne sono la prova». La letteratura femminista abbonda di brani simili che spiegano (in negativo) come sono gli uomini, cosa pensano». Sinceramente, credo che sia arrivato il momento anche per gli uomini di tentare di rispondere finalmente, attraverso una profonda riflessione, alla domanda: che cos’è un uomo, per l’uomo?