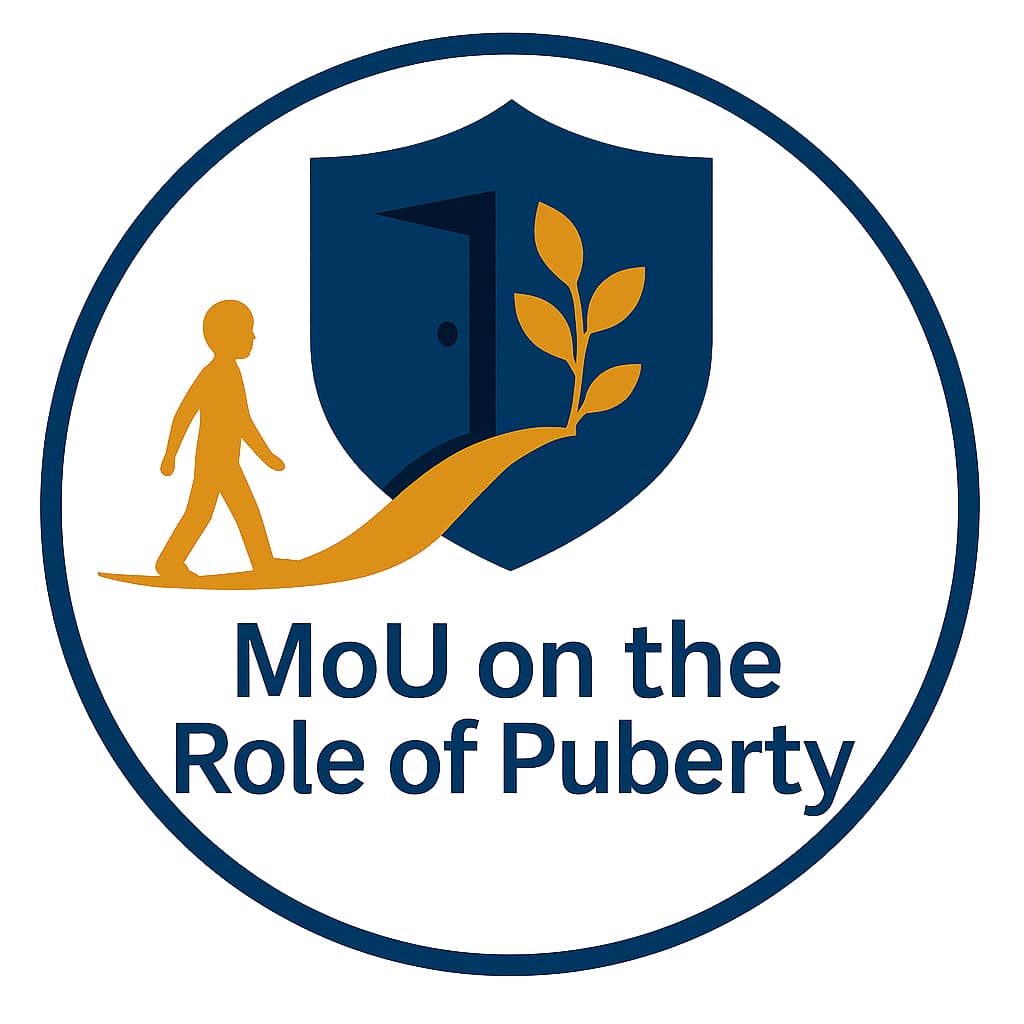La schiavitù è stato un fenomeno storico che ha afflitto l’umanità per secoli, coinvolgendo pressoché tutte le civiltà e le culture. Bisogna aspettare l’età contemporanea per veder riconosciuto, a livello politico, la crudeltà di quest’istituzione e i primi tentativi di abolirla. Il regno di Danimarca divenne il primo paese europeo a proibire il commercio degli schiavi nel 1802. Nel 1815 al Congresso di Vienna Gran Bretagna, Olanda, Francia, Spagna e Portogallo concordarono di abolire il commercio degli schiavi. L’Impero Britannico abolì la schiavitù nel 1833, con il Slavery Abolition Act. Negli Stati Uniti l’abolizione della schiavitù avvenne formalmente nel 1865, a seguito della Guerra Civile. L’ultimo paese dell’area di influenza europea che abolì formalmente la schiavitù fu il Brasile nel 1888. Oggi tutti i governi occidentali riconoscono pubblicamente la profonda ingiustizia di quest’istituzione. Penso di non sbagliare quindi se affermo che l’idea che la schiavitù sia un’inumana e brutale ingiustizia, sia un’idea pressoché universale e ormai patrimonio del mondo occidentale, condivisa da tutti: si tratta di un’istituzione moralmente inaccettabile sempre, non importa se in atto oggi, o un secolo fa, o un paio di millenni fa nell’Impero romano o nell’Antico Egitto. Un giudizio morale di riprovazione, ma anche di profondo stupore: come è stato possibile che l’umanità – persino persone ragionevoli, da Aristotele a Cristo – abbia potuto accettare l’idea che un individuo avesse il diritto di privare della libertà un altro? Il diritto alla libertà dell’individuo è un diritto inalienabile della condizione umana, sempre, la sua violazione un atto gravissimo. A qualsiasi vittima spetterebbe un lauto risarcimento.
Le nuove normative che, durante l’Ottocento, hanno abolito la schiavitù, non solo hanno fissato un quadro legislativo per il futuro, hanno espresso un giudizio di condanna morale inappellabile per il passato: quello che solo ieri era legale, l’indomani era divenuto un crimine atroce; quelli che il giorno prima risultavano essere rispettosi osservanti delle norme, l’indomani erano diventati dei disumani prevaricatori; quelli che il giorno prima risultavano schiavi, l’indomani erano diventati vittime di una crudele ingiustizia, meritevoli di un risarcimento. La domanda quindi: in che modo sono stati risarciti gli schiavi, una volta liberati, riconosciuta finalmente la profonda ingiustizia alla quale erano stati per anni sottoposti? In che modo sono stati risarciti gli schiavi dell’Impero Britannico liberati nel 1833, quelli degli Stati Uniti liberati nel 1865 o quelli del Brasile liberati nel 1888? La risposta: in nessun modo. L’abolizione della schiavitù e il paradosso degli schiavi liberati ma mai risarciti offre un bell’esempio di come l’umanità progredisce spiritualmente, ogni conquista di un nuovo diritto emana un giudizio di condanna inappellabile sul comportamento passato, ma paradossalmente lascia le sue sofferte vittime, all’epoca ancora vive, senza alcun risarcimento. Ogni nuova norma, legale o morale, smentisce e condanna la norma precedente, riflessione tanto paradossale quanto inappellabile. Ogni nuova normativa lascia alle spalle un esercito di vittime mai risarcite.

Vittime mai risarcite.
La normativa che regola le separazioni è in continua evoluzione, ciò vuole dire che ogni progresso ha lasciato indietro un esercito di vittime mai risarcite. Ad esempio, in Italia con la sentenza n. 46 del 1966 la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale la norma che conservava a carico del marito l’obbligo di mantenere la moglie, senza tener conto delle condizioni economiche di lei, quando i coniugi fossero consensualmente separati. Cosa si fece con tutti quelli che, fino al 1966, furono costretti a mantenere la moglie malgrado le agiate condizioni di lei? Nulla, non furono mai risarciti. Parimenti oggigiorno, ogni nuova sentenza della Cassazione in contraddizione con quelle precedenti determina inappellabilmente quanto quelle fossero sbagliate. «La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10035 del 2025, ha confermato un cambiamento profondo: chi non cerca lavoro non avrà l’assegno». «L’assegno divorzile non è un diritto automatico». Va bene, ma cosa si fa con tutti quelli che, fino al 2025, hanno dovuto pagare l’assegno malgrado la ex non cercasse lavoro? Come vengono risarciti gli ex coniugi che hanno dovuto versare l’assegno quando per la giurisprudenza l’assegno divorzile era ancora una diritto automatico? Evidentemente si tratta di “vittime” che hanno subito una grave ingiustizia, mai risarcite. Un’altra: «l’ex moglie con una laurea nel cassetto rischia di perdere l’assegno di mantenimento se, dopo la separazione, rifiuta sdegnata i lavori che non ritiene all’altezza delle sue aspettative. La Corte di cassazione (sentenza 5932) accoglie il ricorso dell’uomo per quanto riguardava la richiesta di rivedere l’importo di 1000 euro versato mensilmente in favore della sua ex signora». Con la sentenza 5932 – 2021 la Cassazione bacchetta la Corte d’Appello di Trieste per aver affermato che una donna laureata, abituata ad un alto tenore di vita, non può essere «condannata al banco di mescita o al badantato». Perfetto, e come vengono risarciti tutti quelli che, fino al 2021, hanno dovuto versare l’assegno all’ex moglie laureata che rifiutava lavori al di fuori delle sue aspettative? Ancora, «divorzio, è rivoluzione: per l’assegno non conta più il tenore di vita matrimoniale ma l’autosufficienza. Sentenza della Cassazione che stravolge una regola in vigore da 30 anni». OK, e per quelli che per 30 anni hanno dovuto subire l’ingiustizia di elargire versamenti per sostenere il tenore di vita delle ex?
Altri esempi. In Spagna, nel 2021 «la Corte Suprema stabilisce limiti agli alimenti dopo il divorzio. L’Alta Corte ritiene che sia necessario valutare se il beneficiario abbia la capacità di generare un reddito autonomo». D’accordo, ma quelli, prima del 2021, ai quali non era mai stato fissato un limite? Un altro, nel 2014 la Corte Suprema stabilì che «le coppie separate devono condividere i costi del trasferimento dei figli» (in pratica, bisogna fare a turno nel trasferimento dei figli, molto importante se vivono in località o regioni diverse). E quelli che, fino al 2014, hanno dovuto affrontare da soli i costi di spostamento, per poter stare con i figli? Ancora un altro, nel 2011 la Corte Suprema stabilì che «l’uso della casa familiare attribuito ai figli minori e al genitore affidatario in occasione del divorzio può estinguersi al raggiungimento della maggiore età di questi ultimi, anche se – e questo è l’importante – non hanno raggiunto l’indipendenza economica». In altre parole, la pratica comune che vedeva prolungare per anni il soggiorno gratuito delle madri nella proprietà del ex marito, giustificato dal bisogno economico dei figli maggiorenni, bisogno indotto o meno che fosse, viene fissato dal 2011 alla maggiore età dei figli. E per gli uomini che si sono visti privare le loro proprietà in queste condizioni prima del 2011? E così all’infinito, in numerose sentenze “rivoluzionarie”.

La “schiavitù del mantenimento”.
Lo stesso concetto della bigenitorialità, introdotto nella normativa italiana nel 2006 – senza entrare nel merito se i giudici abbiano corrotto o meno lo spirito della legge –, l’ammissione da parte del legislatore della sua importanza, solo dal 2006, vuol dire che molti genitori (la stragrande maggioranza padri), prima di quella data, sono stati privati dal diritto di esercitare la bigenitorialità. In che modo sono stati risarciti i padri ai quali i tribunali avevano sottratto ingiustamente i figli prima del 2006? E i figli, che sono cresciuti senza padri? In occidente, tutti gli articoli che analizzano l’evoluzione dei dati di affidamento dei figli, concordano sul fatto che l’affidamento esclusivo alle madri si sta riducendo significativamente (da circa il 90% negli anni ’80 del secolo scorso). In Spagna, ad esempio, nel 2013 era ancora il 72,2% (al padre il 5,57%), nel 2020 si era abbassato al 54,4% (al padre il 3,93%), il resto condiviso. Una tendenza simile in tutta Europa, compresa l’Italia. La conclusione di tutti questi articoli è che siamo sulla via giusta, la bigenitorialità. Di nuovo, senza entrare nel merito sulle differenze significative (54,4% rispetto a 3,93%) che continuano ad esistere nell’affidamento esclusivo a seconda del sesso dei genitori, se oggi siamo sulla “via giusta” vuol dire inoppugnabilmente che prima si era sulla “via sbagliata”, che gli affidamenti assegnati dai tribunali in passato era “ingiusti”.
In altre parole, se è più corretto assegnare “solo” un 54,4% di affidamenti esclusivi alle madri rispetto al 72,2% che venivano assegnati nel 2013, vuol dire che una parte importante di quei affidamenti del 2013 erano ingiusti e discriminatori. Lo stesso ragionamento dovrebbe essere applicato dall’inizio, da quando è stata introdotta la legge del divorzio e l’affidamento dei figli, a dimostrazione che da mezzo secolo la maggior parte degli affidamenti in esclusiva alle madri sono stati assegnati in maniera discriminatoria e “ingiusta”. In che modo possiamo ora risarcire tutti quei genitori che si sono visti sottrarre i figli dai tribunali, e tutti quei figli che sono cresciuti senza un genitore? Come è successo con la schiavitù, il giudizio morale di riprovazione non riesce a offuscare il nostro profondo stupore: sul serio ci sono voluti decenni prima di riconoscere il diritto dei figli a crescere con un padre e con una madre? Sul serio ci sono voluti 30 anni per ammettere che quando ci si separa non si deve mantenere il tenore di vita dell’altro? Sul serio ci sono voluti oltre trenta anni per convenire che non è giusto mantenere qualcuno che si rifiuta di lavorare, anche se si tratta della ex compagna sentimentale, anni per capire che gli assegni alimentari devono essere limitati nel tempo, o che i costi di trasferimento dei figli devono essere condivisi o che il proprietario dell’abitazione ha diritto a recuperare la proprietà quando i figli sono maggiorenni, e così via? Come è stato possibile perdere la ragionevolezza così a lungo? Come mai ci è voluto così tanto tempo per giungere a conclusioni così tanto ovvie? Come è stato possibile che le istituzioni abbiano perso così a lungo la ragione? Come è stato possibile recare tanta sofferenza a tante persone per tanto tempo? Eppure non è finita, quanto ci vorrà ancora per far sparire finalmente l’industria del divorzio? Quanti anni dovranno ancora aspettare gli uomini separati per veder abolire la «schiavitù del mantenimento»? Fin quando un padre rischierà di perdere, senza alcun colpa, i figli?

Risarciti con gli insulti.
Concludo con un’ultima riflessione, forse la più importante. Ipotizziamo per un attimo che nell’irragionevolezza della schiavitù, durante il Settecento e l’Ottocento – una schiavitù, come tutti sappiamo, che era basata sulla razza – fosse esistita anche un’ideologia dominante che avesse sostenuto la sottomissione e la discriminazione dei bianchi e la dominazione e il privilegio dei neri. Col senno di poi, tale ideologia (che storicamente non esisteva e non è mai esistita) si sarebbe rivelata una grande menzogna. L’esistenza della schiavitù e il riconoscimento della sua profonda ingiustizia, della sua necessaria abolizione, da parte di tutti, avrebbe dimostrato quanto tale ideologia fosse profondamente infondata. Ora, è giusto trasferire la stessa riflessione all’attualità. È inoppugnabile l’esistenza di un’ideologia dominante nella società, il femminismo, che sostiene la sottomissione e la discriminazione delle donne e la dominazione e il privilegio degli uomini. Un’ideologia che si è imposta prepotentemente dagli anni ’70 del secolo scorso fino ad oggi. Dall’altra parte, tutte le gravi ingiustizie che ho elencato precedentemente e che vengono pian piano corrette dalle istituzioni riguardano prepotentemente, per non dire unicamente, gli uomini. Sono gli uomini, non le donne, le vittime dell’istituzione e dell’industria del divorzio. Tutta l’evoluzione normativa, elencata precedentemente, tende a correggere ingiustizie che le stesse istituzioni hanno praticato per decenni a danno degli uomini, negli stessi decenni durate i quali le femministe e le istituzioni assegnavano alle donne la condizione di vittime in esclusiva. Le nuove sentenze dei tribunali, le nuove conquiste degli uomini nelle separazioni confermano in maniera inappellabile l’ingiustizia e la discriminazione che questi uomini sono stati costretti a vivere fino allora, ergo confermano la grande menzogna e profonda infondatezza del femminismo. Un esercito di vittime che, in questi anni, al posto di risarcimenti e scuse hanno incassato, grazie al femminismo, unicamente insulti: sessisti, maschilisti, prevaricatori, violenti, patriarcali, misogini…