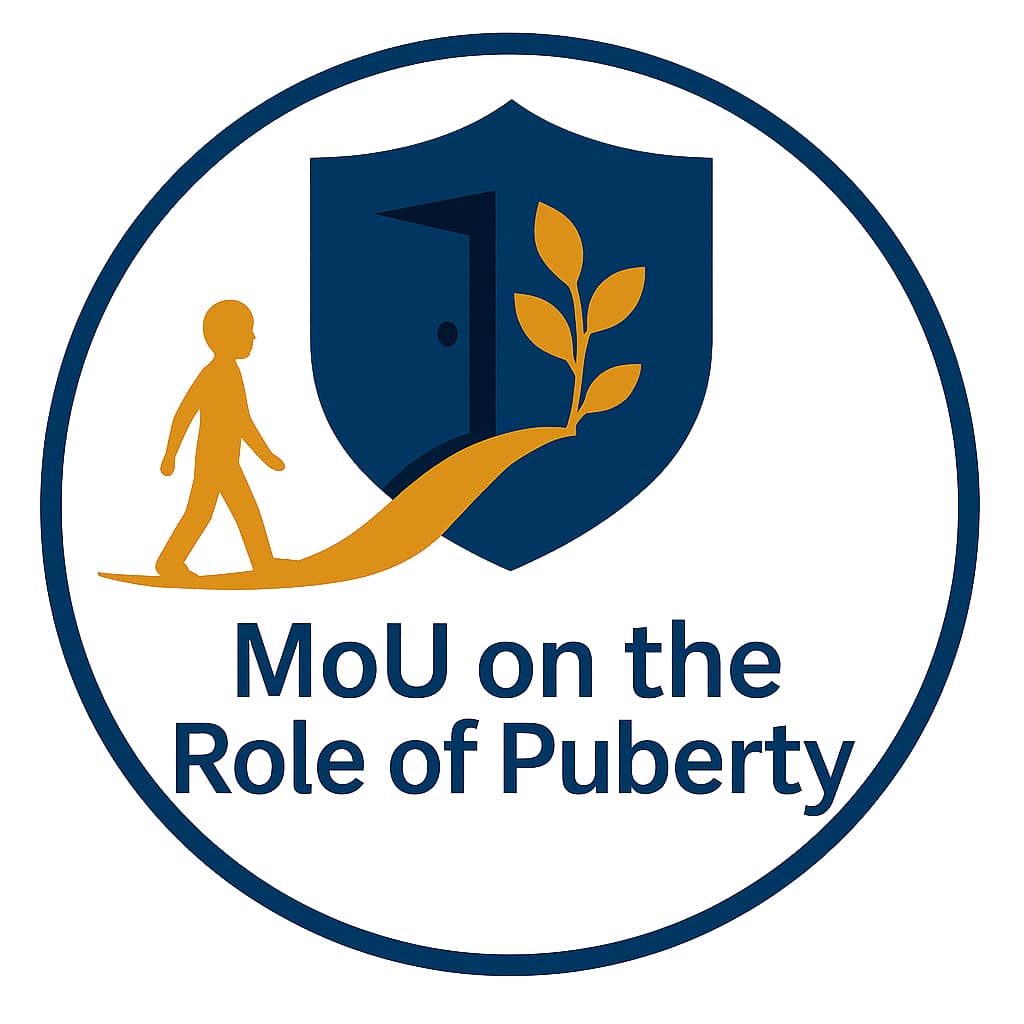«Esistono davvero poche filosofe?», si chiede il giornale la Repubblica. «Cosa ha perso il mondo impedendo al genere femminile di esprimere la propria voce?» (per il «mondo» immagino che il giornale intenda il mondo patriarcale, gli uomini). Secondo il giornale, «come è accaduto con varie discipline, il contributo delle donne al pensiero filosofico è stato ampiamente sottovalutato e volutamente ignorato per secoli». Per «restituire l’onore meritato» è stato pubblicato il Libro rosa della filosofia. «Filosofe pubbliche o private, filosofe mancate, filosofe perseguitate, filosofe famose o misconosciute, donne che sono scese in piazza a protestare e donne che hanno taciuto, ma hanno spronato le loro figlie a uscire di casa: è di loro, è di noi che si parla in questo libro. Il pensiero femminile non è mai mancato, è semplicemente stato ignorato da millenni di cultura patriarcale» scrive l’autrice, insegnate di storia e filosofia. Un libro quindi che non tratta unicamente di filosofia e di pensiero filosofico, «parla di noi», cioè delle donne, di tutte le donne, della sofferenza femminile in un mondo patriarcale. Non un saggio filosofico neutro dunque, è un libro rivendicativo, femminista. Parimenti in Spagna, per correggere «l’emarginazione subita dalle donne» nella filosofia, il Ministero dell’Istruzione ha modificato il programma scolastico. «La materia di Filosofia affronterà la storia del femminismo e porrà l’accento sulla discriminazione storica che ha comportato l’ingiusta emarginazione di molte filosofe da questa disciplina». «Si è voluto riparare la discriminazione storica nei confronti di quelle filosofe che sono state ingiustamente emarginate dal canone tradizionale per la sola condizione di essere donne», recita il testo ufficiale insegnato a scuola. Inoltre, «completato dall’attenzione riservata al pensiero femminista come una delle concezioni più rappresentative della storia recente delle idee».
E chi sono queste filosofe alle quali «la loro eredità è stata cancellata, oscurata, dimenticata» e meritano di essere recuperate? «Ce ne sono state molte». Nella filosofia greca e nell’Antichità, assieme a Socrate, Platone e Aristotele, si studia Aspasia di Mileto, o le pitagoriche Teano e Timica «e, naturalmente, Ipazia d’Alessandria, la più celebre nonché colei che pagò con la vita la sua emancipazione (fu uccisa da un gruppo di cristiani fondamentalisti che ritenevano scandalosa la sua condotta)», nota per il film realizzato sulla sua biografia. Nel Medioevo, figure come Ildegarda di Bingen, monaca e scienziata, e a quelle del Rinascimento, come Mary Astell. Nel XVII secolo le donne colte dei salons, i salotti letterari tanto in voga, ma anche le streghe: «possiamo considerare alcune delle donne tacciate di stregoneria come delle filosofe? Per certi versi sì. “Le voci delle streghe erano senz’altro delle voci contro, contro la miseria e la disuguaglianza, contro la società e le sue strutture, contro l’ordine egemone e imposto, contro le regole”, riflette l’autrice. “Ammesso che quella delle streghe fosse una filosofia, lo fu implicitamente”». Nella modernità, la prima ondata femminista con Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges, ma anche la scrittrice Madame de Staël, dopodiché le femministe Hubertine Auclert, Emmeline Pankhurst, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Germaine Greer, Luce Irigaray, Judith Butler, ecc. e altre come Hannah Arendt, Simone Weil o María Zambrano.
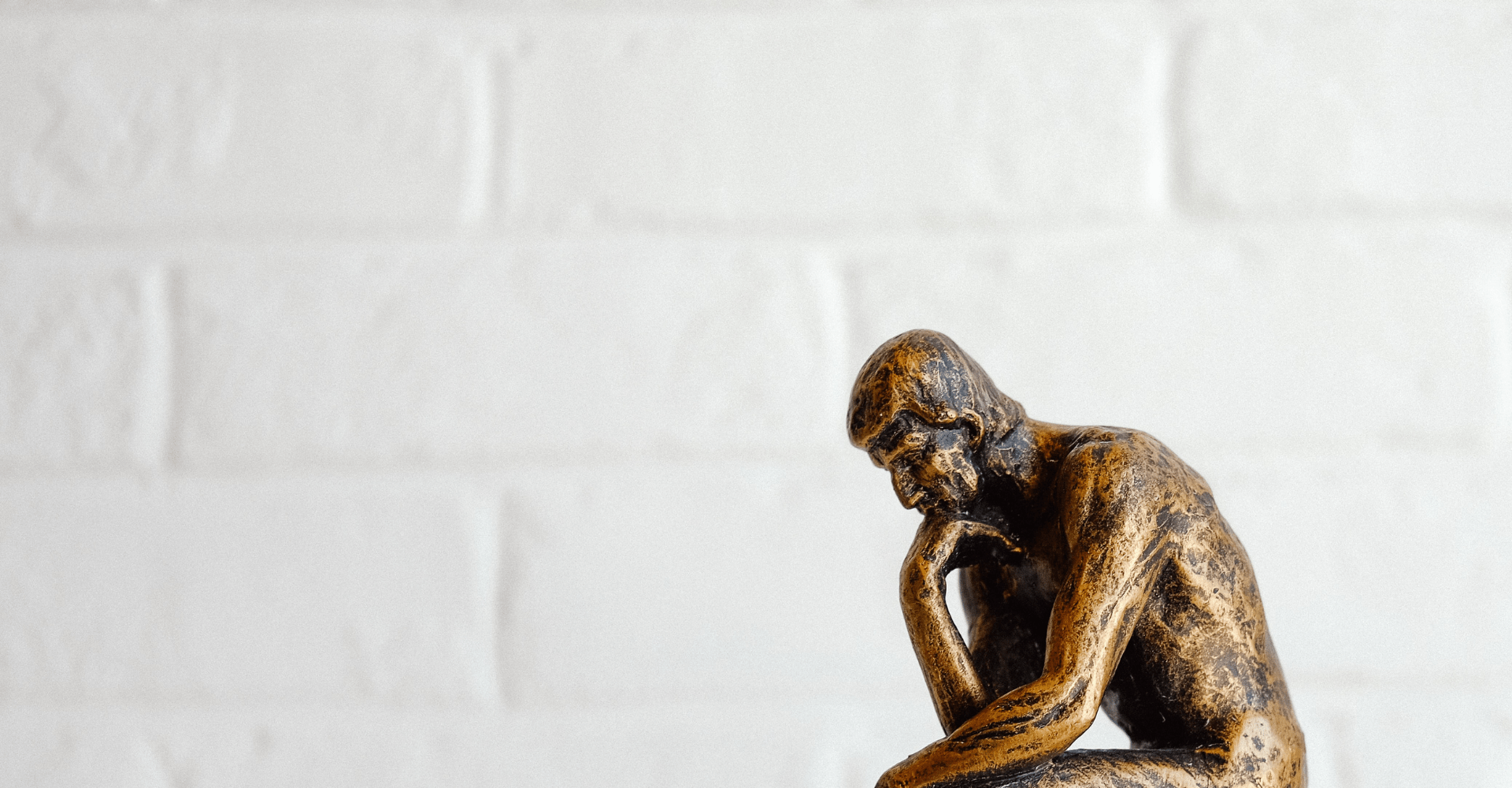
Il piagnisteo filosofico.
«Naturalmente le filosofe sono, storicamente, effettivamente meno della loro controparte maschile, ma le ragioni stanno nella loro impossibilità di studiare, di avere un’educazione, di disquisire pubblicamente, di partecipare ai convegni, di “praticare” come invece potevano fare i filosofi di mestiere». Donne che «hanno avuto a disposizione meno mezzi e hanno dovuto percorrere strade ben più accidentate rispetto alle controparti maschili». Sostiene l’autrice, «hanno filosofato in privato non potendolo fare in pubblico, ma malgrado tutto sono esistite innumerevoli donne coraggiose che non si sono lasciate abbattere dalle difficoltà e sono andate avanti dritte per la loro strada, talvolta rischiando (e perdendo) addirittura la vita». «Perché alle donne fossero concesse certe possibilità sono occorsi millenni, e nemmeno oggi, salvo rari casi, possiamo affermare di trovarci di fronte alla parità di genere in questo senso». Non manca l’accusa agli uomini, ai filosofi misogini, «da Senofonte ad Aristotele, da Cicerone a Seneca, per non parlare dei filosofi cristiani, ma anche i più moderni Kant, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche…a sbarrare la strada al pensiero filosofico delle donne ci si sono messi intenzionalmente molti celebri uomini, fortemente convinti che il cervello alle donne non servisse poi a molto». In conclusione, «sono state le imposizioni della società patriarcale a fare la differenza, non le potenzialità dell’intelletto».
Da questa lunga e succosa introduzione possiamo trarre alcuni insegnamenti: 1. per «millenni la cultura patriarcale» ha oppresso e discriminato le donne in «varie discipline», il pensiero filosofico non è rimasta esente; 2. il pensiero e le idee sono sessuati, esiste un «pensiero femminile» e quindi un pensiero maschile; 3. il pensiero femminile inespresso rappresenta una «perdita per il mondo», ciò implica che il pensiero femminile procura sempre progresso, valori positivi, miglioramento, la possibilità contraria, che talvolta possa procurare un danno, non è affatto ipotizzata; 4. La storia delle donne in filosofia è una questione di genere, le filosofe sono state emarginate «in quanto donne»; 5. «ci sono state molte filosofe» e «naturalmente meno della controparte maschile», quindi ce ne sono state poche (non poteva mancare la solita contraddizione femminista); 6. ce ne sono state molte grazie al «coraggio» femminile; 8. ce ne sono state poche data l’impossibilità di studiare, di avere un’educazione…; 9. le strade percorse dalle filosofe sono state «ben più accidentate» rispetto ai filosofi, tanto da «perdere talvolta la vita» (cosa che evidentemente non è mai successo ai filosofi); 10. «Nemmeno oggi, salvo rari casi», la situazione è cambiata (ci auguriamo sinceramente che nessuna di loro rischi oggi la vita); 11. le streghe erano filosofe (e gli stregoni?); 12. molti pensatori celebri dell’antichità erano misogini; 13. se il contributo filosofico femminile è stato inferiore, è stato dovuto «alla società patriarcale, non alle potenzialità dell’intelletto» (né a un diverso interesse, aggiungo io); 14. il femminismo è una corrente filosofica, anzi, poiché il pensiero è sessuato, è la corrente filosofica delle donne, quella che stabilisce tra l’altro la verità dei tredici punti precedentemente elencati.

Le streghe filosofe…
Questa visione della storia della filosofia è, come minimo, parziale, viziata dal pregiudizio femminista, quando non completamente falsa. Ho deciso di iniziare una serie di interventi sul pensiero filosofico, su alcuni filosofi e sul loro pensiero, sempre in relazione con la questione maschile e il femminismo, in modo da smentire, punto per punto, quanto sopra enunciato. Prima di concludere, qualche breve pennellata su qualche punto che può essere facilmente contestato. Non ho mai capito la necessità del femminismo di infilare l’argomento “streghe” ovunque si parli di narrazione storica su qualsiasi tema. La maggior parte delle vittime della caccia alla stregoneria era gente ignorante, contadina, come mostrano tra l’altro gli atti delle persone interrogate. Ipotizzare che un numero significativo delle streghe fossero «voci contro la miseria e la disuguaglianza» – argomento che dovrebbe essere valido anche per gli stregoni (20% circa del totale delle vittime) –, e da ritenerle quindi per questo motivo “filosofe”, è un po’ troppo. Le migliaia di donne che durante il fenomeno storico della caccia alla stregoneria denunciavano le streghe, sono anche loro da considerare “filosofe” o antifilosofe? Al contrario delle streghe, erano queste donne «voci pro la miseria e la diseguaglianza»? Tutte le figure femminili elencate celebri dell’antichità, Aspasia di Mileto, Teano, Timica e Ipazia d’Alessandria, ma anche tante altre, la poetessa Saffo, la romana Cornelia o Monica, la madre di Sant’Agostino, sono arrivate a noi grazie a testimonianze maschili. Sono stati uomini, che ne parlano bene, a trasmettere la loro memoria, fatto che si sposa molto male con la tesi che sostiene la volontà maschile di voler silenziare le donne.
Come si sposa molto male la tesi della presunta poca o inesistente considerazione che hanno gli uomini delle donne con l’interazione aperta e l’interesse che mostrano per le loro opinioni: Monica dibatte con suo figlio Sant’Agostino; Cartesio mantiene uno scambio epistolare con Cristina di Svezia, con la quale approfondisce i suoi discorsi sull’etica; Galileo manda le sue lettere “copernicane” a Madama Cristina di Lorena; le tesi di Madame de Staël provocano un vivace dibattito, al quale partecipano autori (maschi), e così via. Nel XVIII secolo, i celebri salons letterari e filosofici sono gestiti dalle donne, ma misteriosamente l’opera creativa è prevalentemente maschile. Perché quelle donne colte, benestanti e libere non si concentrarono sulla ricerca e sulla creazione, così come fecero gli uomini? «Il secolo XVIII è caratterizzato dalla presenza dei “salotti” francesi, in minor misura italiani e tedeschi, luoghi di incontro del sapere, dove si svolgono discussioni di religione, politica, arte o letteratura. Le donne sono le organizzatrici e le animatrici. Malgrado questo ruolo da protagoniste, e una loro costante presenza, e volendo tralasciare la scienza, egemonizzata dagli uomini, il mondo delle lettere e pensiero filosofico non sforna la controparte femminile di Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D’Alembert, Condillac, Condorcet, Helvétius, La Mettrie, Jean Meslier, D’Holbach, Quesnay, Turgot, Kant, Lessing, Hume, Berkeley, Beccaria, Verri (Pietro e Alessandro), Cadalso, Feijoo, Moratín, ecc.; unica eccezione degna di nota è Madame de Stäel (1766-1817), che in realtà dovrebbe essere inscritta nel Romanticismo…» (tratto dall’opera La grande menzogna del femminismo, p. 873).

Il tormentone Ipazia.
«In Germania, il Romanticismo si sviluppò all’interno di piccole comunità letterarie, che furono anche cenacoli di vita comunitaria ed esperimenti di vita anticonvenzionale. Particolare importanza, all’interno di tali cenacoli, ebbero le donne, in posizione spesso dominante…» (tratto dall’opera Agorà 3, manuale di filosofia, Ottocento e Novecento, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2008, p. 25). Goethe, Schiller, i fratelli Schlegel, Schelling, Schleiermacher, Fichte, Hegel… niente da fare, tutti maschi. Secondo quanto esposto, le donne «filosofavano in privato non potendolo fare in pubblico». La citata Ildegarda di Bingen conferiva con vescovi e abati, nobili e principi. Nel 1147, il papa Eugenio III leggeva alcuni dei suoi scritti durante il sinodo di Treviri. Non era l’unica. Caterina da Siena mantenne una vivace e incisiva corrispondenza con papa Gregorio XI. Nel 1816 Madame de Stäel pubblicava liberamente i suoi pezzi nella rivista Biblioteca italiana; e così via. Spero che questi piccoli esempi possano bastare per ora a provare che non è tutto o bianco o nero, come il femminismo ci vorrebbe far credere. Chiudo con Ipazia d’Alessandria. Fu uccisa da un gruppo di cristiani parobolani, all’interno di un conflitto tra pagani, cristiani ed ebrei, che vide massacri, la cacciata degli ebrei dalla città e decine di vittime (scomparsi dal racconto femminista su Ipazia). Prima dell’omicidio di Ipazia, il prefetto rischiò di essere linciato, come successe a Ipazia, da un gruppo di cristiani parobalani. Prima dell’omicidio di Ipazia, fu torturato e ucciso il cristiano Ammonio (un altro uomo sparito dal racconto). L’omicidio, in quanto donna, di Ipazia non fu quindi un fatto isolato ma preceduto e probabilmente seguito da tante altre vittime, presumibilmente la stragrande maggioranza uomini. Dopo l’uccisione di Ipazia fu aperta un’inchiesta. Ad archiviarla, un’altra donna, l’imperatrice Elia Pulcheria. Il solito Patriarcato.