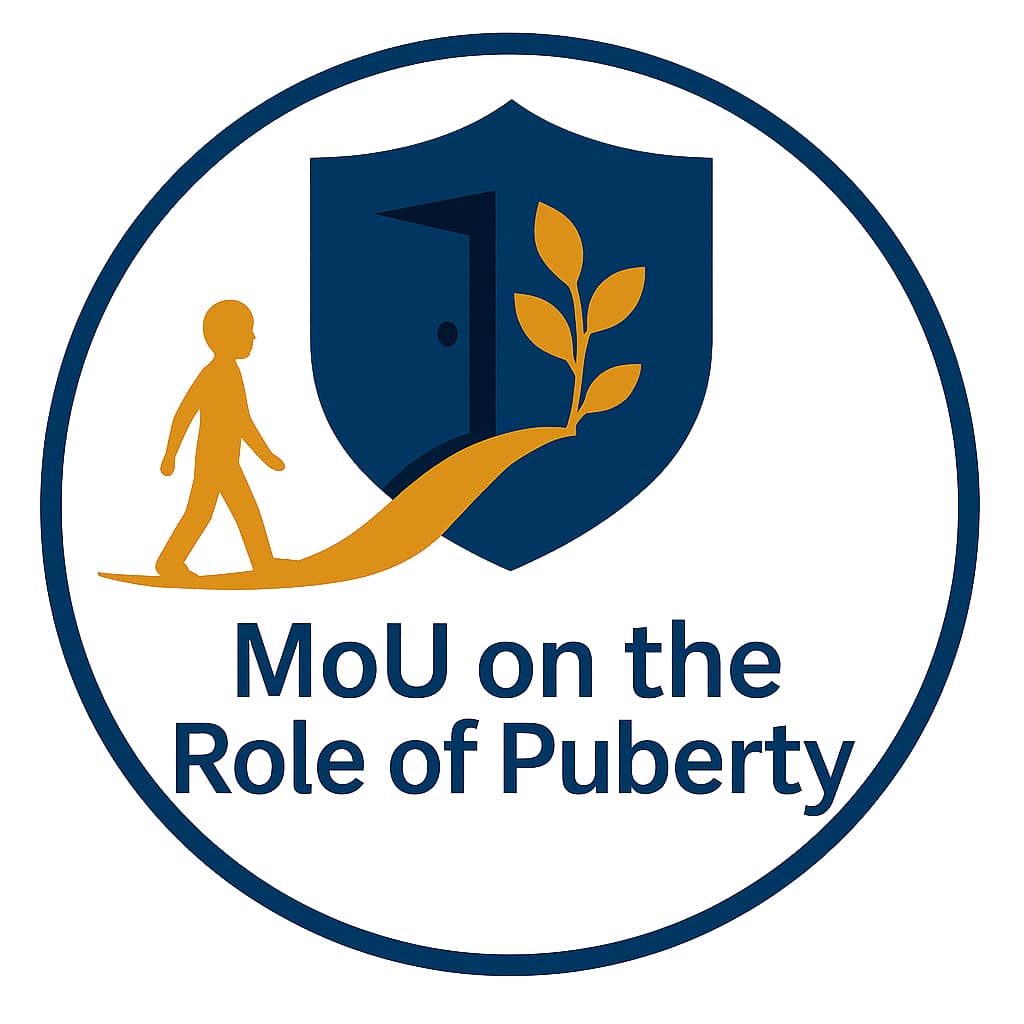Un modo semplice di vagliare la fondatezza della narrazione storica femminista consiste nel risalire alle fonti originali della storia (lettere, autobiografie, dipinti…) o ai libri storici che fanno uso di questi fonti e non sono stati ancora inquinati dall’ideologia femminista. Queste fonti e questi testi molto spesso fotografano una realtà che non combacia affatto con la visione monolitica proclamata dalla narrazione femminista. Allo scopo di contestare il doppio standard sessuale – secondo quella narrazione femminista, una delle ingiustizie più radicate nelle strutture patriarcali –, mi sono servito nell’intervento precedente di un libro della scrittrice Natalia Ginzburg (1916–1991), La famiglia Manzoni. L’opera non si limita soltanto a descrivere comportamenti femminili nell’ambio della coppia sostanzialmente liberi (le donne della famiglia Manzoni convivono senza sposarsi e decidono di non farlo, stroncano relazioni, «piantano» i loro compagni sentimentali o declinano offerte di matrimonio), offre pure altri spunti di riflessione, in altri ambiti, che meritano di essere sviluppati. Anche in questo intervento trascriverò citazioni testuali dal libro (Einaudi editori, Torino, 1983), corsivi miei.
A proposito del matrimonio, della maternità e della vita familiare: «Il 31 di marzo di quell’anno, Sofia morì. […] Fu, come Cristina , felice nel matrimonio. Aveva un marito affettuoso, tenero, delicato, e quattro amati bambini. Aveva davanti a sé paesaggi lieti, colorati, festosi, popolati di facce amiche, di parenti solleciti, e prodigava la sua attenzione agli altri, ai fratelli, ai bambini che nascevano, agli oggetti e ai cibi che riceveva e mandava» (p. 197). L’ideologia femminista ha elencato il matrimonio, la maternità e la famiglia tra le istituzioni patriarcali che opprimevano le donne e che dovrebbero essere annientate. La visione sostanzialmente soddisfatta e felice di Sofia o di Cristina nel matrimonio e nella vita familiare non si discosta da quella della scrittrice Virginia Woolf, già approfondita qui. Siamo molto lontani dall’immagine del marito prevaricatore e violento diffusa dalla narrazione femminista. Lo stato di «felicità» di queste donne non risiede solo nel matrimonio ma nel modo di vita, nelle libere uscite, nelle attività, nella compagnia: «Vittoria si divertiva, le giornate volavano; lei e la tante avevano molte visite e molti inviti; facevano lunghe passeggiate, a piedi e in carrozza. […] Vittoria era felice. […] “Mercoledì si fece una famosa cavalcata alle Cascine, e arrivammo fino al mare: eravamo una bella comitiva, e ci siamo molto divertiti”» (pp. 214, 215).

Il patriarcato non torna.
Anche la madre di Manzoni, Giulia, era stata felice. «Giulia, a Parigi, viveva felice. […] Viveva con un uomo bello – Carlo Imbonati era bello –, ricco, ammirato e stimato da tutti. Abitavano in una bella casa, in un bel quartiere, in place Vendôme. Avevano molti amici. Il suo proprio cognome d’origine, Beccaria, d’improvviso le piacque, essendo noto a tutti nei circoli culturali e mondani. Era accolta ovunque cordialmente e festosamente. Ognuno ricordava la figura di suo padre, e il famoso libro Dei delitti e delle pene» (p. 11). Questa felicità contrasta con la condizione di “schiavitù” delle donne descritta dalla narrazione storica femminista. Nessuna di queste donne si lamenta della propria condizione, al contrario. Ecco la vita di una “schiava”: « …aveva cinquantotto anni. Aveva quattro camerieri che si occupavano solo di lei: Laura; la signora Teresina, una certa Luisa, venuta da Bruzzano; e una nobile decaduta di Campolungo, chiamata Elisa Cermelli. […] Ciascuna aveva un compito particolare: pettinarla, vestirla, calzarla, eseguire i suggerimenti del dottor…» (p. 304). Nella famiglia Manzoni le beghe familiari non mancano: «Giulia aveva intentato causa al padre per ottenere il diritto di successione nella quota dei beni della madre; separatasi dal marito, si diede a questa procedura giudiziaria con più passione. Presentò contro il padre un lungo memoriale d’accusa» (pp. 10-11). Uomini soggetti alla legge come le donne, donne che fanno causa agli uomini, nessuna condizione di privilegio. Questa disputa legale dipinge piuttosto un quadro paradossale della condizione umana: la stessa figlia che fa causa al padre per motivi economici, non trova nulla di sbagliato nel vantarsi e approfittare successivamente del cognome paterno e della celebrità del padre nelle sue relazioni sociali.
A proposito dell’istruzione: «Giulietta a Fauriel […] Le mie sorelle fanno progressi nella musica, hanno come Pietro un maestro di francese, storia e geografia. Pietro ne ha parecchi altri, fa molti progressi in tutto nel fisico e nel morale» (p. 88). Nessun lamento delle donne su una presunta istruzione discriminatoria o asimmetrica; forse perché gli interessi di uomini e donne sono (e sono sempre stati) sostanzialmente diversi? «Enrichetta fu portata alla Maisonnette […]. Ma lei alla Maisonnette s’annoiava; Alessandro e Fauriel s’appartavano a parlare di letteratura e di filosofia; Giulia e Sophie de Condorcet chiacchieravano fra loro di gente di Parigi, a lei sconosciuta» (p. 25). Tutti e tutte erano parimenti istruiti e colti, ma gli uomini parlavano «di letteratura e di filosofia», le donne preferivano «chiacchierare di gente di Parigi»: le donne sceglievano il pettegolezzo. A proposito dell’amore per gli acquisti: «Teresa a Stefano : “Ho pensato di comperare comperare e poi comperare un cantarà, un trumò, un qualche coso a cassettoni, antico ma bono, bello e fatto e finito da un secolo…”» (p. 195). Secondo la narrazione storica femminista l’asimmetrica partecipazione dei sessi alla costruzione del mondo non sarebbe stata dovuta a interessi diversi ma alla discriminazione e all’oppressione che avrebbero subito le donne. A quanto pare, non nella famiglia Manzoni.

Donne oppresse da donne.
A dir la verità, un (unico) lamento, in tutto il libro, della condizione femminile c’è: «: “…per fortuna la mamma ha trovato la moglie d’un pittore che anche lei s’annoia e si tengono compagnia, altrimenti non vedevo l’ora di ripartire e maledicevo la mia vita e soprattutto la detestabile scatola dove a Dio è piaciuto chiudermi, perché se fossi un uomo, vi domando un po’ se sarebbe necessario che la mamma e io fossimo inchiodate insieme. Ah! Se mi chiedessero: Volete essere donna o galeotto? Subito direi. Viva la galera!… Sono come una bella aquila in una piccola gabbia, ma basta bisogna rassegnarsi”» (p. 76). Ci sono talvolta lungo la Storia esternazioni simili, donne che idealizzano la condizione maschile e desidererebbero di essere uomini. Abbiamo già approfondito in altre occasioni l’origine di questo sentimento, se sia fondato oppure il risultato di semplice “invidia”, quando ad esempio Virginia Woolf si augurava di essere uomo per andare in guerra o per andare a lavorare in ufficio comodamente. Esternazioni che esprimono un pensiero infantilizzato, un’ignoranza assoluta delle reali condizioni in questi ambiti e una mancanza di empatia profonda per gli uomini che erano sottoposti a tali attività. Evidentemente Mary Clarke non aveva alcuna consapevolezza della condizione, all’epoca, dei galeotti, e se ne fregava altamente. Un pensiero infantilizzato simile a quello che esprimevano le donne quando idealizzavano le guerre e appellavano agli eroi, agli uomini che, così facendo, mandavano a morire in esse: « Teresa a Stefano: “Letizia Allegria! Memoranda eterna gloria ai milanesi del 22 al 23 marzo 1848. Sono andati!” […] “O che milanesi bravi, eroi! Unici al mondo, superiori cento volte ai parigini des trois journées! Popolo di eroi, degno dell’Italia romana!”» (pp. 240, 241).
Ma ciò che stupisce di più dell’esternazione di Mary Clarke è la ragione della sua condizione, il motivo della sua limitata libertà: un’altra donna. Mary Clarke si sente oppressa perché non riesce a “liberarsi” da sua madre. L’oppressore sarebbe un’altra donna (!), dove è il Patriarcato? Cosa c’entrano gli uomini? Questo lamento ricorda tante altre oppressioni patriarcali, elencate dall’ideologia femminista, esercitate principalmente da altre donne. A proposito della combinazione di matrimoni e la libertà di scelta: «Sua madre , la marchesa Cristina Morozzo di Bianzè, era una donna di carattere forte; egli ne subiva l’influsso e le era molto legato. A spingerlo a quell’idea matrimoniale, erano stati in verità, la madre e il fratello Roberto insieme. Adesso la madre era in ansia. Aveva chiesto informazioni particolareggiate “su quella giovane e famiglia”» (p. 114). La madre di Massimo fa, combina, si informa, è la protagonista principale della riuscita del matrimonio, come lo era stata, dall’altra parte, Giulia, la nonna di Giulietta, e «in casa la persona più autorevole». Insomma, vizi femminili, colpe maschili. Senza riflettere molto, mi viene in mente l’infibulazione, una tradizione promossa principalmente dalle donne. Oppure l’amore romantico, tante volte criticato dal femminismo e passionalmente vissuto da molte di loro, come fecero Mary Wollstonecraft oppure Simone de Beauvoir, e in questo caso nella famiglia Manzoni, da tante Louise, che soffre profondamente per la mancanza del marito: «Morì, il 4 settembre, a Milano, Enrico Blondel; la moglie, tante Louise, alla sua morte cercò di avvelenarsi» (p. 112). Impossibile non deviare il pensiero verso le suttee, verso le vedove che volontariamente si immolavano in India assieme al marito defunto, …altre colpe maschili.
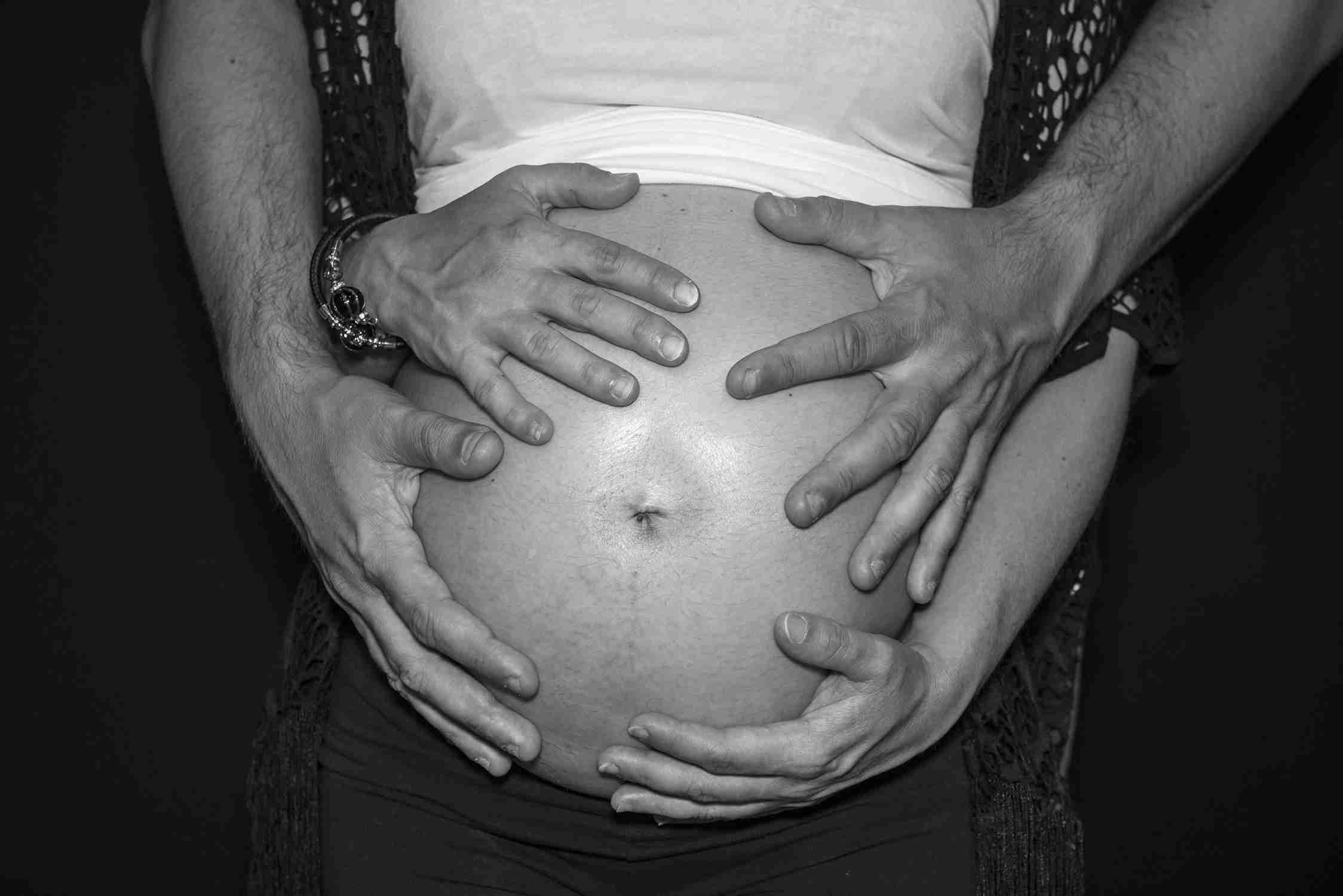
Il tumore che non era tumore.
Il sospetto che questo sentimento di disagio, o di “invidia”, femminile per la condizione maschile, possa derivare dalla biologia, è un sospetto già accennato in altri interventi. Su questo punto trovo molto interessante questo stupefacente passaggio del libro: «Teresa, ai primi di settembre, s’ammalò. Da un pezzo stava male, si sentiva “debolissimamente rotta a bocconcini, a minuzzoli”. […] Teresa chiamò il dottor Mazzola, che anni prima l’aveva operata di tonsille. Poi vennero chiamati altri medici. Fu diagnosticato un tumore. Racconta Stefano Stampa: “Per conseguenza la povera donna fu curata a frizioni mercuriali e di jodio; ma il tumore cresceva invece di calare, e la salute peggiorava…”. Passavano i mesi dell’inverno e Teresa era sempre più sofferente. I medici le tastavano il ventre duro e gonfio, vi avvertivano dei movimenti e questi erano, secondo loro, “borborigmi delle sottoposte intestina che a volte sollevano il tumore o lo scotevano”. Nella notte fra il 7 e l’8 febbraio, essa fu colta da dolori atroci. Era il tumore che scoppiava, dissero i medici. Le fecero dei salassi. Era la fine, dissero. Lei lo credette e lo annunciò al figlio “con un triste sorriso”. A un tratto s’accorsero tutti che aveva le doglie del parto. Il primo medico, Mazzola, a suo tempo aveva avanzato l’ipotesi di una gravidanza, ma con scarsa convinzione, per l’età di Teresa (aveva quarantacinque anni) e d’altronde gli altri subito avevano parlato del tumore. Nacquero due gemelle» (pp. 195-196). Il passaggio descrive una condizione biologica femminile difficile, tenuto tra l’altro conto delle conoscenze mediche dell’epoca, in qualche modo una conferma delle maggiori difficoltà delle donne a sopravvivere senza aiuto esterno.
Concludo con questo passaggio, a proposito del carattere pacifico, mite, piacevole e paziente delle donne: «Il cameriere Clemente Vismara, cameriere in casa ormai da molti anni, detestava Teresa , e anche lei lo detestava. Riguardo al “caldino della stanza da pranzo”, egli riferì, più tardi, questo suo ricordo. […] Dopo mangiare s’era messa a smaniare, e aveva fatto una scenata a Clemente, perché la stufa mandava troppo calore. Se n’era andata infuriata. Manzoni era rimasto solo col cameriere. Gli disse: “Clemente, fate in modo che la stufa bruci meno”. “Non posso” Clemente rispose. “Perché?” “Perché non è accesa affatto”. Secondo Clemente Vismara, Teresa della servitù era chiamata “Donna Stramba” e tutti la detestavano come lui» (p. 309). Affascinante aneddoto, Teresa «si infuria», si sente a disagio, la stanza è troppo calda perché Clemente tiene la stufa troppo alta. In una dialettica di conflitto, lei è una vittima, Clemente il colpevole oppressore. Eppure, fa notare Clemente, la stufa «non è accesa affatto». Che sia questa una plausibile spiegazione del fenomeno del femminismo, che di fronte all’oppressione, ai matrimoni combinati, alla discriminazione, al divieto di istruzione, all’infibulazione, alle suttee e a tante altre lamentele femministe, la “stufa” sia in realtà semplicemente spenta?