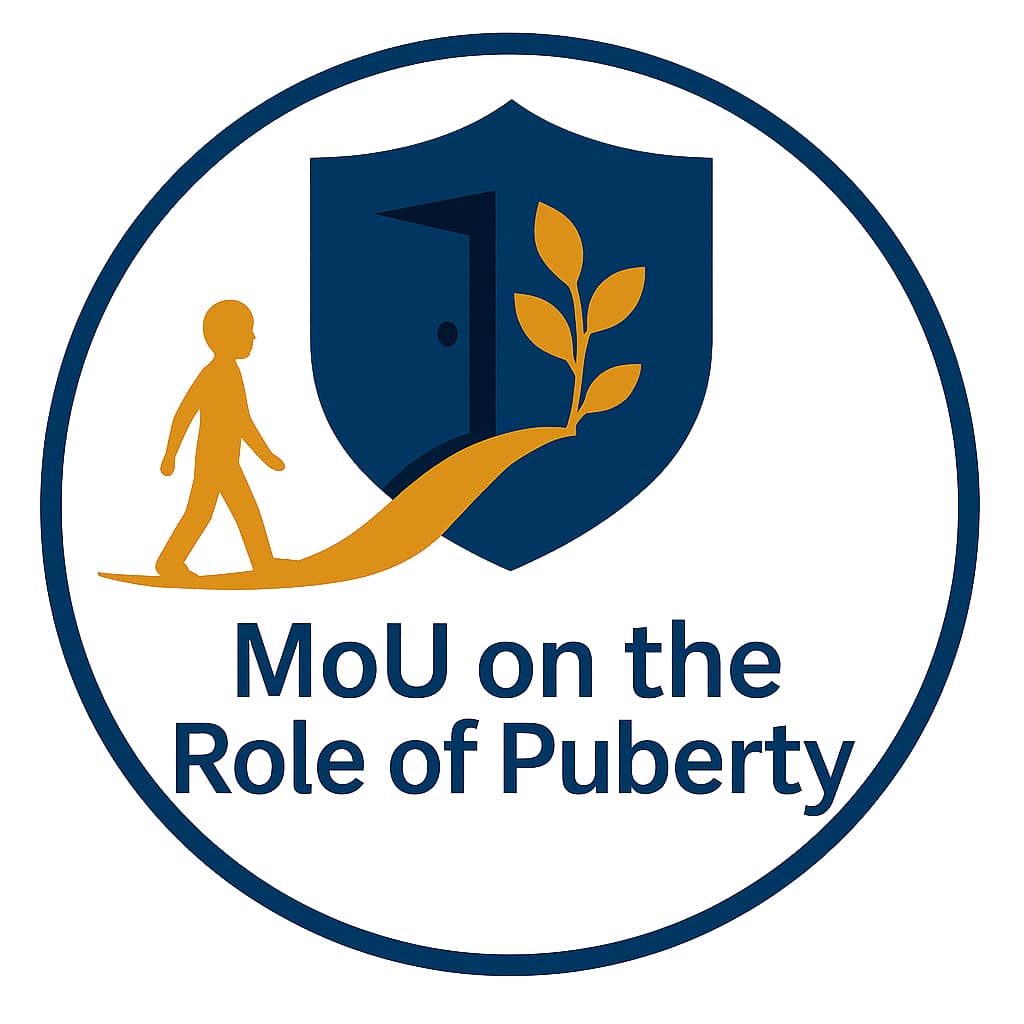Il matrimonio è basato sul dono – almeno così mi hanno sempre detto e così credevo prima di aver conosciuto i tribunali del divorzio. Come l’amicizia. I favori agli amici non vengono fatti in cambio di una controprestazione, ma fatti perché sono amici. Nessuno passa successivamente la fattura all’amico, che amicizia sarebbe? Al massimo, si decide di interrompere l’amicizia perché si ritiene che l’amico non si comporti da amico. Se in nome di una falsa amicizia viene recato un grave danno, non si tratta più di un’amicizia, si chiama truffa ed è disciplinato nel codice penale. Stessa situazione avviene per qualsiasi azione che possa sconfinare nel penale, come la violenza. Il matrimonio dovrebbe agire allo stesso modo dell’amicizia, in fondo si tratta di un’amicizia più intima basata sulla collaborazione tra un uomo e una donna. Se a un certo punto il rapporto matrimoniale non soddisfa più, dovrebbe essere molto semplice, come nell’amicizia, si interrompe e ognuno per la sua strada. Ma non succede così. Misteriosamente la legge e i tribunali del divorzio stabiliscono che quando due coniugi si separano deve essere fatto un bilancio delle azioni e delle decisioni passate. Qui iniziano le perplessità. Primo, se il matrimonio deve essere sottoposto a un bilancio a posteriori e passare il conto, dove a una parte tocca essere saldata per quanto realizzato previamente e all’altra pagare, allora non si tratta più di un dono. L’essenza del dono è la gratuità. Le note promesse matrimoniali, recitate durante il rito religioso, «di essere al tuo fianco per sempre, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita», diventano una farsa, una buffonata di dimensioni colossali. Se ogni volta che sei stato «in malattia», e ti ho assistito, o «in povertà», e ti ho aiutato, ti devo successivamente passare il conto, di che razza di «amore» o di «onore» si tratta?
Qualcuno potrebbe obiettare che questo succede ai creduloni che possiedono una fede e si lasciano guidare dai riti religiosi, ma la stessa identica cosa avviene nel rito civile. Durante la cerimonia, il celebrante (di solito un ufficiale di stato civile del Comune, come il sindaco o un suo delegato) legge gli articoli del Codice Civile relativi ai diritti e doveri reciproci dei coniugi, tra i quali l’articolo 143 che parla di assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione. I nubendi devono acconsentire. Recita l’articolo: «Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia». Insomma, il matrimonio è strutturato sul dono reciproco di due estranei che si alleano e mettono spontaneamente a disposizione i propri mezzi o le proprie risorse a vantaggio di tutto il nucleo familiare. Successivamente però, i tribunali del divorzio fanno carta straccia di quanto enunciato nell’articolo. I nubendi si sposano convinti dell’efficacia di quanto è stato a loro riferito da un pubblico ufficiale, ma si tratta in realtà di una beffa, un falso ideologico, una truffa, un inganno, una frode, un imbroglio organizzato e gestito dallo Stato a danno degli incauti cittadini.

Un bilancio asimmetrico.
D’altra parte, il matrimonio è l’unico contratto al mondo dove il trasgressore dell’accordo può anche non essere punito, o addirittura, al di là della logica, premiato. Leggi e giudici incoraggiano a violare gli accordi convenuti, al contrario di chi si mantiene fermo ai giuramenti presi, che rischia di perdere i figli, la propria casa, i risparmi, i futuri risparmi e la libertà, e di essere perseguito come un criminale senza aver violato nessun accordo né aver mai infranto prima d’allora la legge. Tutte le promesse e tutti gli articoli recitati durante la cerimonia del matrimonio sono carta straccia, una presa in giro madornale. Seconda perplessità, come è possibile fare un bilancio di anni di momenti, decisioni, impulsi, azioni, pensieri, sentimenti, vissuti molti di loro nella più profonda intimità? Come è possibile che un individuo, il giudicante, in questione di minuti, se siamo generosi ore, possa fare questo bilancio? Come è possibile calcolare economicamente, negli anni di matrimonio, le volte che l’uno ha pagato la pizza all’altra, lavato i piatti, andato a lavorare, alzato la notte per badare ai figli, il tempo di guida in auto nei viaggi di coppia, o la protezione della famiglia dal vicino adirato grazie alla massiccia presenza allenata nelle numerose sedute serali in palestra, cioè come calcola il giudicante la funzione di “bodyguard” grazie alle sedute serali annuali in palestra, che nel mondo lavorativo è un lavoro reale? Come si fa a giudicare il vissuto di una vita intera? Tutti siamo chiamati a rispondere nel giudizio finale della nostra vita, davanti a un essere onnisciente, almeno così ci dicono le Scritture. Ma i tribunali del divorzio si sono arrogati questo potere, il potere di essere onniscienti e di sbrigare in pochi minuti i vissuti più profondi di anni di vita. Può essere concepita maggiore superbia nella natura umana? Il bilancio di una vita matrimoniale non è possibile e l’esito sarà necessariamente tutto tranne che giusto.
Arrivati a questo punto sorge la terza perplessità. Se i tribunali del divorzio snaturano la vera essenza del matrimonio e producono un bilancio che è impossibile che possano produrre, come è possibile che a lamentarsi siano quasi in esclusiva gli uomini? La logica vorrebbe che questo perverso meccanismo dell’industria del divorzio colpisca tutti ma… il bilancio è asimmetrico, il giudizio è asimmetrico, l’industria del divorzio è asimmetrica. Il giudicante ha già deciso, deve soltanto decidere quanto danno vuole infliggere all’uomo. Innumerevoli sono gli esempi che possono essere fatti a prova di questa asimmetria, alcuni di loro da elencare progressivamente nei prossimi interventi, ma vorrei menzionare uno che mi sembra abbastanza chiaro e clamoroso. Una volta il matrimonio tipo consisteva prevalentemente in una famiglia monoreddito: il marito lavora all’esterno, la moglie fa il lavoro casalingo. Questa coppia decide di divorziare. Nel bilancio ci sono due colonne, nella prima le spese di mantenimento (mangiare, dormire in casa, vacanze, vestiti…) pagate grazie al lavoro retribuito e nella seconda il lavoro casalingo non retribuito. Ora, ci sono tre modi possibili di concepire il mondo. Nel primo le due colonne si equivalgono e si annullano, nulla è dovuto. Nel secondo, la prima colonna è molto più onerosa, la donna è stata mantenuta, ha sfruttato il lavoro dell’ex marito (da “parassita”, termine che usa Simone de Beauvoir per definire la condizione economica delle mogli! Ripeto, il termine non è mio, ma di Simone de Beauvoir, bisognerebbe rammentarlo ogni volta nei tribunali del divorzio) e dovrebbe risarcirlo. Nel terzo, la seconda colonna è quella più onerosa, il marito ha sfruttato il lavoro domestico della ex e deve risarcirla. Nei tribunali del divorzio il terzo modo è l’unico esistente, manca sempre la prima colonna. Avete mai sentito di una donna che è stata condannata a risarcire l’ex marito per essere stata mantenuta durante il matrimonio? Dove c’è scritto, in quale costituzione, in quale legge dell’umanità, che la terza visione deva prevalere sulla seconda?

Solidali solo nella ricchezza.
In Italia secondo la Cassazione, occuparsi della casa, consentendo al marito di svolgere la sua attività senza altre incombenze, è un lavoro che merita il dovuto riconoscimento al momento del divorzio. Dello stesso parere tutti i tribunali occidentali. Secondo la Cassazione in Portogallo, «l’esercizio dell’attività domestica si traduce in «un arricchimento del componente della coppia che non partecipa ai lavori domestici, in quanto gli consente di beneficiare dello svolgimento di tali attività senza costi né contributi» e quindi condanna l’ex marito a pagare 60.000 euro alla ex per i lavori domestici. In Spagna il Tribunale fissa un costo superiore, 88.000 euro a compensare alla ex per il lavoro domestico durante il matrimonio. Oppure 150.000 euro, a nulla valgono le obiezioni dell’ex marito, il fatto che si erano sposati in regime di separazione dei beni o il fatto che la donna avesse beneficiato di aiuto esterno nella realizzazione dei lavori domestici. Infatti, «il lavoro domestico non è solo una forma di contributo, ma costituisce anche un titolo per ottenere una compensazione al momento della cessazione del regime» matrimoniale. La giurisprudenza degli ultimi anni abbonda di sentenze cospicue e singolari. Ad esempio viene riportata quella di una donna con proprietà milionarie e 10 dipendenti (per i lavori domestici, le lezioni private dei figli o come autisti), alla quale è stato riconosciuto un sostanzioso risarcimento perché svolgeva la funzione di «coordinare» tutti quei lavoratori al suo servizio.
Le quantità sono mobili, come la donna nel “Rigoletto”, ora 204.624 € di compenso a beneficio della ex per il lavoro domestico e la cura della famiglia. Il risarcimento «presuppone innanzitutto il riconoscimento del lavoro di tutte quelle donne che sono nell’ombra e che senza dubbio rappresentano un sostegno fondamentale, personale, coniugale e familiare, per anni e anni di matrimonio, affinché colui che è stato loro marito, sviluppi una carriera professionale e un incremento patrimoniale di cui, al momento della rottura, esse non possono disporre». Se durante il matrimonio le ex hanno contribuito e guadagnato il diritto di beneficiare del successo e dell’incremento patrimoniale dei loro ex mariti, che ruolo svolgono le ex nei fallimenti? Dove sono le ex mogli condannate di modo solidario dai tribunali di divorzio a scontare anni di galera assieme ai loro ex mariti corrotti o negligenti, a subire anche loro i processi giudiziali per questioni lavorative, debiti o quant’altro, dove sono le ex mogli costrette a compensare all’ex marito nelle famiglie cadute in disgrazia economica? Perché le ex contribuiscono al successo del marito e l’insuccesso è soltanto di lui? Perché devono essere compensate quando il patrimonio cresce e non devono compensare quando il patrimonio decresce?

Indennizzi trentennali.
E ancora, se il lavoro casalingo è un lavoro remunerabile a posteriore, e non uno scambio all’insegna del dono, dove sono le compensazioni fissate dai tribunali per genitori, figli, fratelli? I figli adolescenti non danno mai una mano a casa? La sorella o il fratello maggiore non si occupano mai dei più piccoli? I figli non dovrebbero compensare i genitori per tutti gli anni di lavoro? La madre non dovrebbe compensare la figlia maggiore quando questa dà una mano? Per quale motivo legalmente la situazione riguarda soltanto la ex? L’industria del divorzio ci tratta da imbecilli ( e noi forse ce lo meritiamo). La maggior parte di noi ha vissuto da solo in alcun momento della vita, da studente, da single, da vedovo o da separato, e tutti siamo consapevoli della carica di lavoro casalingo che rappresenta giornalmente vivere da soli. Quanti di voi hanno impiegato otto ore giornaliere in queste faccende? Al di là che il carico di lavoro dipende della volontà individuale e soggettiva di ognuno di noi, scommetto che molti di voi sbrigavate queste faccende in poche ore giornaliere. Per quanto mi riguarda, il lavoro casalingo, se non ci sono dei figli piccoli, è l’ennesima sciocchezza inventata dal femminismo per colpevolizzare gli uomini e spillar loro dei soldi.
Quando gli uomini si impegnano in un contratto matrimoniale, così come è stabilito oggi, stanno in realtà firmando un contratto di schiavitù. La legge impone all’uomo “lavoro obbligatorio” in cambio di …nulla. Durante la durata del matrimonio, i tribunali non impongono alle mogli di fare una lavatrice o di preparare da mangiare. L’uomo invece, una volta finito il matrimonio, resta vincolato da obblighi verso la ex e rischia la galera per un periodo molto prolungato se inadempiente. La donna non rischia nulla, non ha alcun obbligo, né prima né dopo. Forse nel matrimonio la donna rischia il carcere se non prepara la cena? E dopo la separazione? Perché i tribunali regolano se il ex marito si dimette dal lavoro ma non regolano se la ex moglie fa o non fa la lavatrice? Un operaio che lavora 30 anni in un’azienda e viene licenziato ingiustificatamente può ricevere legalmente in Italia un tetto massimo di 24 mensilità di retribuzione. Una donna che si sposa per tre anni può ricevere dal ex marito gli alimenti per 30 anni, può cacciarlo di casa e sottrargli una fetta importante del patrimonio e della busta paga. Anche se adultera. Evidentemente gli operai non possono cacciare il datore di lavoro via da casa e appropriarsi del suo guadagno. Tranne se le impiegate sono le ex mogli: in Spagna se l’ex marito, datore di lavoro della ex moglie, decide di licenziarla, dovrà pagare in futuro lo stipendio integro in funzione di alimenti (cioè, posto fisso al di là della prestazione lavorativa futura di lei). Quale azienda sarebbe disposta a pagare un indennizzo per 30 anni a favore delle sue ex impiegate? Quale azienda tollererebbe l’imposizione da parte dello Stato di mantenere una ex lavoratrice per 30 anni? Bisognerebbe fare una profonda riflessione per capire per quale motivo in questa società qualsiasi operaio, che ha sacrificato la vita lavorando duramente, abbia molti meno diritti di una qualsiasi moglie fedifraga.