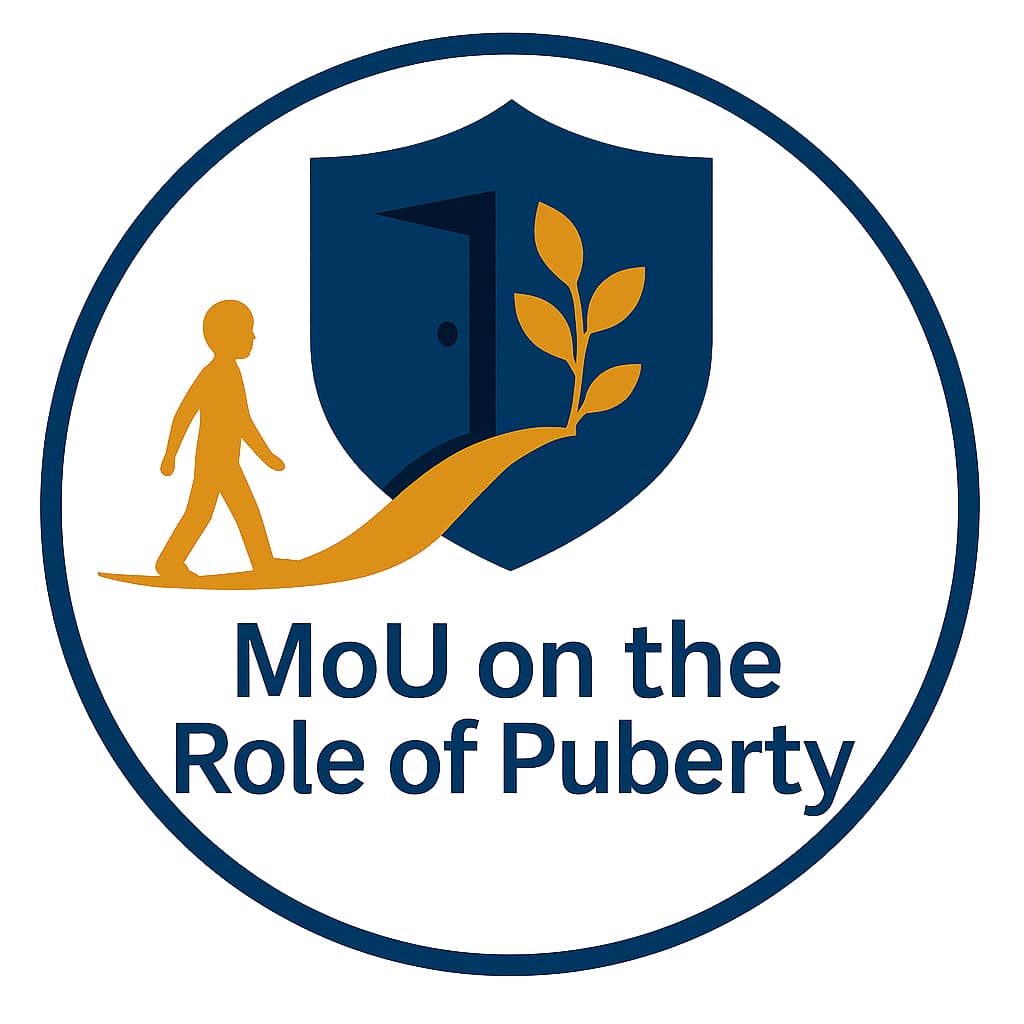Abbiamo trovato online questo splendido articolo di Filippo Chinnici e riteniamo assolutamente indispensabile rilanciarlo e diffonderlo. Abbiamo provato a contattare il sito originario dove è stato pubblicato per chiedere il permesso per la ripubblicazione, ma non abbiamo trovato indirizzi a cui rivolgerci. Se questa ripubblicazione pone problemi di copyright, l’autore o la testata che l’hanno pubblicato sono pregati di notificarcelo a lafionda.info@gmail.com. Sarà nostra cura prendere tutti i provvedimenti richiesti.
Articolo originale di Filippo Chinnici. |
Il 23 luglio 2025, il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità (161 voti favorevoli su 161 presenti) il disegno di legge n. 935‑B, che introduce nel Codice Penale l’articolo 577-bis, istituendo il reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo. In base alla nuova disposizione, è considerato femminicidio ogni omicidio commesso ai danni di una donna «per motivi di odio o discriminazione di genere, o per finalità di possesso, dominio, sopraffazione o controllo». [SkyTG24]
Dalla punizione del fatto alla repressione dell’intenzione
Con questo provvedimento, il diritto penale si allontana dalla propria natura originaria, fondata sulla punizione di atti obiettivamente accertabili, per entrare nell’ambito scivoloso della valutazione soggettiva del movente. Non si condanna più soltanto ciò che si è fatto, ma ciò che si presume si pensasse mentre lo si faceva. L’imputato non sarà giudicato soltanto per l’omicidio commesso, ma per l’interpretazione ideologica che si darà del suo gesto: si riterrà che abbia agito per motivi “patriarcali”, per odio di genere, o per volontà di dominio.
Ma chi stabilisce che l’omicidio è stato determinato da un movente di “odio identitario”? E quali strumenti oggettivi consentono di distinguere una dinamica relazionale conflittuale da una struttura ideologica latente? In assenza di prove documentali, confessioni esplicite o elementi certi, si apre inevitabilmente la strada a giudizi arbitrari, costruiti su ricostruzioni psicologiche a posteriori, suggestioni mediatiche o applicazioni forzate di teorie sociologiche al diritto penale.
La diseguaglianza giuridica tra vittime
Nel vigente ordinamento italiano, l’omicidio può già essere punito con l’ergastolo in presenza di aggravanti, come previsto dall’art. 576 c.p. La norma contempla circostanze specifiche, come l’uccisione del coniuge, del convivente o di un familiare stretto. L’introduzione del nuovo articolo 577-bis non colma un vuoto normativo, ma istituzionalizza una diseguaglianza punitiva tra vittime, fondata sul sesso biologico, e quindi sull’appartenenza identitaria.
Se un uomo uccide una donna, potrà essere condannato all’ergastolo in forza della nuova norma. Ma se una donna, in circostanze analoghe – ad esempio per vendetta, gelosia o volontà di dominio – uccide il proprio compagno, non ricadrà in alcuna fattispecie autonoma. Ne consegue che il reato di femminicidio è strutturalmente monodirezionale: può essere attribuito soltanto a un uomo, mai a una donna. Ciò viola apertamente il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito dall’art. 3 della Costituzione. [Rapporto Antigone 2024 – Il femminicidio come reato autonomo]
Il concetto di femminicidio tra sociologia e diritto
 Il termine femminicidio, ormai largamente diffuso nel dibattito pubblico e mediatico, non trova origine nella tradizione giuridica italiana, né è frutto di un’elaborazione dottrinaria interna al diritto penale. Si tratta, in realtà, di una categoria concettuale introdotta nell’ambito della criminologia anglosassone, in particolare dalla studiosa Diana Russell, che negli anni Novanta definì l’uccisione di una donna in quanto donna come la forma più estrema di una violenza sistemica, ambientale e culturale, radicata in strutture patriarcali.
Il termine femminicidio, ormai largamente diffuso nel dibattito pubblico e mediatico, non trova origine nella tradizione giuridica italiana, né è frutto di un’elaborazione dottrinaria interna al diritto penale. Si tratta, in realtà, di una categoria concettuale introdotta nell’ambito della criminologia anglosassone, in particolare dalla studiosa Diana Russell, che negli anni Novanta definì l’uccisione di una donna in quanto donna come la forma più estrema di una violenza sistemica, ambientale e culturale, radicata in strutture patriarcali.
In Italia, tale concetto è stato progressivamente recepito sul piano politico e mediatico, venendo assunto come categoria interpretativa privilegiata dei fatti di sangue che coinvolgono vittime femminili. Tuttavia, la nozione non è mai stata oggetto di una codificazione giuridica compiuta, e la sua adozione è avvenuta più per forza retorica che per solidità giuridica.
I dati ufficiali – in particolare quelli dell’ISTAT relativi all’anno 2023 – indicano che il 77 % delle donne uccise era legato da una relazione affettiva o familiare con l’autore del reato, nella quasi totalità dei casi un partner o ex partner (istat.it). Tali numeri suggeriscono che la matrice principale di questi omicidi è di natura relazionale, spesso legata a dinamiche di dipendenza, abbandono, possesso o gelosia, più che riconducibile a un odio strutturale verso il genere femminile.
Il medesimo orientamento emerge dall’XI Rapporto EURES (2023), secondo cui nei primi undici mesi del 2024 sono state uccise 99 donne, con una netta prevalenza di vittime ultra-sessantacinquenni e una diminuzione della componente straniera tra gli autori. Si tratta di un dato significativo, che conferma la tendenza della violenza omicida a manifestarsi in contesti di lunga prossimità emotiva o familiare, e non come esito diretto di un disegno ideologico misogino.
In tal senso, pur riconoscendo la legittimità degli intenti protettivi che hanno ispirato l’uso del termine, occorre constatare che la nozione di femminicidio rischia di trasporre nel diritto una lettura ideologica del fenomeno, presentandolo come manifestazione sistemica di una cultura patriarcale onnipresente. I dati, al contrario, sembrano indicare che la maggior parte dei femminicidi non risponde a un odio strutturale di genere, ma a relazioni personali deteriorate, dentro le quali la violenza agisce come atto estremo, spesso disperato, e non come espressione di una visione del mondo.
La deriva pedagogico-emotiva della giustizia penale
L’approvazione unanime del disegno di legge da parte del Senato, senza alcuna voce parlamentare dissenziente o anche solo cautamente critica, costituisce un segnale preoccupante sul piano democratico e culturale del Paese. Essa testimonia la subordinazione del legislatore alla pressione emotiva e morale dell’opinione pubblica, sempre più alimentata da narrazioni mediatiche e attivismo simbolico. Il timore, oggi sistemico, di essere accusati di insensibilità, complicità o mancanza di empatia verso le vittime ha finito per soffocare ogni forma di riflessione razionale, trasformando il processo legislativo in una liturgia collettiva dell’indignazione.
Come ha osservato con lucidità la prof.ssa Antonella Massaro, docente di Diritto penale all’Università Roma Tre, «la norma assume un forte valore simbolico, ma si espone a rilievi critici sul piano della coerenza costituzionale e della ragionevolezza giuridica» [Sistema Penale].
La legge, dunque, si pone più come risposta emotiva che come strumento normativo efficace, agendo sul piano della rappresentazione pubblica più che su quello della funzione preventiva. È l’ennesimo esempio di un diritto penale trasformato in codice morale, in cui la funzione repressiva non è più orientata alla giustizia, ma alla rassicurazione sociale.
Una coscienza programmata: chi ha costruito il concetto di “femminicidio”?
Il termine femminicidio è oggi divenuto un topos inscalfibile nel discorso pubblico, una sorta di parola sacra al riparo da ogni contestazione. Eppure, la sua ascesa nel lessico giuridico e mediatico non è stata spontanea, né motivata da una reale impennata statistica del fenomeno, bensì da un’operazione concertata su più livelli, che ha visto convergere media nazionali, organismi sovranazionali, accademie ideologizzate e strutture ministeriali. La coscienza collettiva è stata plasmata – e in larga parte, secondo me, indotta – da un processo eterodiretto, graduale, ma costante, i cui attori si sono mossi con coordinazione sorprendente.
Il primo strato di questa architettura è di natura mediatica. A partire dal 2012, il termine femminicidio entra prepotentemente nel vocabolario giornalistico, in corrispondenza con la ratifica della Convenzione di Istanbul (firmata nel 2011, ratificata in Italia nel 2013). Il quotidiano La Repubblica è tra i primi a usarlo con sistematicità, seguito da tutti gli altri del mainstream: Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, e da una lunga serie di rubriche televisive della RAI. Il linguaggio si fa sempre più emotivo, il lessico giuridico viene sostituito da categorie etico-morali, e l’attenzione si concentra su singoli casi resi esemplari, anche in assenza di una base statistica coerente.
A livello istituzionale, la spinta propulsiva viene dalla già citata Convenzione di Istanbul, emanata dal Consiglio d’Europa con l’obiettivo di contrastare la violenza domestica e «basata sul genere». Tale trattato, benché nobilmente motivato, introduce per la prima volta nel diritto internazionale europeo il concetto di «genere» come costruzione sociale dotata di efficacia normativa, imponendo agli Stati firmatari obblighi concreti in materia penale, educativa e sociale. L’Italia, ratificando il trattato nel 2013 (L. n. 77/2013), si è impegnata a riconoscere la violenza contro le donne come «manifestazione delle relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne».
A questa ratifica segue il Decreto-legge 93/2013, poi convertito nella Legge 119/2013, che introduce misure straordinarie contro la «violenza di genere», fondando una cornice normativa d’eccezione in cui si sovrappongono diritto penale, educazione scolastica e interventi sociali. Ma il cuore della questione non sta tanto nella norma in sé, quanto nella matrice ideologica che l’ha generata e nella rete che l’ha implementata.
A sostenere e promuovere questa struttura operano organismi sovranazionali e transgovernativi, come UN Women, UNFPA, il Consiglio d’Europa, la Commissione Europea, il CEDAW, e una costellazione di fondazioni collegate a interessi globalisti come ad esempio Open Society Foundations di Soros e la Ford Foundation. Questi enti non si limitano a consigliare, ma finanziano e condizionano direttamente la produzione culturale, accademica e normativa attraverso programmi come DAPHNE, Horizon 2020, Rights, Equality and Citizenship (REC) e Erasmus+.
Decine di milioni di euro sono stati erogati per sostenere centri antiviolenza, manuali scolastici, linee guida per l’educazione «di genere», corsi di aggiornamento per magistrati, docenti, operatori sociali.
In Italia, organizzazioni come D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), Telefono Rosa, UDI, e molte realtà femministe di matrice postmarxista, sono divenute interlocutori istituzionali privilegiati, ricevendo fondi pubblici e godendo di ampia visibilità presso i ministeri. Esse promuovono una lettura strutturalista della società secondo cui la violenza maschile non è un fatto, ma un’espressione inevitabile del dominio patriarcale. È una visione ideologica che rifiuta la responsabilità individuale in favore della colpa sistemica e che spesso non distingue tra reale e simbolico, tra dato e narrazione.
La ristrutturazione antropologica e la colpevolizzazione dell’identità maschile
Sul piano metapolitico, l’intera architettura ideologica che sostiene la retorica del femminicidio si inscrive in un disegno più vasto di ristrutturazione antropologica dell’Occidente, orientato alla decostruzione delle identità storiche – sessuali, familiari, culturali – che per secoli hanno fondato l’ordine simbolico e giuridico europeo. Si tratta di un processo strategico, promosso da centri sovranazionali, ambienti accademici e circuiti culturali egemoni, volto a sostituire i riferimenti stabili della soggettività con categorie fluide e vittimistiche, facilmente manipolabili a livello normativo e mediatico.
Nel cuore di tale metamorfosi si colloca la frammentazione delle identità tradizionali: la sessualità è ridotta a percezione soggettiva, la famiglia a costrutto negoziabile, la cultura a sovrastruttura da smantellare in nome dell’inclusività. Il risultato è l’introduzione di nuove categorie giuridicamente ambigue, articolate attorno alla dicotomia vittima–oppressore, e funzionali a una narrazione che deresponsabilizza alcuni e criminalizza altri non per ciò che fanno, ma per ciò che sono.
In questo nuovo ordine, la figura femminile non è più riconosciuta come soggetto morale e giuridico autonomo, ma elevata a simbolo permanente di vulnerabilità. La donna viene configurata come entità collettiva da tutelare in modo incondizionato, al di là del merito o del contesto, secondo un principio preventivo che la colloca fuori dalla logica paritaria del diritto. Questo dispositivo produce una deresponsabilizzazione sistemica, sottraendo alla persona la dignità di essere giudicata per le proprie azioni e trasformandola in icona politica.
Specularmente, l’uomo viene sempre più rappresentato come archetipo dell’oppressione, portatore presunto di dominio e violenza. Non è valutato per le sue scelte, ma per la sua appartenenza di genere. È un soggetto giuridicamente sospetto, da sorvegliare e rieducare. La colpa che gli si attribuisce è ontologica, non comportamentale: non deriva da ciò che compie, ma dalla sua stessa maschilità. Si assiste così a una torsione radicale del principio di giustizia, che smette di giudicare i fatti per condannare le identità.
 Non sorprende, dunque, che negli ultimi anni esponenti politici, accademici e membri del governo – tra cui il ministro Antonio Tajani – siano giunti a chiedere pubblicamente perdono per il solo fatto di essere uomini. Tali dichiarazioni, formulate con toni liturgici, rappresentano l’apice simbolico di un’inversione antropologica, nella quale la colpa individuale viene sostituita da una colpa identitaria collettiva, e la penitenza assume le sembianze di una religione laica della contrizione obbligatoria.
Non sorprende, dunque, che negli ultimi anni esponenti politici, accademici e membri del governo – tra cui il ministro Antonio Tajani – siano giunti a chiedere pubblicamente perdono per il solo fatto di essere uomini. Tali dichiarazioni, formulate con toni liturgici, rappresentano l’apice simbolico di un’inversione antropologica, nella quale la colpa individuale viene sostituita da una colpa identitaria collettiva, e la penitenza assume le sembianze di una religione laica della contrizione obbligatoria.
Questi atti, pur simbolici, producono effetti reali: diffondono l’idea che essere uomo costituisca di per sé una colpa latente, un reato morale in potenza. Ne deriva una colpevolizzazione preventiva della soggettività maschile, che altera le relazioni tra i sessi, condiziona i comportamenti e minaccia il principio stesso di reciprocità. Il diritto, da strumento di equità, si trasforma in veicolo di pedagogia ideologica, orientata non alla verità, ma alla rieducazione.
In questo quadro, il concetto di femminicidio rivela la sua natura autentica: non uno strumento di tutela, ma un dispositivo di controllo narrativo e normativo, concepito per ridefinire il patto sociale tra i sessi in termini asimmetrici. Non si mira più a contrastare la violenza, ma a riscrivere le categorie della colpa, del potere e della legittimità sociale, sulla base di un impianto ideologico che si nutre di paura e presunzione d’accusa.
Il femminicidio diventa così più che un concetto giuridico: esso si configura come un grimaldello politico, una parola-emblema attraverso cui si giustificano leggi d’eccezione, politiche selettive ed esclusioni culturali. Il diritto non protegge più le persone, ma plasma la società secondo una nuova grammatica del potere, in cui l’appartenenza prevale sulla responsabilità, e la giustizia cede il passo alla funzione pedagogica, simbolica e conformativa del potere.
Precedenti storici: il diritto fondato sull’appartenenza
Non è la prima volta che il diritto penale viene piegato a logiche identitarie. Si pensi al delitto d’onore (art. 587 c.p., abrogato nel 1981), che attenuava la pena per l’uomo che uccideva la moglie, la figlia o la sorella per «preservare l’onore familiare». In entrambi i casi, la giustizia cessava di basarsi su criteri oggettivi per diventare selettiva, individuale, ideologica.
Allo stesso modo, le leggi razziali del 1938 introdussero discriminazioni giuridiche sulla base dell’appartenenza etnica, imponendo un regime legale già segmentato nel diritto privato e penale.
Oggi, con l’articolo 577-bis, il criterio discriminante non è più il movente o la condotta, bensì il sesso biologico: non si valuta ciò che si è fatto, ma chi si è e chi si è ucciso. Come ai tempi dell’onore, non si giudica il fatto ma l’identità dell’agente e della vittima. [Treccani, voce «Onore»]
Quali alternative per una tutela autentica?
Un legislatore realmente orientato alla protezione delle vittime, e non semplicemente animato da esigenze di consenso o da impulsi simbolici, dovrebbe rivolgere il proprio impegno verso interventi strutturali e sistemici, capaci di incidere sulle radici profonde della violenza e non soltanto sui suoi effetti finali.
In primo luogo, sarebbe indispensabile un rafforzamento organico e capillare della rete territoriale dei centri antiviolenza, affinché questi non restino presìdi formali, ma divengano luoghi concreti di ascolto, protezione e ricostruzione dell’autonomia psico-sociale delle persone coinvolte. Questo implicherebbe anche una revisione dei criteri di finanziamento, spesso affidati a logiche clientelari o ideologiche, a scapito dell’efficacia reale.
In secondo luogo, occorrerebbe una riforma profonda della giustizia familiare, finalizzata a ridurre la conflittualità patologica nelle separazioni e ad affermare un principio di giustizia relazionale basato sulla responsabilità condivisa. Le guerre giudiziarie tra ex coniugi, alimentate da avvocati spregiudicati e dispositivi giuridici sbilanciati, producono un terreno fertile per l’odio e l’esplosione della violenza.
A ciò dovrebbe aggiungersi una trasformazione dell’impianto educativo scolastico, non limitata a slogan sulla parità, ma incentrata su percorsi di maturazione emotiva, alfabetizzazione affettiva e costruzione responsabile dell’identità personale. Senza una riforma pedagogica che parta dalla scuola primaria e coinvolga la famiglia, ogni intervento repressivo sarà destinato a fallire.
Infine, ma non per importanza, è necessario implementare forme di sostegno psicologico preventivo rivolte tanto agli uomini quanto alle donne in situazioni di disagio, isolamento, instabilità relazionale o perdita del controllo emotivo. L’intervento deve avvenire prima che la violenza esploda, in una logica di prevenzione reale e non meramente dichiarata.
La repressione penale, da sola, non previene la violenza: la sposta, talvolta la maschera, talvolta la aggrava. Una giustizia che voglia essere realmente equa e risolutiva non può limitarsi a punire il sintomo, ma deve curare la ferita invisibile che genera l’odio, la paura e la sopraffazione. Diversamente, si rischia di sostituire la violenza con nuove forme di squilibrio giuridico e sociale, mascherate da progresso.
Conclusione
Questa legge, lungi dall’essere una conquista civile, segna la crisi della neutralità giuridica. Non protegge la donna in quanto persona, ma la sacralizza in quanto categoria, generando nuove forme di ingiustizia. Punire in modo differenziato in base al sesso non è tutela: è discriminazione rovesciata.
E quando il diritto cessa di essere universale, diventa ideologia travestita da giustizia.