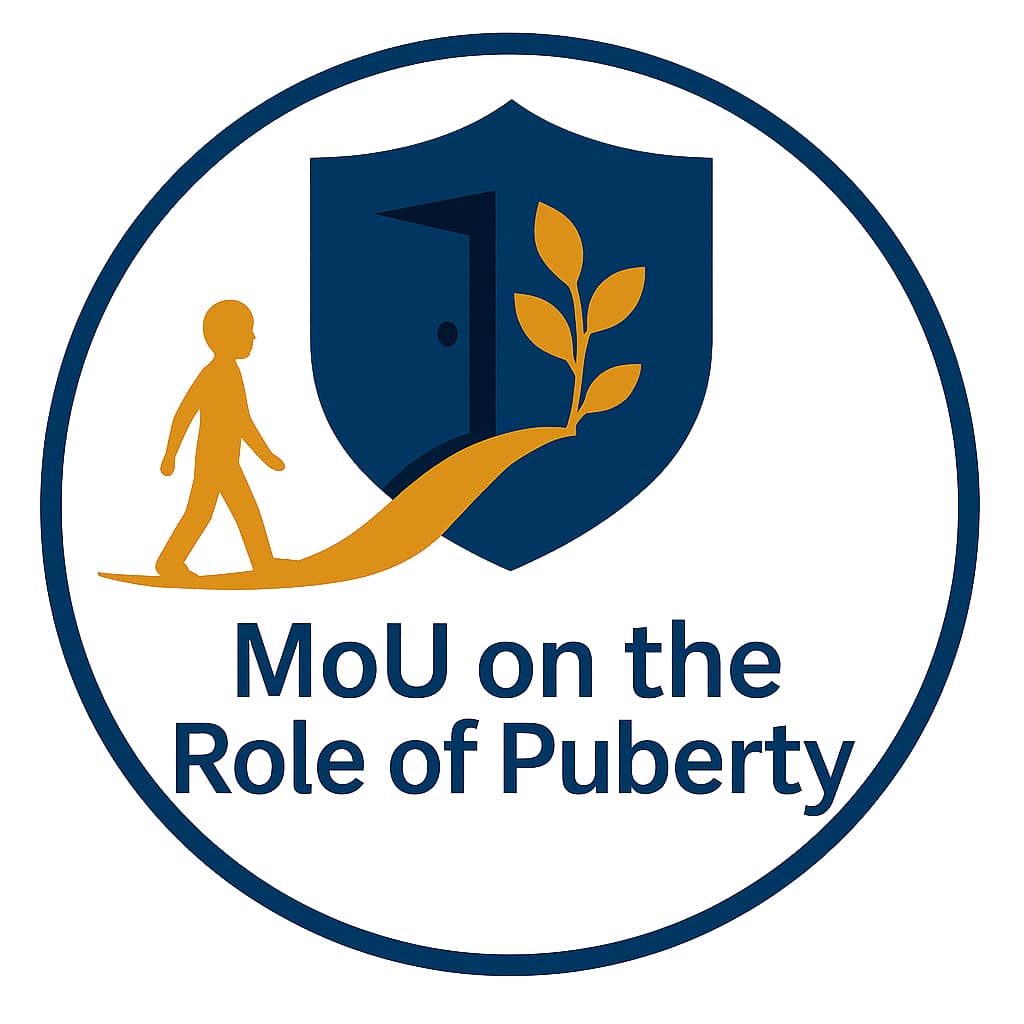« Talete, mentre studiava gli astri e guardava in alto, cadde in un pozzo. Una graziosa e intelligente servetta trace lo prese in giro, dicendogli che si preoccupava tanto di conoscere le cose che stanno in cielo, ma non vedeva quelle che gli stavano davanti, tra i piedi. La stessa ironia è riservata a chi passa il tempo a filosofare […] provoca il riso non solo delle schiave di Tracia, ma anche del resto della gente, cadendo, per inesperienza, nei pozzi e in ogni difficoltà». Ecco il celebre aneddoto sulla saggezza, riferito da Platone in Teeteto, vertente su un accadimento della vita del filosofo Talete e di una sconosciuta giovinetta, protagonista dell’episodio, la servetta trace. L’aneddoto vorrebbe mostrare la considerazione nella quale è tenuto il filosofo, lo scienziato, e in generale lo studioso, concentrato nelle proprie riflessioni o contemplazioni, percepito come lontano dalle cose terrene, distratto e fuori dalla realtà, assorbito dalle elucubrazioni e astrazioni della mente e inadeguato alla quotidianità della vita, secondo il noto archetipo del “professore distratto”, caratteristiche che vengono messe a confronto con l’arguzia e lo spirito pratico che possono promanare da persone più semplici. Per chi non è ferrato in filosofia, Talete fu il primo filosofo a ignorare la spiegazione degli dèi come causa dei fenomeni (indicando nell’acqua l’unico principio di tutte le cose), il primo scienziato capace di prevedere un’eclisse e di controllare con profitto la natura (il raccolto delle olive), il primo intellettuale a dare suggerimenti saggi per l’organizzazione politica delle città, il primo matematico a capire la necessità delle dimostrazioni, ecc. Non è da meravigliarsi quindi se per Platone Talete era diventato l’archetipo dello scienziato.
L’aneddoto inoltre trasmette simbolicamente il pensiero di un altro filosofo, Platone: Talete volge gli occhi al cielo poiché per Platone lì risiedono le verità eterne, mentre in terra si manifestano le apparenze delle cose. Al di là di queste considerazioni filosofiche, l’aneddoto ci offre altre due riflessioni che ci interessano di più. Primo, il fatto che venga raccontato, con naturalità, come una donna prende in giro un uomo a lei sconosciuto, senza mai sottolineare la straordinarietà di questo evento, denota un’interazione paritaria tra uomini e donne, molto lontana da quella descritta dalla narrazione femminista. Nella mente del filosofo Platone e dei suoi lettori e/o ascoltatori dell’epoca, si tratta quindi di un evento altamente plausibile e per nulla straordinario: le donne possono parlare e deridere gli uomini senza paura delle conseguenze. Interazioni simili si trovano spesso in altri passaggi della letteratura universale, descritte senza mai sottolineare la straordinarietà dell’evento (che qui non andiamo ad approfondire perché ci porta fuori argomento). La seconda riflessione ci interessa di più. L’aneddoto non solo mette a confronto gli archetipi dello scienziato e della persona semplice, ma anche l’archetipo dell’uomo e l’archetipo della donna, due esseri sessuati con due interessi diversi. Questo aneddoto mette in evidenza che gli interessi degli esseri umani sono sessuati, cioè diversi tendenzialmente a seconda del sesso. È così?

Uomini e donne sono diversi.
A proposito della famiglia Manzoni, «Alessandro e Fauriel s’appartavano a parlare di letteratura e di filosofia; Giulia e Sophie de Condorcet chiacchieravano fra loro di gente di Parigi, a lei sconosciuta», ecco spiegata in maniera schietta e semplice la diversa produzione e costruzione del mondo per mano degli uomini e delle donne, spiegazione presente nelle epistole scritte da una donna. Due coppie di persone parimenti istruite e colte, gli uomini parlano «di letteratura e di filosofia», le donne preferiscono «chiacchierare di gente di Parigi», le donne scelgono il pettegolezzo. Tendenzialmente uomini e donne, bambini e bambine, possiedono interessi diversi – giochi diversi, acquisti diversi, sport diversi, letture diverse, studi diversi, ecc. –, palese verità che molto spesso viene contestata. In certi ambiti, come nel sesso, le differenze sono enormi. Una verità che qualsiasi persona che lavori nel marketing sa riconoscere, basta entrare in qualsiasi centro commerciale di abbigliamento e considerare la diversa superficie commerciale dedita alle donne e agli uomini. Di fronte a questa realtà il femminismo si pone, come al solito, in maniera ambigua (ora siamo uguali, ora siamo diverse!), a seconda se l’argomento è a loro favore o contro. Ad esempio, quando si tratta di difendere leggi diverse a seconda del sesso, come contro la violenza, la nota Ley de violencia de género in Spagna oppure la recente legge sul femminicidio in Italia, allora per il femminismo uomini e donne siamo diversi: «La violenza è amalgamata al DNA della mascolinità», ha dichiarato la femminista Manuela Carmena, ex sindaco di Madrid.
Quando invece si tratta di spiegare il motivo delle inferiori prestazioni dell’universo femminile, attuali o storiche, nello sport, la matematica, la scienza, l’arte o la filosofia, allora per il femminismo siamo completamente uguali e le cause sono da ricercare unicamente nelle discriminazioni del patriarcato. «Esistono davvero poche filosofe?», si chiede il giornale la Repubblica. «Naturalmente le filosofe sono, storicamente, effettivamente meno della loro controparte maschile, ma le ragioni stanno nella loro impossibilità di studiare, di avere un’educazione, di disquisire pubblicamente, di partecipare ai convegni, di “praticare” come invece potevano fare i filosofi di mestiere». In conclusione, «sono state le imposizioni della società patriarcale a fare la differenza, non le potenzialità dell’intelletto». L’autrice ipotizza due uniche possibili cause, o siamo diversi con differente potenzialità dell’intelletto (ragione che l’autrice esclude), o le donne sono state ostacolate e discriminate dalla società patriarcale. Sulla «potenzialità dell’intelletto», è un dato di fatto che sono esistite donne filosofe, poche rispetto agli uomini, ma pur sempre esistite, basta pensare a Hannah Arendt, o la stessa Simone de Beauvoir. Dunque bisogna concordare con l’autrice che anche le donne, come gli uomini, sono portate all’astrazione del pensiero e allo sviluppo creativo dell’intelletto. Ma «potenzialità» non vuol dire realizzazione.

Interessi differenti e complementari.
Tutti siamo artefici in potenza ma in molti tra noi non concretizziamo nulla nei più svariati ambiti, perché non troviamo gli stimoli per farlo. Alle due cause menzionate, può essere aggiunta quindi una terza che l’autrice non ipotizza nemmeno: l’interesse. È possibile che le donne fossero meno interessate alla filosofia, come lo erano Giulia e Sophie de Condorcet, distratte da altre questioni o da altri interessi? È possibile che il minor coinvolgimento femminile non dipenda né dalle potenzialità né dalla discriminazione, ma dal semplice fatto che le donne erano meno propense a interessarsi alle questioni tecniche, alla matematica, alla fisica o allo sviluppo teorico della filosofia? Quest’ipotesi è l’unica che riesce a spiegare ragionevolmente perché in ambienti dove uomini e donne erano parimenti colti e istruiti, dove tra l’altro il ruolo delle donne era preminente, come succedeva nelle comunità letterarie o nei “salotti” francesi, italiani e tedeschi nel XVIII secolo e nei primi decenni del XIX secolo, le scoperte tecniche, la creazione artistica e la produzione del pensiero rimase un regno quasi esclusivamente maschile. Queste donne erano benestanti e libere, stimate socialmente e ascoltate pubblicamente dal mondo intellettuale maschile che frequentava i loro salotti. Evidentemente la discriminazione non può essere chiamata in causa. Cosa impediva a queste donne di produrre così come facevano i loro coetanei e frequentatori dei loro salotti? Forse non erano interessate.
Durante il Medioevo ci furono due tipi di sapere teologico, l’uno spirituale e mistico, l’altro filosofico e dimostrativo. Fino al XIV secolo la teologia mistica costituì una via complementare e convergente con la via seguita dalla teologia scolastica, diretta all’intelligenza della fede. La Scuola scolastica fu quasi esclusivamente maschile (Teodorico di Chartres, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, Ruggero Bacone, Giovanni Duns Scoto, Guglielmo di Ockham, Marsilio di Padova, Bonaventura da Bagnoregio….). Il fiorire delle esperienze mistiche fu prevalentemente femminile (la beghina Margherita Porete, la badessa cistercense Gertrude di Helfta, la badessa benedettina Ildegarda di Bingen, Angela da Foligno, più tardi Teresa d’Avila o di Gesù, per citare alcune delle figure più note). Attraverso la mistica cristiana queste donne ribadirono la superiorità dell’amore e proposero il ritorno dell’anima al suo essere originario in Dio come annientamento per diventare ciò che Dio era. Tale incontro liberava l’anima, tanto che l’anima annientata, grazie all’Amore dello Sposo divino, prendeva congedo dal servizio alle virtù. Il titolo dell’opera di Margherita Porete, Lo specchio delle anime semplici annientate, che dimorano soltanto nella volontà e nel desiderio d’amore, è abbastanza eloquente. Su Ildegarda è stato già accennato nell’intervento precedente che predicò pubblicamente, visitò monasteri, inviò lettere a vescovi e abati, ma anche al pontefice e all’imperatore. Sembra che gli uomini e le donne medievali si siano divisi spontaneamente, secondo il loro diverso interesse, il tipo di conoscenza.

Nessuna “discriminazione patriarcale”.
Vorrei concludere con un’ultima riflessione sul concetto di discriminazione patriarcale. Secondo la tesi femminista la società patriarcale ha discriminato le matematiche, le scienziate, le scrittrici, le filosofe… Per secoli nel mondo occidentale c’è stato un ambito che ha socialmente prevalso su qualsiasi altro (scienza, fisica, matematica, letteratura, pittura, filosofia…), un ambito che concedeva la stima e il riconoscimento di tutta la società: l’ambito religioso. A lungo, essere un matematico o un artista non è mai stato motivo di grandi guadagni né di grande vanto sociale. Fino alla fine del Basso Medioevo gli artisti non firmavano nemmeno le loro opere. Al contrario le sante, alla pari dei santi, erano sempre in prima linea per le gerarchie ecclesiastiche e per il popolo patriarcale. A loro spettava tutto il riconoscimento e la stima sociale. Per quale motivo gli uomini avrebbero dovuto discriminare le donne in ambiti marginali ignorati dal popolo e esaltare le donne nell’ambito più importante celebrato da tutta la società?
Una riflessione che può essere applicata anche per l’attualità. Secondo le filosofe femministe, «nemmeno oggi, salvo rari casi, possiamo affermare di trovarci di fronte alla parità di genere». Per quale motivo l’attuale società patriarcale dovrebbe discriminare le matematiche o le filosofe – ambiti che non generano né celebrità (quanti filosofi e matematici attuali conoscete?) né grandi guadagni (nemmeno se si vince il Nobel) -, e promuovere invece le donne in un ambito che concede loro la fama e lauti guadagni miliardari, come è quello delle superstar della musica e dello spettacolo, dove le donne prevalgono e non mancano (Shakira, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga, Ariana Grande…)? Se è così che funziona la discriminazione del sistema patriarcale, bisogna riconoscere che non è un sistema molto illuminato.