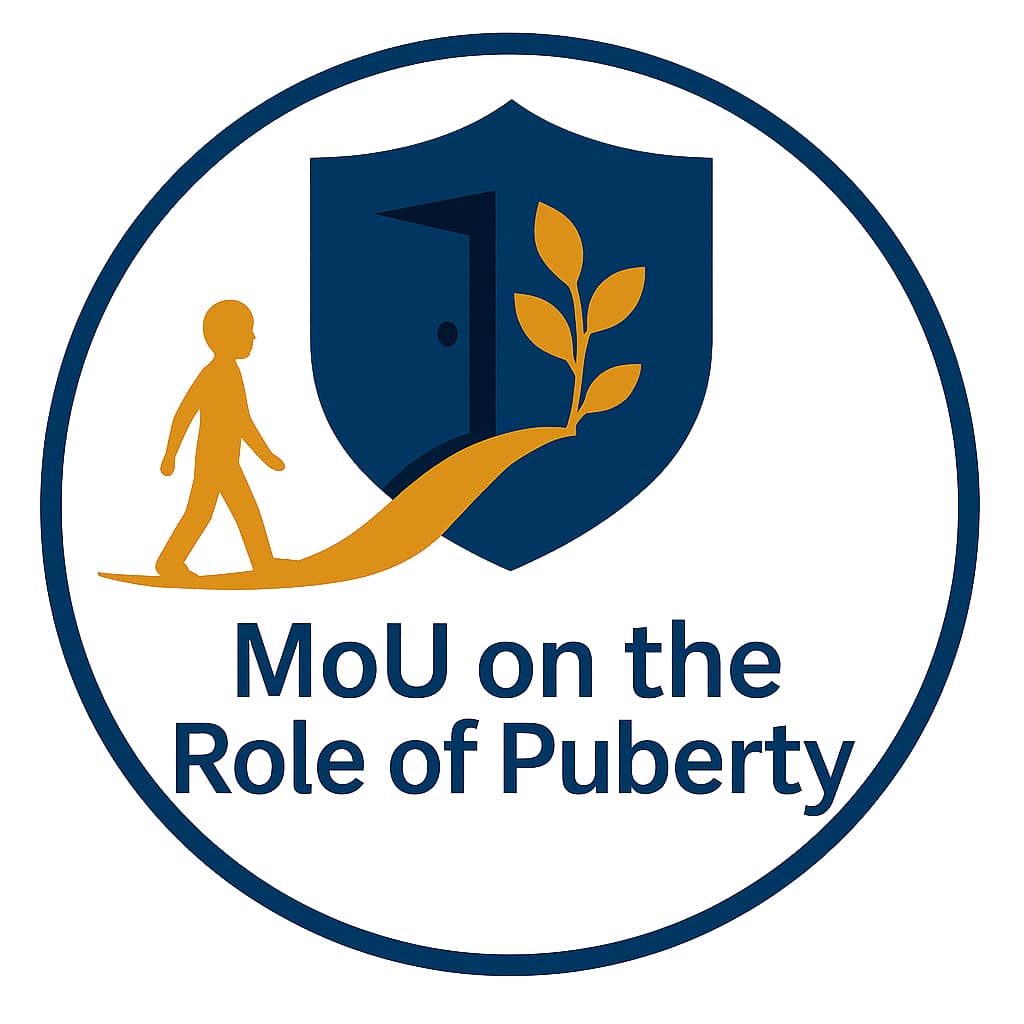«La coscienza è una parola in uso solo presso i vili, escogitata in prima luogo per incutere paura ai forti. Che la nostra coscienza siano le nostre braccia forti, la nostra legge le spade!» (Riccardo III, Atto V, William Shakespeare). Attualmente la morale e il senno comune inculcano la condanna di ogni forma di violenza e il rispetto degli altri, anche se possiamo constatare come spesso questi precetti non sono seguiti o sono seguiti con molte eccezioni. Malgrado il biasimo morale, la convenienza e la forza sembrano prevalere nella vita, nel mondo della politica e negli affari, tra gli individui e tra gli stati. Il sofista Trasimaco diceva che il “giusto” non è altro che l’“utile” del più forte: la logica della forza si scontra in questo modo con la logica del diritto e della giustizia. C’è un evento storico, tramandato dallo storico greco Tucidide, che esemplifica molto bene il concetto del diritto della forza: nel 416 a. C., la storia dello scontro tra un potente impero, quello di Atene, e una piccola isola dell’Egeo, l’Isola di Melo, che oggi viene denominata Milos. L’isola di Melo, neutrale anche se amica di Sparta, si rifiutò di entrare a far parte della lega ateniese. Dopo un lungo assedio – racconta lo storico – «gli ateniesi passarono per le armi tutti gli adulti caduti nelle loro mani e resero schiavi i fanciulli e le donne». Un episodio minore nel trentennale conflitto tra Sparta e Atene nella guerra del Peloponneso. Per inciso, da notare, come succedeva spesso nelle guerre, il trattamento asimmetrico dei vinti a seconda del sesso: tutti gli adulti maschi venivano sterminati, donne e fanciulli resi schiavi e lasciati in vita.
Tucidide, nella sua opera Guerra del Peloponneso (V, 85-114), ci tramanda il presunto colloquio tra i governatori di Melo e gli emissari Ateniesi, probabile invenzione dello stesso storico. Al centro del colloquio il nodo del diritto alla neutralità e della guerra “giusta”: la neutralità che i Meli difendono e che gli Ateniesi non possono accettare senza indebolire il loro prestigio di grande potenza. La guerra diventa in questo modo una inevitabile “necessità” per entrambi gli avversari. I Meli pagheranno con l’annientamento la loro scelta. Gli Ateniesi riferiscono ai Meli che Atene vuole sottomettere Melo, non distruggerla, ma la distruggerà se insisterà nel suo rifiuto a sottomettersi. La giustizia esiste laddove c’è parità di forze; altrimenti i forti agiscono in ragione del loro potere e i deboli subiscono. Questa è la sola legge di natura che è in vigore, che vale sia per gli dèi, sia per gli umani; legge che essi, i Meli, se avessero la forza, eserciterebbero con lo stesso potere. Nel colloquio così si esprimono gli Ateniesi: «Gli dei e gli uomini tendono sempre, per necessità di natura, a dominare ovunque prevalgano le forze. Questa legge non l’abbiamo istituita noi e non siamo nemmeno stati i primi ad applicarla; così, come l’abbiamo ricevuta e come la lasceremo ai tempi futuri e per sempre, ce ne serviamo, convinti che anche voi, come gli altri, se aveste la nostra potenza, fareste altrettanto».

Il capovolgimento dei valori tra debolezza e forza.
Gli interlocutori Meli, dopo aver invano invocato le norme universali della giustizia, sostengono che è più vantaggioso per Atene consentire all’isola di mantenere la sua neutralità, piuttosto che distruggerla provocando il biasimo di tutti i greci e la ritorsione degli spartani. Ma gli Ateniesi non sono convinti di questa considerazione: l’ostinata neutralità di Melo, se perdurasse, sarebbe interpretata come un’ammissione di debolezza da parte di Atene. Gli Ateniesi dunque non sono liberi di scegliere: o conservano l’impero, con la forza che esercitano sui nemici, o finiranno a loro volta asserviti. Gli Ateniesi ammoniscono i Meli a non fare gli eroi: non è in gioco l’onore, come in uno scontro fra pari, ma la loro sopravvivenza di fronte a un nemico tanto più forte. E così si compì, per l’ennesima volta, la massima del filosofo tedesco Hegel: «i popoli, gli individui sono come degli innocenti fiorellini che la storia calpesta». I Meli furono annientati. Nel dialogo tra gli Ateniesi e i Meli, le parole restituiscono l’applicazione della logica di potenza, del diritto del più forte tra gli stati, il diritto di tiranneggiare i più deboli: la ferocia dei più forti non risparmia nulla e nessuno. Da quando c’è memoria storica, il diritto del più forte è stato alla base di ogni conquista tra i popoli, e questa dinamica tra i popoli sembra riproporsi tra gli individui. I forti agiscono in ragione del loro potere e i deboli subiscono? La giustizia esiste solo laddove c’è parità di forze? È sempre stato così e deve per forza così rimanere? Il diritto della forza è la legge di natura?
Di questa opinione sono i sofisti, come Trasimaco, Crizia o Callicle: si tratta di una legge della natura, comune a uomini e dèi, che sanziona la superiorità di alcuni, non l’uguaglianza di tutti. La logica della forza demolisce il concetto di uguaglianza, la giustizia e la legalità. Nella Repubblica, Platone fa pronunciare a Trasimaco una lezione di crudo realismo politico: la legge non realizza alcuna giustizia, ma legalizza la sopraffazione; la città è teatro di uno scontro di forze, senza che vi sia un ordine superiore al quale riferirsi. L’aristocratico Crizia sostiene che leggi e divinità sono solo strumenti forgiati dall’abile legislatore per ridurre a ordine, attraverso la punizione e l’inganno, una natura umana priva, in sé stessa, di moralità e socialità. La divinità è dunque una sorta di polizia segreta inventata dai governanti per controllare le coscienze, uno strumento di oppressione che Crizia ritiene lecito, utile e indispensabile per controllare i sudditi ma dal quale i potenti non devono certo sentirsi vincolati e condizionati. In questo modo i più forti sottometterebbero i più deboli, il volgo, rendendo vera la massima di Marx: «la religione è l’oppio dei popoli». Callicle invece capovolge il ragionamento: leggi e valori morali sono invenzioni dei deboli, la maggioranza, per impedire ai pochi, ai forti, di realizzare la superiorità che li caratterizza per natura. Callicle osserva che in natura i più forti prevalgono e i deboli inevitabilmente soccombono; la legge naturale è dunque il diritto del più forte e contempla la superiorità di alcuni sulla massa degli altri. Quando si afferma l’uguaglianza tra i cittadini, vengono penalizzati i migliori e si assegna ai deboli un grande potere. Secondo Callicle, la democrazia lede la legge di natura e le gerarchie naturali tra gli uomini. Da Callicle prende spunto Nietzsche per sviluppare il suo pensiero e denunciare il capovolgimento dei valori: la critica alla morale degli schiavi (l’umiltà, la modestia, la compassione, la gentilezza, la pietà, l’obbedienza, l’uguaglianza, la sicurezza, la pazienza…), dei deboli, che si è imposta sulla morale dei signori (nobiltà, forza, potenza, orgoglio, libertà, indipendenza, eccellenza, audacia, coraggio, autenticità…), dei forti – questione che cercherò di approfondire nel prossimo intervento.

C’è parità nella forza?
Il filosofo tedesco Max Scheler (1874-1928), in Il risentimento nella edificazione delle morali, spiega il capovolgimento avvenuto con queste parole: «Tutti i pensatori i poeti i moralisti antichi sono su questo punto unanimi: l’amore è aspirazione, tendenza dell’ “inferiore” al “superiore”, del “meno perfetto” al “più perfetto”, del “me on” all’ “on”, del “non sapere” al “sapere”: “un medium tra avere e non avere”, come dice Platone nel Simposio. Così ogni relazione amorosa umana – matrimonio, amicizia ecc. – si fraziona in un “amante” e in un “amato” e l’amato e sempre l’elemento più nobile, la parte più perfetta: il modello per l’essere, il volere, l’agire dell’amante. Se si confronta ora questa concezione con quella cristiana, risulta qualcosa che si potrebbe chiamare il moto di ritorno dell’amore. Qui si dà uno schiaffo in faccia disinvoltamente all’assioma greco dell’amore secondo cui l’amore sarebbe un tendere dell’inferiore al superiore. Al contrario l’amore si deve dimostrare proprio con il fatto che il nobile si china e discende verso il non nobile, il sano verso il malato, il ricco verso il povero, il bello verso il brutto, il buono e il santo verso il cattivo e il volgare, il Messia verso i pubblicani e i peccatori; e ciò senza l’angoscia antica di perdersi e di svilirsi bensì nella convinzione autenticamente religiosa di ottenere nel compimento attuale di questo “piegarsi”, nel “lasciarsi andare”, nel “perdersi”, il massimo: la somiglianza con Dio. […] Ora Dio non è più meta eterna e quieta dell’amore della creatura, simile ad una stella che muove addirittura l’universo al modo in cui “l’amato muove l’amante”, bensì l’essenza stessa di Dio diventa amare e servire e da ciò soltanto procede il suo creare, volere, causare».
Fin qui una rassegna veloce del pensiero di alcuni filosofi su questioni fondamentali dell’umanità, come è la giustificazione del diritto attraverso la forza o la sua negazione attraverso la morale, ma in tutto ciò manca un elemento essenziale, che nessun filosofo introduce: la questione di genere. Il femminismo ha denunciato la falsa universalità, l’androcentrismo insito nel pensiero filosofico (cioè maschile). L’ideologia femminista ha ragione quando rivela che questi filosofi non si esprimevano dalla particolarità di un genere specifico, in conflitto con l’altro, come predica il femminismo. Nietzsche è stato, all’epoca, l’unico e il primo filosofo a introdurre la questione di genere, cioè a parlare specificamente nel proprio sistema concettuale di uomini e di donne, e tendenzialmente ha posizionato le donne tra i deboli, propagatrici dei valori degli schiavi. Non bisogna essere molto accorto per capire le enormi implicazioni e le profonde conseguenze che se ne possono trarre, oltre che politicamente scorrette, se inseriamo la questione di genere e una visione maschile, così come ha fatto il femminismo inserendo una visione femminile, su ogni ambito della filosofia, terreno del pensiero in gran misura inesplorato e di immense potenzialità. Nello specifico, sull’argomento dell’intervento: in che modo dobbiamo applicare la logica della forza o del diritto a uomini e donne? Hanno forse uomini e donne parità di forze? Quando Shakespeare in Riccardo III parla di «braccia forti» e invoca di impugnare «le spade» si rivolge agli uomini, alle donne o a entrambi? Quei «braccia forti» sono braccia femminili? A chi conviene capovolgere i valori, promuovere la morale e la religione, a scapito dell’altro più forte? Perché nelle dualità che elenca Max Scheler non c’è il maschile/femminile? Parafrasando Scheler, si può parlare di una tendenza della donna verso l’uomo che è stata capovolta in una tendenza dell’uomo verso la donna? Parafrasando Trasimaco, è forse il “giusto” oggigiorno l’ “utile” per la donna?

La forza del sesso.
È evidente che è stato aperto un filone quasi inesauribile di domande e riflessioni, che qui, per ovvi motivi di spazio, per ora, non farò. Mi preme accennare molto velocemente tre considerazioni. Primo, sbagliano i filosofi o chiunque creda che la forza (fisica) sia l’unico strumento per raggiungere il potere. Le donne adoperano spesso armi diverse (la seduzione, la bellezza, l’intrigo, l’amore, il sesso, la lacrima, il ricatto emotivo…) con le quali cercano di imporre la loro volontà nel mondo, argomento che in qualche modo è stato già sviluppato nella serie di interventi Chi comanda il mondo (1, 2, 3, 4). Secondo, molti filosofi (Freud, la Scuola di Francoforte… persino Simone de Beauvoir) hanno riconosciuto nella sublimazione del sesso la forza trainante nella costruzione del mondo. Il sesso diventa quindi per le donne un’arma fenomenale per cercare di imporre la propria volontà. Terzo, in Natura tendenzialmente gli uomini prevalgono e le donne soccombono, e questo è ancora più vero per quanto riguarda i rapporti sessuali e le conseguenze del coito. Quando i filosofi (maschi) denunciano la moralizzazione e repressione storica del sesso e si chiedono (in special modo Foucault) il motivo della sua «problematicizzazione», in realtà stanno lamentando, in quanto maschi, la sostituzione della Natura per la Civiltà: l’introduzione della cultura e moralizzazione della Natura ha penalizzato l’uomo e capovolto la gerarchia naturale tra uomini e donne. L’unica e vera rivoluzione sessuale dell’umanità è stata quella di attribuire alle donne la decisione dell’atto sessuale. Per maggiori approfondimenti su questi complessi argomenti, rimando alla lettura dell’opera La grande menzogna del femminismo, è concludo con delle parole tratte da questa stessa opera (p. 527): «Senza possedere la conformazione fisica che le permettesse di farlo, la donna ha capovolto i ruoli predisposti dalla Natura, ha assoggettato il maschio al suo consenso […]. Nella Natura il maschio è “vincente”, la femmina “perdente”; nella civiltà, l’uomo è “perdente”, la donna “vincente”».