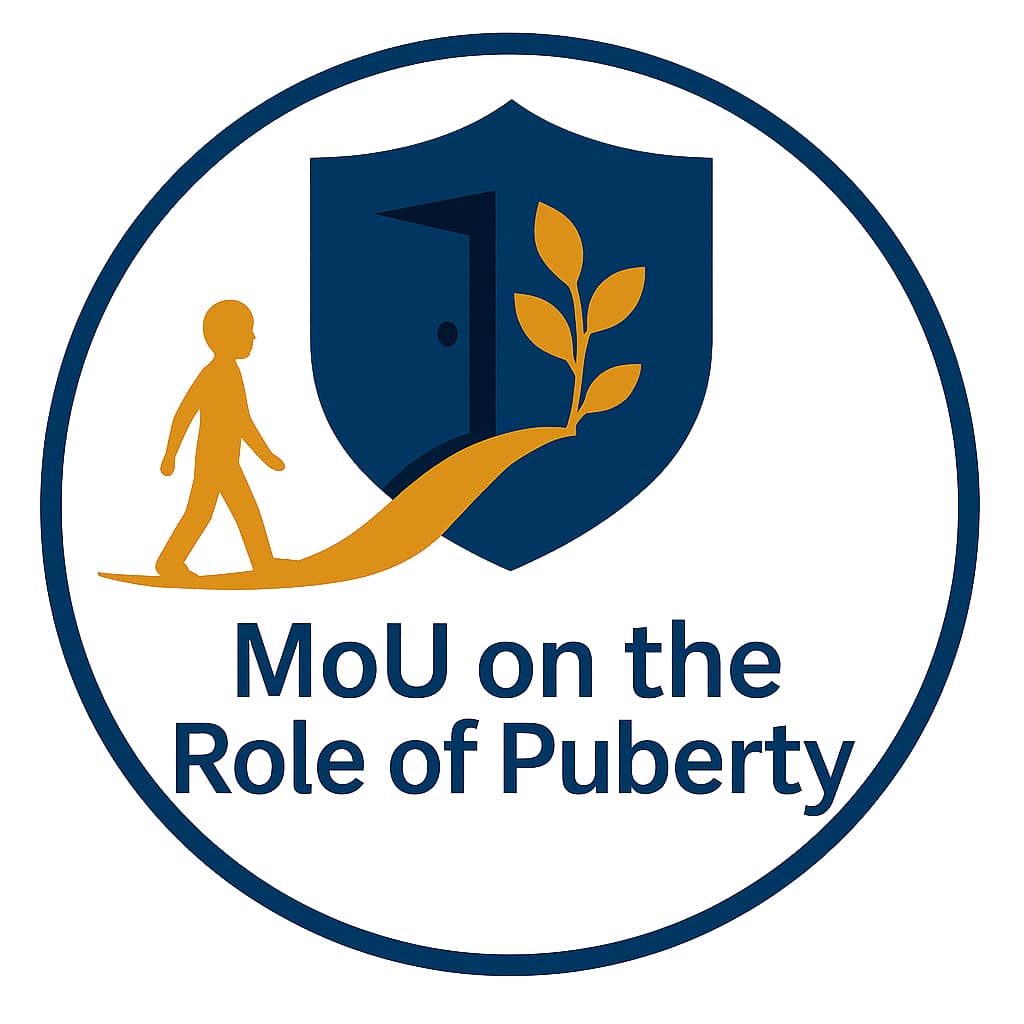Nella prima parte abbiamo visto che la ricostruzione della notte di sesso tra E. M. e i cinque campioni di hockey junior in quella stanza d’albergo di London, Ontario nel giugno 2018, fondata su testimonianze e prove, lascia poco adito a dubbi: c’è perfino un eccesso di evidenze a sostegno del consenso esplicito della donna. Ma secondo i sostenitori dell’accusa, il solo fatto di essersi trovata in una stanza da sola con più ragazzi dimostrerebbe che tutto ciò che è accaduto lì dentro è in automatico il risultato di una coercizione: la donna non avrebbe avuto altra scelta che fare tutto ciò che ha fatto (comprese le ripetute espressioni di consenso, rifiutare le offerte delle amiche di andare a “salvarla”, le aggressive profferte sessuali etc. etc.), per paura di ritorsioni violente. Nella versione di E. M. (però la seconda, quella del 2022, quattro anni dopo i fatti), paralizzata dal terrore per la situazione, dopo aver «inserito il pilota automatico» e «incapace di controllare il proprio corpo», ella fece tutto ciò che pensava i ragazzi si aspettassero da lei (pp. 45-47 delle motivazioni alla sentenza, che si possono scaricare qui). Prendendo pure direttamente l’iniziativa, senza tentativi attivi di coercizione e neanche inviti o suggerimenti, ma ciò non dimostrerebbe il “reale” consenso della donna né la sua libera “agentività”, per usare un termine che piace ai filosofi femministi.
Anzi, secondo l’accusa, i video in cui E. M. afferma il proprio consenso esplicito e appare tutt’altro che intimorita e incapace di intendere e volere, in realtà costituirebbero una chiara prova dell’abuso in atto (p. 48 delle motivazioni): perché, se tutto era lecito e a posto, i ragazzi non avrebbero avuto alcun motivo per voler registrare quei video. Ne converrete: c’è del genio in questo ribaltamento di frittate. In pratica, se mancano prove del consenso, è una lampante prova di violenza sessuale; se le prove ci sono, è comunque una lampante prova di violenza sessuale. Se non si sta facendo nulla di male, perché mai si dovrebbe voler registrare prova del consenso della controparte? Forse perché da decenni la vulgata femminista insiste che “solo sì significa sì”, che questo sì dev’essere espresso in modo chiaro e dimostrabile, e questa dottrina è penetrata pure nella legge dei paesi occidentali?… Nah, che sciocchezza: cercare di ottenere una prova del consenso della donna è praticamente una confessione di star commettendo un abuso (ma visto che in questo processo le prove si sono rivelate fondamentali, sembra comunque meglio procurarsene, se possibile…).

Cosa significa “consenso”?
Rebus sic stantibus, la prima riflessione sorge spontanea: cosa significa “consenso”, e come lo si può attestare? Il procuratore Donkers ha affermato: «In questo caso non è importante stabilire se la ‘vittima’ abbia detto esplicitamente ‘no’, o abbia cercato di ritrarsi da una situazione sgradita pur avendone avuta l’opportunità. In questo caso è importante capire se lei abbia realmente consentito in modo libero e volontario a ciascun atto sessuale nel momento esatto in cui esso aveva luogo». Cunningham, l’altro procuratore, ha dichiarato che i due video in cui E. M. esplicita il proprio consenso dimostrano una mera «adesione meccanica a parole, ma non costituiscono una prova sufficiente che i ragazzi abbiano preso tutte le misure necessarie per assicurarsi un reale consenso». Ma, come scrive la ricercatrice Janice Fiamengo nel suo acuto commento alla vicenda, «Allora qualcuno deve spiegarci chiaramente che cosa può costituire una prova ‘sufficiente’ di un ‘reale’ consenso a ‘ciascun’ atto sessuale. Altrimenti, si può solo concludere che qualsiasi evidenza o prova si possa produrre, non sarà mai considerata ‘sufficiente’».
Una seconda riflessione riguarda la discussione del caso nei media e nell’opinione pubblica. I titoli riguardanti l’accusa, la fine della carriera dei ragazzi, il processo hanno certamente raggiunto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Ma quante di queste approfondiranno, confrontando più fonti e magari leggendo le motivazioni della sentenza? Verosimilmente molto poche, così come pochi sono coloro che hanno consapevolezza della realtà delle false accuse. I più resteranno fermi all’idea che qualcosa di terribile si sia svolto in quella stanza d’albergo ai danni di E. M., che una violenza sia rimasta impunita a causa del maschilismo e della misoginia imperanti nel sistema giudiziario, e la reputazione degli atleti coinvolti resterà macchiata a lungo. Nonostante la quantità di evidenze contrarie alla versione di E. M., la sentenza di assoluzione è stata accolta con una protesta da parte di attivisti solidali con la “vittima”, con cartelli recanti la scritta “We believe E.M.”: #sorellaioticredo, a prescindere.

Una reputazione macchiata a vita.
E, significativamente, sono rare le voci che stanno raccontando la storia completa. La maggior parte dei cronisti e commentatori esalta il coraggio di E. M. nel perseguire la “propria” verità; denuncia la “vittimizzazione secondaria” che E. M. è stata costretta a subire durante il processo, ad es. così il sottotitolo del The Guardian: «Il giudice sembra aver sottoposto l’accusatrice a uno scrutinio ben più aspro rispetto ai cinque atleti accusati di violenza sessuale, che nonostante tutto restano liberi»; i “falsi miti e stereotipi dannosi” sulla violenza sessuale che avrebbero informato la decisione del giudice, nonostante la stessa Maria Carroccia li abbia affrontati esplicitamente nelle motivazioni della sentenza; e il danno che ogni sentenza di assoluzione in processi per violenza sessuale comporterebbe a tutte le presunte vittime di violenza sessuale, che così verrebbero colpevolmente dissuase dal denunciare (ad esempio qui e qui): come se fosse più importante non rischiare di intimidire le donne che abbiano un’accusa in pectore, piuttosto che accertare la verità, assicurare sentenze giuste e evitare che degli innocenti siano condannati. Nel commento di Janice Fiamengo, «Il motto del nostro tempo sembra essere: meglio cento uomini innocenti in galera, che la potenziale esitazione di una sola accusatrice».
Terza e ultima riflessione: il femminismo e l’ideologia queer spingono da decenni per la “liberazione sessuale”, dipingendo il sesso come un mero strumento transazionale e idraulico per ottenere piacere a buon mercato o anche vantaggi economici e di altro tipo. Purtroppo non è così semplice e il sesso, lungi dall’essere quell’atto meccanico che può sembrare nelle rappresentazioni grafiche e video, oltre alla gratificazione corporale momentanea, implica sempre uno scambio a livello intimo, emotivo. E. M. probabilmente ha sfogato con McLeod e compagni una propria fantasia, ma ha pagato emotivamente lo scotto di aver provato a realizzarla con dei ragazzi conosciuti appena, anziché nel contesto di un rapporto umano profondo e strutturato. Secondo la ricostruzione dei fatti (p. 21 delle motivazioni), dopo gli atti sessuali di gruppo E. M. e McLeod fanno nuovamente sesso, dopo il quale McLeod, stanco, le chiede se abbia intenzione di andarsene. Questa domanda offende e irrita E. M., probabilmente deludendo le sue aspettative. Lasciando la stanza, infatti, gli dà dello “sfigato” (“jerk”); e appena uscita dall’albergo chiama un’amica e si sfoga, ma non parla di abusi o violenze: tutto ciò di cui sente il bisogno di lamentarsi è che «era uscita dal locale con un ragazzo che le era sembrato interessante, ma poi si era rivelato un vero sfigato» (pag. 17).

Dopo il sesso la responsabilità non è mai della donna.
Quando l’eccitazione del momento finisce, e della fantasia realizzata resta solo uno atto di sesso idraulico tra corpi sconosciuti, alieni, e non uno scambio integrato in un rapporto umano affettivo e reale (magari anche solo potenziale, promesso…), la frustrazione emerge potente. Ma non se ne può addossare la colpa all’altro. Su questo punto chiudo con le parole di Marilyn Simon, docente di letteratura, studiosa di Shakespeare, autrice di un blog antifemminista e di un superbo articolo sulla vicenda, di cui suggerisco caldamente la lettura integrale: «Come potrebbe una qualsiasi donna che rispetti se stessa comportarsi in questo modo? Be’, perché la verità, politicamente scorretta, è che alle donne a volte piace sentirsi degradate nel sesso. Questo desiderio di umiliazione può suonare strano, specie dopo decenni di femminismo che insistono che le donne vogliono l’opposto – essere rispettate, e soprattutto essere rispettate nel sesso. Ma il rispetto non è molto eccitante. È esattamente il contrario di eccitante: è morale. Il sesso eccitante ha un sapore di trasgressione.
Questo è il motivo per cui il sesso è più pericoloso per una donna che per un uomo, anche nell’era dell’infinita espansione del concetto di consenso. È proprio perché desideriamo il sesso trasgressivo, che siamo disposte a rischiare le conseguenze del sentirci usate, macchiate, forzate, e poi scartate. L’etica femminista tradisce le donne quando rifiuta di dare al sesso il necessario peso morale e di considerare la complessità del desiderio femminile. Le femministe sono più interessate a trattare le donne come vittime perenni, piuttosto che accompagnarle in una comprensione profonda della loro sessualità. Sono sempre in prima linea nel condannare gli uomini quando si comportano male, ma poi insegnano alle donne che, purché consenzienti, possono fare qualsiasi cosa le salti in testa. Questa è la parità secondo le femministe. E se una donna, a posteriori, si sente frustrata, non è mai una sua responsabilità: è sempre colpa dell’uomo che, in qualche modo, è riuscito a farla sentire male contro la sua volontà».