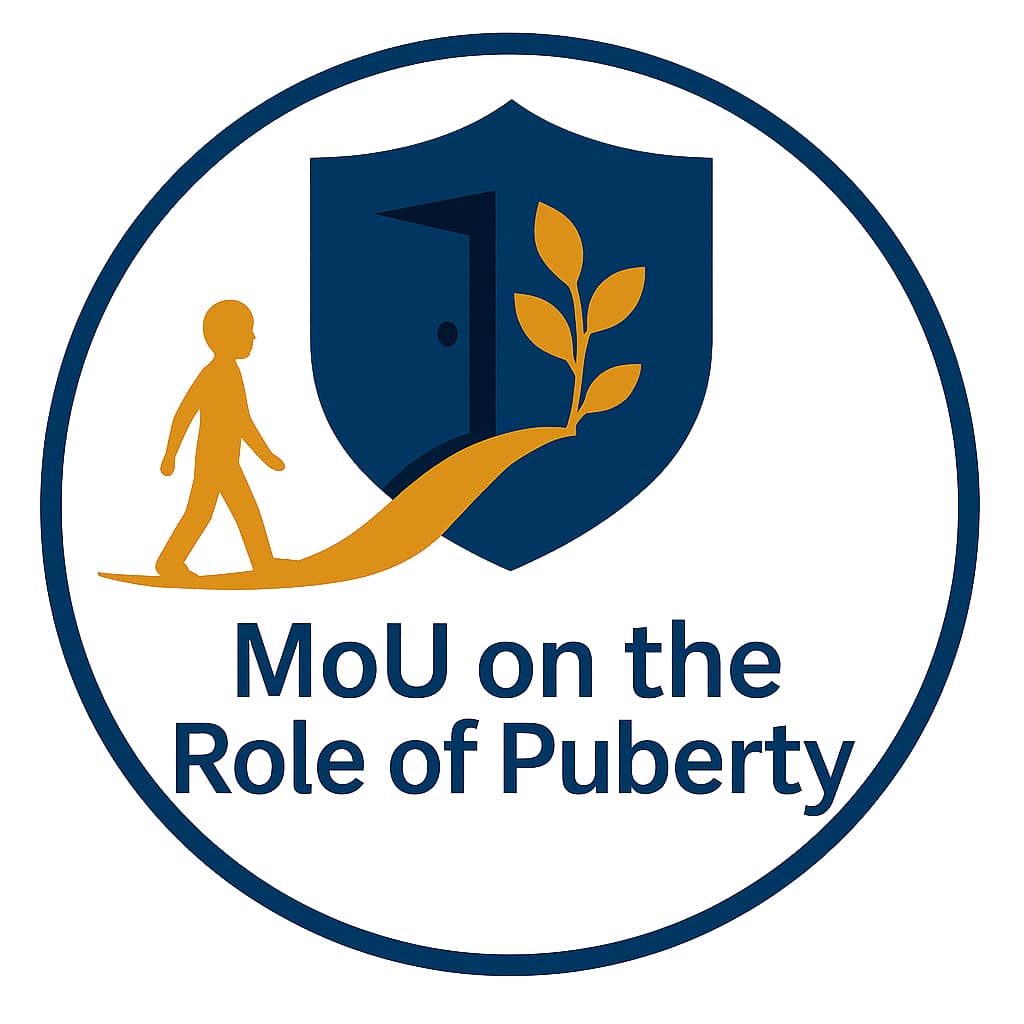Ora che sappiamo che uomini e donne sono categorie naturali, e non meri costrutti sociali inventati da qualche oppressore, bisogna capire come si fa a distinguerli. Abbiamo detto che uomini e donne si differenziano per la struttura corporea che, in condizioni di sviluppo sano e maturo, è in grado di produrre gameti fertili di un tipo (grande, l’ovulo) o dell’altro (piccolo, lo sperma). Le parti del corpo preposte a produrre e trasportare all’esterno i gameti costituiscono la funzione sessuale più fondamentale, perciò si chiamano “caratteri sessuali primari”: per i maschi sono i testicoli e il dotto deferente, per le femmine le ovaie e l’ovidotto, ma questi da soli non ci aiuterebbero a distinguere gli uomini dalle donne, perché sono interni al corpo. Fortunatamente, l’evoluzione ci ha dotato anche dei “caratteri sessuali secondari”: tutti quegli aspetti del corpo sessuato che invece si percepiscono dall’esterno (ve li dobbiamo indicare?). Può capitare che l’aspetto esteriore sia, a un impatto superficiale, ambiguo: ma entrano in gioco anche altri fattori non visivi e la cui percezione non è del tutto cosciente, ad esempio olfattivi tramite gli ormoni, o tonici e comportamentali, che ci fanno ugualmente intuire il sesso dell’altra persona. È comunque sempre possibile individuare il sesso del soggetto con un banale esame dei suoi organi genitali o, nei rarissimi casi di DSD, del fenotipo nel suo complesso.
Last but not least, i due sessi si distinguono anche per le loro tendenze comportamentali, attitudini e preferenze tipiche. Anzitutto, ogni epoca e area culturale ha un “dress code” tipicamente maschile e uno femminile, distinti tra loro. Questo “dress code” costituisce il grosso di quella che i woke chiamano “espressione di genere”. È innegabile che alcuni soggetti maschili amino presentarsi secondo l’espressione tipica femminile, e viceversa, e questo può accadere per moda, o per gusto personale, o per il preciso desiderio di assomigliare all’altro sesso, come nel caso dei soggetti cosiddetti “transgender”, o anche per specifica rivendicazione politica obbediente alle ideologie gender e queer (esempi qui e qui). Tuttavia, “l’abito non fa il monaco”. Se sei un uomo, puoi agghindarti e atteggiarti da donna quanto vuoi, puoi anche farti cambiare artificialmente i caratteri sessuali esterni, e puoi perfino riuscire a ingannare tutti in merito: resti comunque un individuo il cui corpo è nato e cresciuto nel modo strutturato per produrre gameti maschili, quindi un uomo.

I fatti sono bigotti: censurateli!
Parlavamo di differenze nei comportamenti, attitudini e preferenze. Secondo i woke, chi pensa che uomini e donne abbiano gusti e comportamenti differenti si è lasciato ingannare dai famigerati “stereotipi di genere”, responsabili pressoché di ogni presunta ingiustizia sociale nei confronti delle donne, nonché di ogni tipo di disagio o sofferenza maschile (non si capisce bene secondo quale logica o catena causale). Gli “stereotipi di genere” sono credenze comuni riguardanti i tratti tipici distintivi di uomini e donne, basate su generalizzazioni antiche e persistenti: non valide tutte insieme e in ogni singolo caso, ma comunque generalmente valide. Secondo i woke, queste generalizzazioni non coglierebbero la realtà delle cose, ma solo un’arbitraria aspettativa preconcetta proiettata sulle persone, che contribuirebbe a ingabbiarle nei “ruoli di genere” cattivi (i presunti posti nella società pre-assegnati agli individui a seconda del sesso) e quindi a perpetuare le presunte ingiustizie sociali. Vi diranno anche che “decenni di studi” confermano l’idea che gli “stereotipi di genere” non riflettano differenze naturali e biologiche ma siano unicamente “costrutti sociali” arbitrari. Non stateli a sentire: di solito, andando a scavare, si scopre che parlano per sentito dire, oppure citano qualche articolo di sociologia, antropologia culturale, gender studies – che possono certamente avere dignità accademica, ma di certo non sono ambiti che indagano le categorie naturali mediante l’osservazione empirica (piuttosto, interpretano fenomeni sociali o culturali, solitamente sotto la lente di precise impostazioni ideologiche).
L’indagine empirica rivela un dato incontrovertibile: «l’accuratezza degli stereotipi è uno dei fenomeni più ampiamente osservabili e ripetibili dell’intera psicologia sociale, sebbene ci sia voluto quasi un secolo per riconoscere che l’affermazione contraria non era basata su evidenze empiriche, e per accettare la realtà delle cose una volta che i dati hanno cominciato a essere disponibili», passo tratto dal 2° capitolo del manuale accademico Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (Taylor&Francis, 2015). Gli autori spiegano così l’ostilità di certi ambiti accademici verso gli stereotipi: «La psicologia sociale si è da sempre incaricata della missione di risolvere problemi sociali, tra cui quelli causati da pregiudizi e discriminazione. … Alcuni studiosi sono convinti che l’accuratezza degli stereotipi possa essere usata come argomento per indebolire gli sforzi mirati a ridurre l’ingiustizia sociale. Questa preoccupazione è stata a lungo un ostacolo alla ricerca empirica sul tema, e poi ad accettarne i risultati. Ad es. Stangor argomenta in questo modo perché non bisognerebbe fare questo tipo di ricerca: “non possiamo permettere che i bigotti si sentano confermati nei loro stereotipi, neanche se questa credenza fosse fattualmente accurata”» (ricordate l’uso del termine “bigotti” da parte della Prof.sa Sarah Richardson nella recensione del volume di Fuentes?).

Gli stereotipi su uomini e donne sono accurati.
Questo atteggiamento, tipico dell’attivismo e delle “scienze sociali” woke, non è scientifico, ma ideologico: la scienza guarda anzitutto ai fatti nel modo più neutro possibile, poi sulla base di quelli, può stimolare domande su se e come si possa agire su di essi; la ricerca woke invece parte dallo stato ideale ritenuto desiderabile, e su quella premessa cerca, o fabbrica ad hoc, dei dati per sostenerla e propagandarla, ignorando o censurando quelli che la smentiscono. Gli autori proseguono con l’accurata e dettagliata review di tutte le ricerche disponibili sul tema (che il lettore può approfondire autonomamente) e concludono ribadendo che: «L’accuratezza degli stereotipi è tra i fenomeni più ampi e replicabili dell’intera psicologia sociale. Tale effetto è osservato in modo largamente più solido rispetto ad altre ipotesi che sono comunque considerate ‘supportate dai dati’». Questo risulta soprattutto per gli stereotipi socialmente condivisi, quelli del tipo “lo sanno tutti che…”: «Il giudizio medio di una comunità risulta spesso più accurato dei giudizi degli individui che ne fanno parte presi singolarmente … Questo risultato costituisce una spina nel fianco per: 1) chi afferma che gli stereotipi sono ‘inaccurati’; 2) ogni prospettiva che suggerisca che gli stereotipi sono falsi miti culturalmente condizionati». Il woke obietterà che sì, questi studiosi dicevano questo allora, ma sono passati ben dieci anni e ora il campo è rivoluzionato da nuove scoperte. Non statelo a sentire. Una review recentissima condotta da studiose diverse (peraltro, entrambe donne), pubblicata ad agosto 2025 sul Journal of Experimental Social Psychology, ha ribadito esattamente gli stessi risultati.
Non ci dilunghiamo sui dettagli tecnici (che il lettore può approfondire autonomamente: la versione pubblicata è a pagamento, è accessibile per tutti quella pre-print) ma è interessante un passo delle conclusioni: «I risultati suggeriscono che la metafora del ‘semino di verità’ che sarebbe presente al fondo degli stereotipi sui sessi non è del tutto corretta, perché piuttosto che un semino, si tratta di un ‘nòcciolo’ più grosso di quello di un avocado o di un mango. Alcuni stereotipi possono certamente essere inaccurati e del tutto slegati dalla realtà (ad es. quelli sui segni astrologici), ma nel caso degli stereotipi sui sessi, il fatto che uomini e donne siano costantemente a contatto diretto gli uni con gli altri è un filtro di accuratezza: in tali condizioni, se si cercasse di diffondere generalizzazioni palesemente false, non potrebbero mai diventare credenze diffuse. Se qualcuno ad es. dicesse che le donne sono mediamente più alte degli uomini, sarebbe subito messo in ridicolo, perché l’esperienza diretta che gli uomini hanno delle donne e viceversa fornisce già di per sé una solida evidenza contraria. Lo stesso si può dire delle affermazioni sulle tendenze psicologiche e comportamentali: se qualcuno dicesse che gli uomini sono più interessati alle persone e le donne alle cose, ad esempio». Quindi, il fatto che gli “stereotipi di genere” siano generalizzazioni accurate, e in oltre l’80% dei casi si rivelino efficaci strumenti euristici, lungi dal segnalare uno schema totalmente arbitrario imposto tramite la “socializzazione”, è il segno vivente di una storia naturale comune tra uomini e donne, millenaria e quotidiana, lungo la quale i due sessi, coesistendo e cooperando nelle loro differenze, hanno imparato a conoscersi e a ri-conoscersi.

Uomini e donne: diversi, insieme.
Le differenze tra i sessi non si limitano alle caratteristiche fisiche e a tendenze comportamentali molto ampie e generali come il già citato interesse prevalente per le cose o le persone, che si manifesta fin dai primissimi anni di vita e quindi è certamente estraneo a imposizioni di “costrutti” o “aspettative” sociali; ma spaziano praticamente in ogni aspetto dell’individuo, compresa la struttura cognitiva (ad es. negli uomini prevale l’attitudine per i numeri, nelle donne quella per le parole), le priorità e preferenze lavorative (ad es. gli uomini tendono a assumere rischi maggiori e puntare a compensi alti, le donne preferiscono occupazioni flessibili e part-time), l’assetto valoriale (mediamente gli uomini danno più importanza ai fatti e alle regole, le donne ad aiutare i membri della comunità in difficoltà o sofferenza, anche a scapito di fatti e regole: in nuce, l’atteggiamento paterno e quello materno).
Queste differenze si riflettono inevitabilmente nelle scelte e nei percorsi di vita più frequenti per i due sessi, a partire dal più tipico: gli uomini tendono a investire maggiormente sulla carriera, le donne sulla famiglia e la comunità. E come anche il “paradosso nordico” dimostra, laddove le condizioni sociali rendono realmente possibile per tutti, in modo paritario, realizzare e autodeterminare sé stessi secondo le proprie preferenze, uomini e donne tendono a fare scelte di vita che riflettono, piuttosto che contraddire, i tanto vituperati e demonizzati “ruoli di genere”, e pure a esprimere soddisfazione per la vita che così si sono costruiti. In conclusione quindi: non fidatevi dei woke e delle loro bizzarre teorie sui “generi”. I sessi esistono in natura; sono due, e non possono essercene di più; e sono diversi tra loro per natura, non per convenzione sociale. E più li si lascia in pace a coltivare le proprie peculiarità, meglio stanno. Insieme.