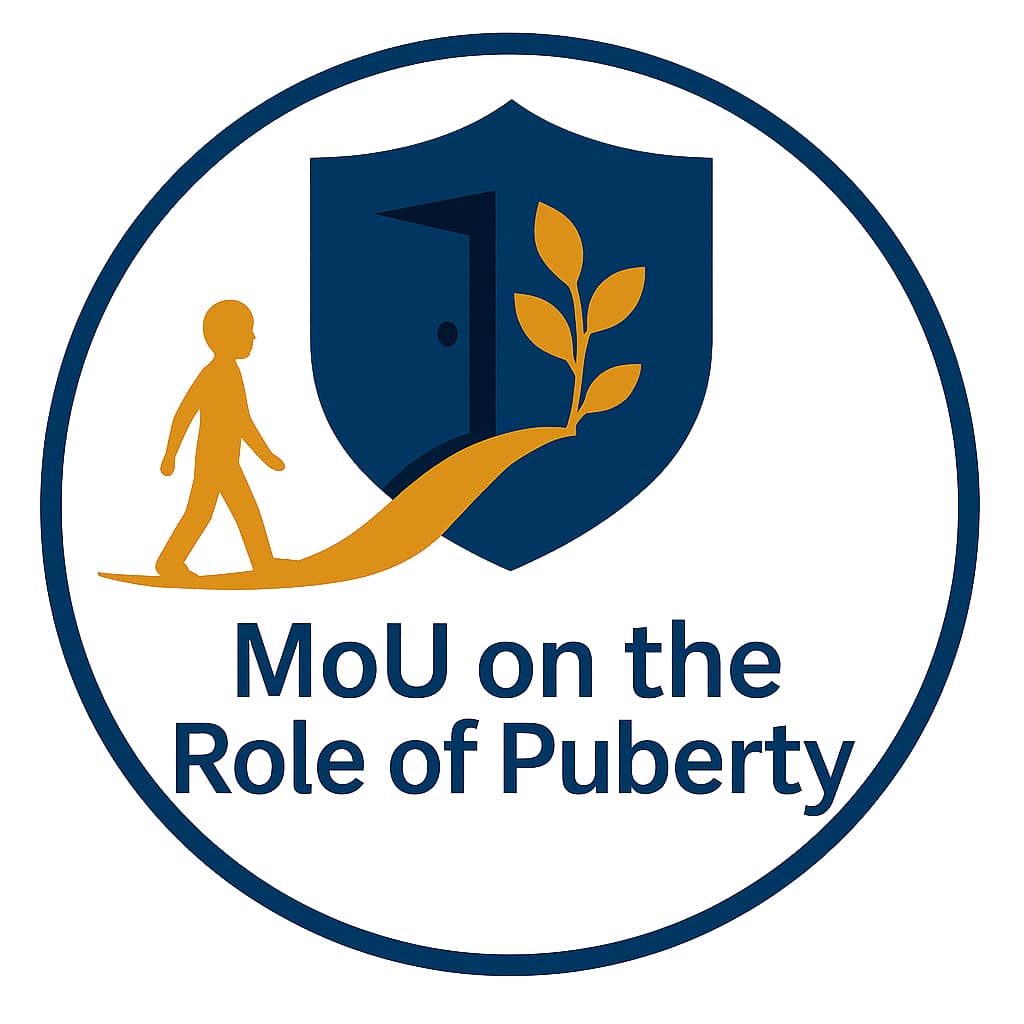Negli Stati Uniti si sta cominciando a guardare a distanza gli effetti del #MeToo sulla società e a vari livelli, compreso quello accademico, ci si sta accorgendo di un’anomalia di cui queste pagine parlano ormai da tempo: il dilagare delle false accuse e la loro connessione diretta con la moda della vittimizzazione. Diverse controversie nel mondo dei vip dello sport o dello spettacolo hanno evidenziato una tendenza preoccupante, che non risparmia l’Italia: personaggi di spicco sono accusati di aver strumentalizzato il movimento #MeToo e ciò che ne è seguito attraverso false affermazioni. I critici sostengono che molti inventino accuse false per favorire la propria carriera o i propri interessi personali. Sebbene le conseguenze legali di tali accuse possano richiedere anni per manifestarsi, il problema chiave è già evidente: la glorificazione sociale della vittimizzazione ha creato incentivi che, per alcuni, superano i rischi etici di formulare false accuse per ottenere ricompense sociali ed economiche. Nel mondo di oggi la vittimizzazione si traduce spesso in valore sociale e guadagno finanziario. Le ricompense per essere percepiti come vittime sono così allettanti che le false accuse sono sempre più comuni. Per coloro che sono disposti a rischiare, il potenziale guadagno è immenso. Un’accusa falsa e accolta potrebbe portare a risarcimenti in denaro, all’attenzione dei media o a un avanzamento di carriera. Anche quando le accuse non arrivano in tribunale, l’opinione pubblica spesso si stringe attorno agli accusatori, garantendo loro convalida sociale e prestigio.
Questa dinamica crea uno scenario rischio-beneficio che alcuni ritengono degno di essere sfruttato. Jussie Smollett, ad esempio, inscenò un crimine d’odio contro se stesso e ha dovuto affrontare conseguenze legali dopo essere stato scoperto. Il caso di Smollett solleva una questione etica: possono individui come lui assumersi tutta la responsabilità quando la società ha creato un sistema che incentiva il vittimismo? Per molti versi, la radice del problema risiede in una cultura che esalta le narrazioni delle vittime, senza riuscire a ritenere responsabili i falsi accusatori. Crystal Mangum accusò falsamente per violenza sessuale i membri della squadra di lacrosse della Duke University, causando gravi danni agli accusati. Il caso del Titolo IX che ha coinvolto la Virginia Tech ha rivelato come i pregiudizi di genere possano influenzare le indagini. Il processo per diffamazione di Amber Heard con Johnny Depp ha dimostrato le conseguenze di accuse false o esagerate. Aziz Ansari ha dovuto affrontare una reazione negativa dopo essere stato accusato di cattiva condotta derivante dal pentimento post-intimità di una 23enne. Ogni caso sottolinea come la cultura moderna amplifichi le accuse, spesso senza un’adeguata verifica.

False accuse e moda del vittimismo: un circuito che si autoalimenta.
Questi esempi rivelano un modello sociale. Quando le vittime vengono celebrate e i vincitori denigrati, il fascino del vittimismo diventa difficile da resistere. Gli incentivi legati all’essere percepiti come vittime sono così pervasivi che persino individui di grande successo possono essere tentati di adottare tale ruolo, indipendentemente dalla sua autenticità. In questo contesto, non sorprende che alcuni ricorrano a false accuse per ottenere vantaggi sociali o economici. Il mantra culturale del “credere a tutte le vittime” crea uno scenario in cui il primo ad accusare ottiene un vantaggio decisivo, indipendentemente dalla credibilità delle accuse. Ciò ha portato a una preoccupante mentalità da “corsa all’accusa”, in cui gli individui si affrettano a formulare accuse per assicurarsi una posizione di superiorità morale. Le false accuse diventano una strategia competitiva quando tutte le parti sono ugualmente innocenti, con conseguenze devastanti per i falsamente accusati. Le implicazioni vanno oltre i casi di alto profilo e si estendono alla vita di tutti i giorni. Sono molto frequenti i casi in cui qualcuna sorpresa a tradire il proprio partner accusa falsamente l’amante di violenza sessuale per evitare di essere ritenuta responsabile. Altri potrebbero sfruttare le app di incontri per prendere di mira individui con accuse inventate. Le controversie sull’affidamento della prole degenerano quasi sistematicamente in false accuse di comportamento inappropriato per escludere i padri dalle vite dei figli.
Per chi dà priorità all’etica rispetto al tornaconto personale, evitare anche solo l’apparenza di un comportamento scorretto può essere la migliore difesa. Un esempio è la “Regola di Mike Pence“, ispirata al Manifesto di Modesto del compianto Billy Graham. Questo principio sconsiglia le interazioni individuali con persone del sesso opposto per preservare l’integrità e prevenire situazioni in cui potrebbero sorgere false accuse. Sebbene tali precauzioni possano sembrare estreme, offrono una certa protezione in una cultura in cui le accuse possono cambiare la vita. Il dilemma etico che circonda l’incentivazione del vittimismo è profondo. Da un lato, credere a chi lo accusa è essenziale per affrontare le ingiustizie autentiche. Dall’altro, questa stessa narrazione culturale crea inavvertitamente opportunità di sfruttamento. Il vittimismo è ora così ampiamente ricompensato che la ricerca di vantaggi sociali ed economici spesso oscura l’importanza della verità e dell’integrità. L’etica della verità è sempre più preda dell’economia della menzogna. Questi problemi persisteranno finché la società premierà le narrazioni delle vittime senza distinguere tra affermazioni autentiche e false. Questo sistema favorisce le false accuse, minando al contempo la credibilità delle vere vittime. Per affrontare questo problema, la società deve bilanciare l’empatia per le vittime con l’impegno per l’equità, la ricerca delle prove e la responsabilità. Solo allora potremo smantellare gli incentivi che rendono le false accuse così attraenti.