Si è tenuto il tanto atteso e discusso evento di Yasmina Pani, Immanuel Casto & co., ospitato in corner dai Radicali Italiani a Roma, dopo la geniale trovata pubblicitaria (involontaria?) dell’annullamento, quattro giorni prima della data prevista, da parte del locale progressista Monk che in origine avrebbe dovuto ospitare l’evento. Delle implicazioni e dei retroscena di tale “scandalo” abbiamo già parlato (ad esempio qui). Vorrei proporre invece un commento sull’evento in sé, che è possibile visionare per intero qui. Anzitutto a partire dal sottotitolo descrittivo: “conversazioni sull’antisessismo”, che riflette il modo in cui l’evento era stato presentato e anticipato dagli organizzatori: a sentir loro, si sarebbe dovuto trattare di un’occasione di dialogo e confronto tra posizioni diverse, e non di relazioni versate ex cathedra addosso al pubblico. Occasione di cui si sente veramente una grande necessità: anche noi di LaFionda.com invitiamo costantemente diversi soggetti a dibattiti e confronti pubblici (di solito, senza ottenere risposta). Ed è per questo che anch’io attendevo l’evento con rosee aspettative. Ma, a ben vedere, di “conversazione” e dibattito c’è stato ben poco: si è trattato piuttosto di una serie di monologhi, peraltro non focalizzati su un unico problema – il che avrebbe dato l’idea del “confronto” tra diverse posizioni – ma ciascuno stretto sulla propria tematica, slegata da quelle altrui. Questa serie di monologhi è stata sì intervallata da spazi per interventi dal pubblico – e significativamente, dopo tutti gli interventi tranne quello di Fabio Nestola – e però anche questi interventi non sono stati altro che monologhi più piccoli inanellati nella serie, senza alcun tentativo di discussione dei (pochi) spunti critici.
Il primo relatore è stato, per procura, lo psicoterapeuta Giancarlo Di Maggio, che ha parlato di come si curano gli uomini violenti (ok, sì, accennando en passant al fatto che esiste pure la violenza femminile); ovviamente non sconfessando l’idea che la violenza maschile sia causata da fattori culturali (non sia mai), ma semplicemente dicendo che ci sono anche altri fattori concorrenti. Di Maggio chiarisce che se non parla di prevenzione della violenza, è solo perché non se ne occupa a livello professionale. Ma casomai qualcuno avesse frainteso che a ciò fosse sottintesa una critica all’idea di “prevenire la violenza di genere” mediante un’azione culturale, ecco poco dopo Yasmina a rassicurare in merito (corsivi nostri qui e nel seguito): «è chiaro che non si abbandona la prevenzione, non credo neanche che fosse quello che intende Giancarlo». E per fugare definitivamente ogni dubbio, dopo alcuni monologhetti dal pubblico arriva Casto a celebrare l’educazione sessuale-affettiva nelle scuole; certo, se intesa come «intervento sul problema culturale, diventa più controversa», ma non perché il legame causale dalla cultura dominante al crimine violento sia un falso ideologico, assolutamente no, bensì solo perché poi bisogna mettersi d’accordo su quale sia il problema culturale su cui intervenire: è che si insegna agli uomini ad essere violenti, o non piuttosto che si trasmette loro il senso del possesso della donna?… Quale che sia il problema culturale da combattere, pare essere il sottinteso, riguarda comunque solo gli uomini: la violenza femminile non è presente nel quadro, dai timidi accenni di Di Maggio è già totalmente svanita.
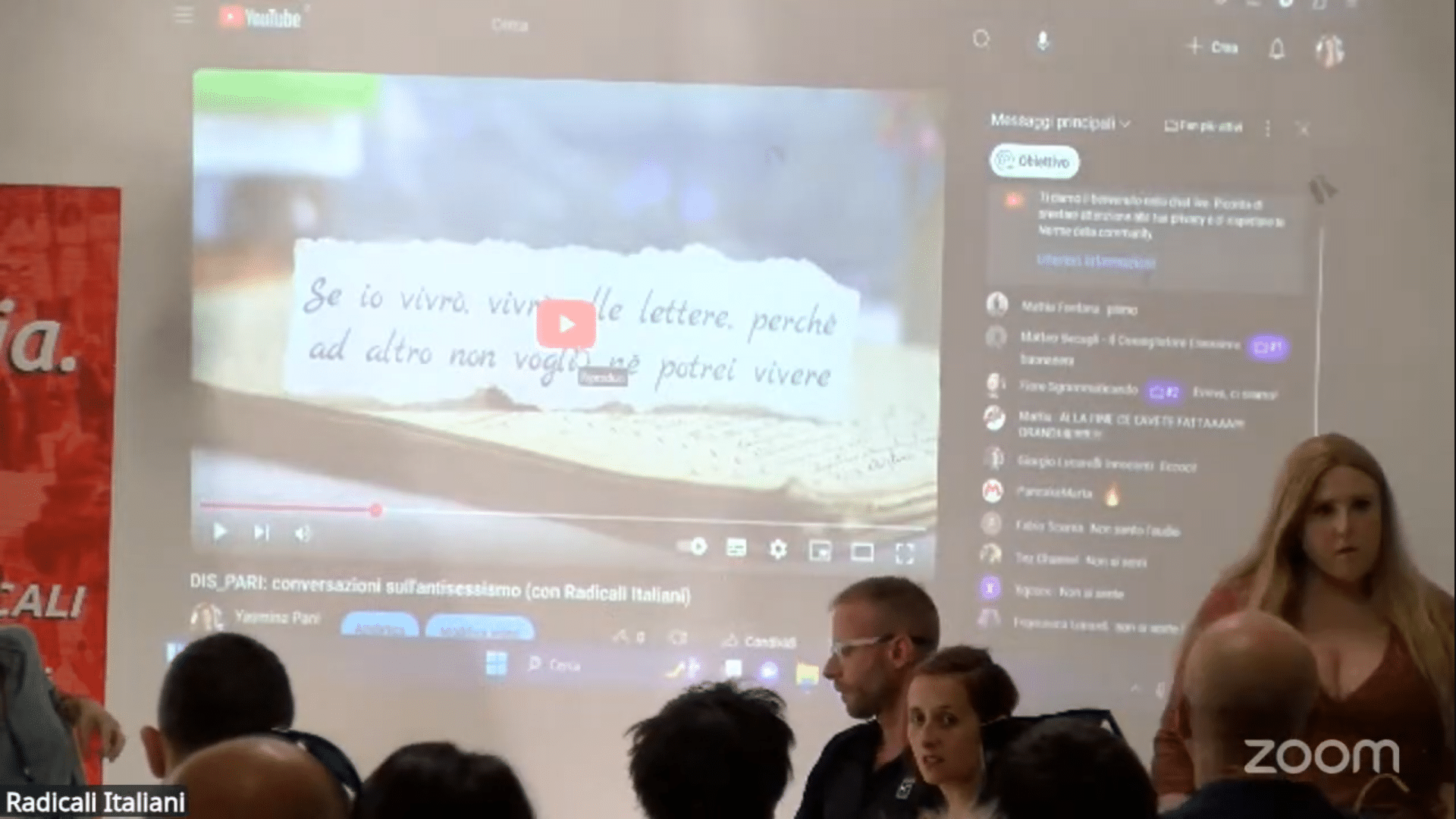
Una perfetta vetrina woke.
Segue un excursus un po’ frammentario condotto da uno degli organizzatori con la professoressa di filosofia Tiziana Lombardo. Questa è l’unica parte dell’evento che assomiglia vagamente a una “conversazione”, sebbene poi di fatto si tratti di un botta e risposta su alcuni input, sui quali i due “conversanti” vanno ciascuno per la propria tangente: 1) il patriarcato, che secondo l’organizzatore, in piena hybris marxista, identifica la sovrastruttura culturale di precise strutture socio-economiche, per la prof.sa Lombardo, pur con qualche sfumatura, è «fuori dal tempo e dallo spazio», trasversale a epoche e culture, una categoria metafisica fondamentale dell’umano; 2) la “normatività” del privilegio maschile (che viene ovviamente confermata senza essere discussa), cui la prof.sa Lombardi risponde iniziando una interessante digressione sulla storia della schiavitù in Haiti, che però non le fanno concludere; 3) le varie “forme” di lotta femminista e in particolare la misandria intrinseca al femminismo, che – indovinate un po’ – viene sconfessata: il femminismo non va considerato misandrico, implica l’organizzatore femminista, solo perché c’è qualche singola femminista che accidentalmente è misandrica. Capita, dice, che alcune femministe adottino «toni indubbiamente stigmatizzanti nei confronti del maschile, alcune anche dei maschi, ma del maschile, percepito come pienamente cittadino, pienamente dotato di agentività, mentre loro, spesso non lo erano, e in alcuni ambiti ancora le donne non lo sono»… insomma, se alcune – rare, rarissime! – femministe stigmatizzano “i maschi”, bisogna capirle, tutto sommato “i maschi” se lo sono meritato, togliendo “l’agentività” alle donne.
In conclusione, la prof.sa Lombardi si produce in un altro mega-spot pubblicitario all’obiettivo femminista-woke della rivoluzione culturale da attuarsi mediante la rieducazione di massa orientata a una determinata visione ideologica, e i termini usati sono precisamente quelli da noi individuati nella nostra genealogia della cultura woke (in “Malapianta”, cap. III, e in questa presentazione). L’intervento terapeutico, dice infatti la Lombardi, è «a valle, quando già c’è stato» : bisogna invece «mettere in campo degli strumenti che mi aiutino a prevenire certi comportamenti, ma devo usare un modello: che cos’è che è violenza … quello che non era violenza fino adesso, adesso è diventata violenza. Se non metto in discussione … se non faccio una critica di quello che io interpreto come violenza, e soprattutto se non metto in discussione il sistema economico … che non può che riprodurre sistemi alternativi di dominio». L’intervento successivo è quello del nostro Fabio Nestola sul quale – ci scuserà – non ci soffermiamo (ma vi invitiamo ad ascoltare per intero, da 1h50’ a 2h18’ circa), se non per sottolineare che si tratta di un intervento pulito, fattuale e incontrovertibile volto a denunciare il sessismo antimaschile strutturale nel diritto di famiglia, e le strategie più comuni utilizzate per aggirare le norme che dovrebbero garantire il diritto del minore a frequentare entrambi i genitori dopo una separazione. Come accennato più sopra, questo è l’unico intervento al seguito del quale non si dà spazio a interventi dal pubblico, ma si passa direttamente all’ultimo intervento, anche questo per procura (letto da Casto), un testo della scrittrice femminista Giorgia Antonelli.

Spazio al femminismo più becero.
La Antonelli chiude in bellezza, citando teoriche del femminismo intersezionale e misandrico tra le più radicali come Bell Hooks, Audre Lorde e Jessa Crispin, e inanellando perle di saggezza memorabili come: «moltissime donne, una volta raggiunto il potere, si accomodano in poltrone imbottite dagli uomini per gli uomini, e si inseriscono perfettamente nel solco della tradizione tipicamente patriarcale»: è il famigerato queen bee effect, che avevamo discusso qua, per il quale se una donna – sistemicamente oppressa e esclusa dalle posizioni di potere – una volta raggiunta una posizione di potere (e già qui, la logica…) si comporta esattamente come lo stereotipo dell’uomo di potere dipinto dalle femministe (prevaricatore, tossico eccetera), è comunque colpa degli uomini. Segue una citazione di Jessa Crispin, talmente moderata, dialogante e “antisessista buona” che perfino Casto, sconcertato, in due momenti interrompe la lettura chiedendosi “ma ho letto bene? Manca qualche parola?”. Merita citarlo estesamente: «Il mio femminismo non prevede un cambiamento per gradi che alla fine lascia tutto com’era, e anche peggio. È un fuoco purificatore. Chiedere a un sistema costruito con il preciso scopo di opprimere: ‘Ehm, per favore, smetteresti di opprimermi?’ è assurdo. L’unica azione che ha senso intraprendere è smantellare completamente quel sistema e sostituirlo con un altro. Ecco perché non mi posso associare a un femminismo … comodo, che non esige riflessioni né un vero cambiamento. Se il femminismo è universale, se è un carro su cui tutte le donne, e gli uomini, possono saltare, non fa per me». Casto qui si interrompe, ingenuamente domandandosi se non abbia saltato un “non”.
Ma il testo originale è proprio quello, e continua significativamente così: «Se il femminismo non è altro che un guadagno personale fatto passare per progresso politico, non fa per me. Se dichiarandomi femminista devo rassicurare che non sono arrabbiata, che non rappresento una minaccia, di certo il femminismo non fa per me. Io sono arrabbiata. E rappresento una minaccia». Antonelli infatti subito dopo rivendica la legittimità della “rabbia” e della necessità di “riappropriarsene”, e conclude con l’elencazione delle solite lamentele-leggende femministe ormai sbufalate mille volte, come l’emergenza “femminicidio” e “violenza di genere” (arriva a dire testualmente: «dati Istat fino al 2023 ci parlano di circa 110 donne uccise in media all’anno, una ogni due giorni», infatti un anno è composto di 220 giorni, no?), le «tutele legali davanti a una denuncia spesso insufficienti» (veramente questo vale per gli uomini falsamente accusati…), addirittura «un incremento della violenza sulle donne che è direttamente proporzionale alla maggiore libertà acquisita». Dopo questi fuochi d’artificio finali sarà ormai chiara la sostanza: un evento in cui l’ideologia woke più classica e becera ha spadroneggiato, con l’oppressione sistemica patriarcale millenaria e addirittura metafisica attuata dal “maschio” a svantaggio delle donne (e anche degli “elleggibbittì”, citati alcune volte in tal senso), che dev’essere “smantellata” attraverso una rivoluzione culturale radicale, i cui strumenti sono la “critica” dei modelli culturali egemoni e l’indottrinamento, a partire dalle scuole, di modelli alternativi.

La ragione e il torto.
Questa ideologia non solo non è stata messa in discussione, non ha incontrato alcun contraddittorio, ma è stata legittimata e anzi nobilitata dall’accostamento (totalmente casuale e arbitrario, non essendoci stato dibattito né confronto) con soggetti che appartengono alla critica di essa, e dalla trovata pubblicitaria della “censura preventiva”. Non possiamo fare a meno di chiederci: cui prodest? Questa insistenza nel volersi presentare come “in mezzo”, “i moderati”, “gli antisessisti”, nel dare voce a tutti acriticamente, quali interessi serve? Quali narrazioni neutralizza e quali agevola? Mettere tutti i fuochi d’artificio ideologici qui elencati sullo stesso piano e nello stesso calderone insieme a discorsi razionali, fattuali e concreti non serve a fare chiarezza, né a separare la farina dalla crusca: serve soltanto a confondere le idee, restituendo una pappa informe in cui tutto sommato tutto va bene, ogni tesi e ogni affermazione ha la stessa dignità di ogni altra, “volemose ‘bbene”, e quindi alla fine il potere – non quello del “maschio etero-cis”, ma quello dei potenti gruppi d’interesse che spingono determinate istanze ideologiche con fiumi di denaro e reti di influenza – deve avere campo libero, mentre chi vi si oppone ne esce, in sostanza, neutralizzato, dato che in fondo, hai visto?, ha avuto pure lui il permesso di dire la propria. No: ciò che è disperatamente necessario (e ciò in cui speravamo, puntualmente delusi) è un confronto reale, un dibattito vero, con il contraddittorio, e con il fine analitico di raggiungere una sintesi, su temi specifici, uno alla volta. Una procedura di vaglio razionale tramite il dialogo, in cui non ogni affermazione ha la stessa dignità di ogni altra, ma tutte possano essere messe in dubbio, contraddette, discusse e valutate, e sì, anche valutate negativamente, se all’analisi razionale proprio non reggono; e in cui chi dice sciocchezze alla fine può venire smascherato, e non semplicemente applaudito uguale a chiunque altro solo perché “l’antisessismo, non bisogna essere estremisti, volemose ‘bbene” eccetera.
Ricordandosi sempre che sono le tesi, le affermazioni, le idee a essere valutate, analizzate e eventualmente invalidate in questo processo, non le persone. Uno degli organizzatori, nell’introdurre l’incontro, ha detto: «non vogliamo che queste istanze così preziose e così sensibili possano essere usate per delegittimare aprioristicamente una parte che si sente nemica … noi siamo convinti che ciò che abbiamo in comune sia superiore a ciò che ci divide … non ci sarà chi ha ragione e chi ha torto». Ma caro il mio femminista, se tra tutti quelli che hanno parlato al vostro incontro, nessuno ha ragione e nessuno ha torto, siamo proprio messi male: costretti a navigare nel vuoto interstellare del totale arbitrio etico e intellettuale, dove ogni dissenso diventa flatus vocis, perché alla fine tanto nessuno ha mai ragione e nessuno ha mai torto, e vale tutto e il suo contrario allo stesso modo, e (per dire) chi dice che i “femminicidi” l’ultimo anno sono stati 200 (uno al giorno, quindi, no?) è da mettere sullo stesso piano di chi dice che sono stati 30. C’è decisamente chi ha torto e chi ha ragione; e proprio perché queste istanze sono preziose e sensibili, è necessario poter decidere tra le due cose. Nessuno vuole “delegittimare aprioristicamente” una parte: ma è perfettamente legittimo delegittimare una parte a posteriori, tramite il confronto, il contraddittorio e il vaglio razionale, appunto. Sicuramente ciò che abbiamo in comune sarà superiore a ciò che ci divide: ma questo non esime nessuno dalla possibilità di vedersi criticata e magari anche smentita la propria credenza o la propria ideologia. E anzi questo processo, quello che ha realmente mandato avanti l’impresa umana nel corso della sua storia, è l’unico mediante il quale “ciò che abbiamo in comune” può essere realmente visto e raggiunto al di là di “ciò che ci divide”.


